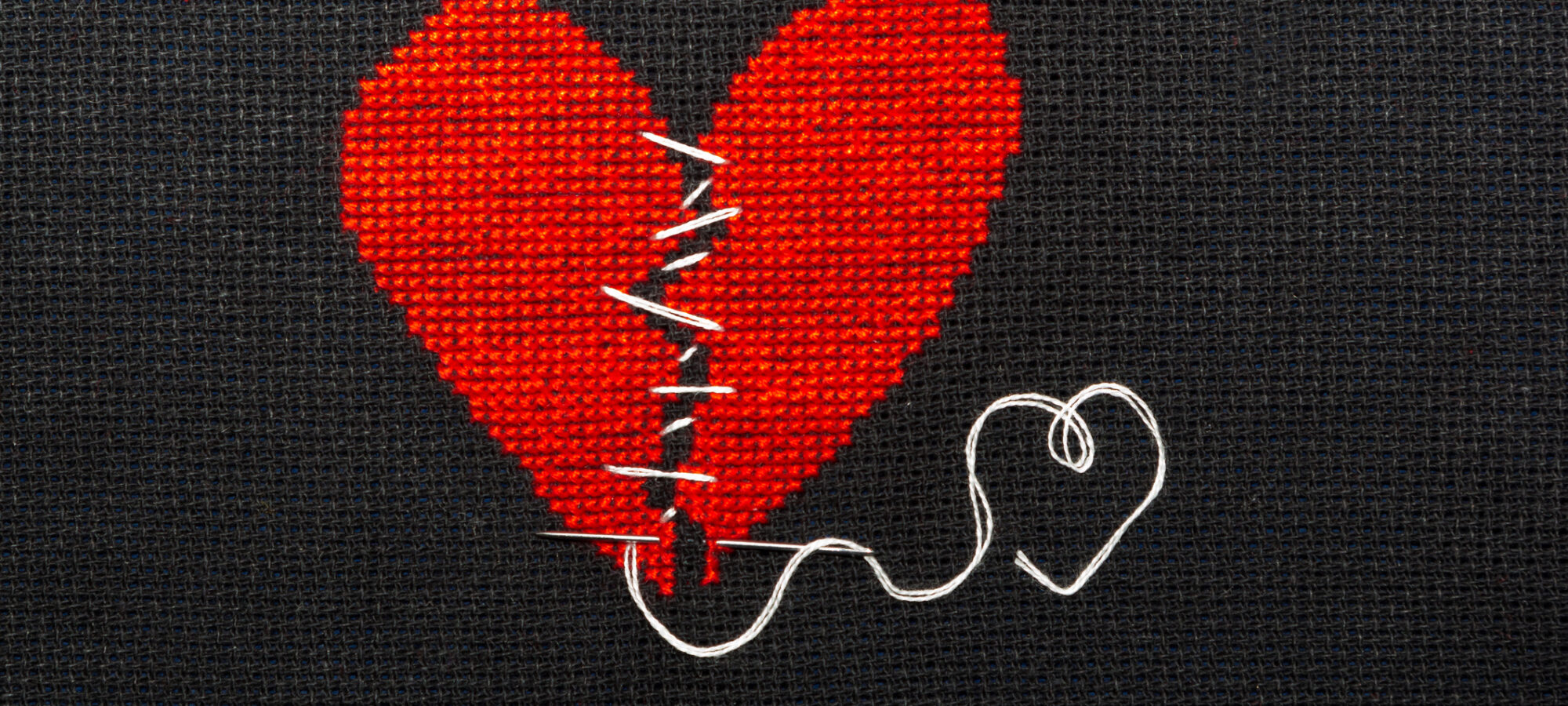
|
|
Il perdono richiede, come ogni atto umano, una sorta di «allenamento» pratico e mentale, una ripetizione continua perché possa divenire sempre più possibile ed efficace. Più che un gesto, esso è un percorso, un cammino, che coinvolge il tempo nelle sue modalità dinamiche: a partire dal presente, lavora sul passato, per aprirsi al futuro. Quando invece ci si rifiuta di perdonare, ci si fossilizza sull’evento passato, come se il tempo si fosse fermato; da qui la sensazione di morte interiore, di aridità e di isolamento. Perdonare significa iniziare qualcosa, compiere negli anni una serie di passi, esercizi e attività capaci di rivisitare ed educare il proprio vissuto; questo lavoro, non facile, può portare nuovi colori e mostrare nuove possibilità in chi lo coltiva. In quanto atto anche psicologico, il perdono può essere favorito o ostacolato da alcuni elementi basilari, di cui si deve tener conto. Si è visto come il temperamento e la personalità possano incidere sul processo del perdono[1]; dal punto di vista affettivo si possono ulteriormente evidenziare alcuni stati d’animo che possono bloccare tale processo, come il rancore e il risentimento: essi vanno riconosciuti e contrastati, perché fonte di avvelenamento interiore e punizione di sé. Ve ne sono invece altri che risultano di indubbio aiuto: l’empatia e la gratitudine.
A differenza delle emozioni, che sono reazioni primarie, antecedenti una possibile valutazione cognitiva e morale, queste quattro modalità sono elaborazioni secondarie, complesse, che riuniscono elementi differenti: gli affetti, la memoria, la conoscenza, l’immaginazione e la volontà. Tale complessità consente di rileggerle, di evidenziarne le caratteristiche fondamentali, e soprattutto di educarle, portando a esiti differenti.
Possibili ostacoli affettivi al perdono
Il rancore e laruminazione portano il soggetto a ripiegarsi su di sé, occupando la mente, l’immaginazione, il pensiero e gli affetti attorno alla ferita ricevuta, impedendo di volgersi ad altri interessi e occupazioni. È come rivedere da soli, nella propria mente, continuamente il medesimo filmato, esacerbando l’animo, isolandosi e amareggiandosi sempre più. È il circolo vizioso del rancore, una sorta di «delitto e castigo interiore» in cui il soggetto, credendo di punire l’altro, in realtà punisce se stesso in modo sempre più crudele. E questo ha una ricaduta anche sulla salute fisica.
Nel processo proprio del risentimento non si tiene conto che l’accrescimento dell’astio è opera della fantasia e dell’immaginazione, soprattutto della maniera di considerare l’avversario in termini di totale malvagità, attribuendogli la piena e deliberata intenzione di compiere il male, senza attenuanti. Dalle ricerche emerse sembra tuttavia che le cose non stiano quasi mai in questi termini, perché quanto suggerito dal rancore, pur comprensibile, è una costruzione accentuata.
È infatti risaputo che, anche quando risultano chiari i ruoli di colpevole e di vittima, la percezione dell’accaduto rimane sempre differente. Quando si chiede a una persona di raccontare un episodio in cui aveva avuto il ruolo di offensore e un altro in cui era vittima, si nota una grande disparità di vedute, in termini di emozioni provate, di valutazione della gravità del gesto, delle sue possibili conseguenze, ma soprattutto in termini di consapevolezza e responsabilità morale. L’offensore tende a essere piuttosto indulgente con se stesso, porta attenuanti circa la volontarietà di quanto accaduto, al contrario della vittima. Prendere consapevolezza di questa diversità di valutazioni è fondamentale per correggere la propria percezione della realtà, che viene per lo più elaborata spontaneamente, in base alle emozioni suscitate, che sono univoche e caratterizzate da potenti filtri soggettivi.
Il passaggio, difficile ma indispensabile, per rileggere quanto accaduto è di accettarne la complessità, il che significa che la situazione non può essere giudicata unicamente in base a categorie emotive dicotomiche e onnicomprensive (giusto/sbagliato, buono/cattivo, responsabile/innocente). L’incapacità, in sede di giudizio, di cogliere le possibili sfumature (sempre presenti in ogni accadimento) e di entrare nella complessità si traduce in un approccio alla realtà in termini di splitting, di separazione netta tra il bene e il male, considerando l’offensore come totalmente cattivo (all bad), senza riconoscere possibili attenuanti o altri elementi in gioco. È il meccanismo alla base dell’odio, che porta a svalutare l’altro fino a considerarlo non umano, un «mostro» indegno di vivere: «Le storie di odio hanno una struttura semplificata anche perché prevedono solo due ruoli stabili, quello del perpetratore da odiare e quello della vittima che odia»[2]. E così il male tende a perpetuarsi.
Dal punto di vista psicologico, lo splitting viene considerato una difesa primitiva («primitiva» dal punto di vista dello sviluppo psichico): la semplificazione fornisce una facile descrizione di quanto accaduto, perché individua una causa onnicomprensiva. È legata al bisogno di capire: più la motivazione è semplice, chiara e globale, più risulta soddisfacente in termini di attribuzione di responsabilità. I meccanismi del risentimento e dell’odio sono alimentati da questo tipo di approccio cognitivo, dall’esigenza di sapere e capire, che tuttavia, in mancanza di informazioni adeguate, rischiano di plasmare il mondo in base ai propri vissuti emotivi.
In tal modo si raffigura l’altro con il colore delle proprie ferite — mediante quel meccanismo noto come «proiezione» —, un colore cupo, di morte. Considerati sotto l’aspetto del dinamismo e della salute psichica, perdono e rancore si presentano come del tutto antitetici: «Il perdono è un principio di mobilità e fluidità, a differenza del rancore che è un principio di staticità e rigidità (caratteristiche che accompagnano spesso la sofferenza psichica) e un processo di umanizzazione, poiché spinge a fare i conti con i propri limiti e la propria vulnerabilità, è un principio di libertà»[3].
Modificare i pensieri automatici è difficile, ma consente di cogliere la complessità del reale, rivisitando i criteri di giudizio, e ponendo termine al meccanismo di autolesionismo proprio della ruminazione interiore. Entrare nella complessità non significa giustificare l’altro, né sminuire la propria sofferenza, o far finta di nulla. La difficoltà di rendere ragione della complessità consiste anzitutto nel tenere insieme i possibili e molteplici aspetti dell’accaduto. Per fare ciò, si richiede di incentivare un atteggiamento affettivamente uguale e contrario al rancore, l’empatia.
I risultati delle ricerche, soprattutto circa i conflitti relazionali che avvengono in famiglia, mostrano a questo riguardo un’altra cosa interessante, e cioè che quanto meno ci si sente colpevoli tanto più si tende ad attribuire una responsabilità unilaterale alle mancanze altrui. Come si è visto, la mancata esperienza del perdono porta a una esagerata colpevolizzazione: «Le persone che tendono con più facilità a incolpare gli altri hanno difficoltà a empatizzare, e sono più propense a considerare se stesse come innocenti»[4]. Perdono e rabbia non sono incompatibili, ma con il perdono si manifesta anche il desiderio di vivere diversamente sia l’avvenimento, sia soprattutto la rappresentazione interna della persona che ci ha fatto del male.
Il risentimento
Uno degli effetti principali del rancore, il risentimento, è stato esplorato anzitutto in filosofia, in particolare da Max Scheler nella sua opera Il risentimento nella edificazione delle morali. In questo libro egli riconosce due caratteristiche essenziali al risentimento: a) la persona avvelena se stessa, continuando a ritornare su pensieri ed avvenimenti spiacevoli; b) non si confronta mai, né riconosce il proprio sentire. Il risentimento, come la coazione a ripetere di Freud, nasce da un conflitto profondo, riproponendo un copione già noto: quanto più viene ripetuto, tanto più aumenta il malessere, l’autoavvelenamento, senza che il processo possa conoscere una fine. Si tratta di qualcosa di virtualmente infinito, che porta la persona a incattivirsi sempre più: «I moti e gli affetti che in primo luogo si offrono all’osservazione sono: senso e impulso di vendetta, odio, cattiveria, invidia, gelosia, malizia»[5].
L’analisi di Scheler trova una perfetta rispondenza in sede analitica. L. Kancyper riporta in proposito la descrizione di un paziente: «Il risentimento è come cercare di premere l’acceleratore di un’auto incagliata nel fango. Quanto più si accelera, tanto più l’auto affonda nel fango e meno si muove… Si è come in un vicolo cieco. Mi viene un gioco di parole: se sono risentito, invece di sentire risento, sento di nuovo cose vecchie, ormai stantie, e passo la mia vita così»[6]. È una descrizione che esprime in modo molto efficace l’autopunizione di siffatti atteggiamenti: più ci si arrovella per quanto accaduto, più ci si sente amareggiati e astiosi, ossessionati dal pensiero di vendicarsi per il torto subìto, avvertendo un crescente avvelenamento di sé. Così si rimane avvinghiati, prigionieri dell’evento, che continua a rivivere al proprio interno, alimentando la coazione a ripetere. Al termine di questo processo la persona non ricorda più, ma rielabora, ripresentandolo, il proprio conflitto irrisolto, senza trovare via d’uscita, come la macchina che accelera nel fango rievocata dal paziente di Kancyper.
Tale modalità è, per Freud, uno degli ostacoli più forti nei confronti di una possibile interpretazione e successiva cura di un trauma, perché questo rimane come congelato, senza presente né futuro, del tutto ancorato al passato, un passato deformato dai filtri della sofferenza inconscia. In questo modo, come osserva Ricœur, «il soggetto ripete i suoi fantasmi anziché elaborarli; cosa ancora più grave, li lascia passare all’atto in gesti che minacciano lui stesso e gli altri»[7]. Per la persona succube del risentimento, il tempo si è fermato: è diventata affettivamente e psichicamente morta, fossilizzata su un evento anch’esso morto, che l’ha interamente pervasa, impedendole di vedere, sentire, notare altro: «Il soggetto risentito resta prigioniero nell’atemporalità, suo malgrado incapace di perdonare. Resta come coinvolto in una dimensione di tortura, quella del “lavare l’onta”, del “saldare i conti” per le offese subite, ma paga un prezzo molto elevato, cioè l’ibernazione degli affetti»[8]. In questo modo egli rimane bloccato e ripete, come un disco rotto, la medesima storia.
L’odio
Il risentimento, in quanto rancore sedimentato, sceso in profondità, può con più facilità portare all’odio. A differenza della rabbia, che è concreta e individuale, legata a un avvenimento preciso, l’odio è generalizzato, indirizzato alla persona o a una categoria nella sua totalità. Una seconda differenza tra l’odio e la rabbia è che quest’ultima è per lo più legata a un dolore che con il tempo tende a scomparire, cosa che invece non accade nell’odio[9]. La rabbia infine cerca giustizia per un torto subìto, l’odio vuole la distruzione dell’altro, senza comunque trovare soddisfazione adeguata: «Le storie d’odio tendono ad avere una struttura più semplice di quelle d’amore, che sono caratterizzate da un’ampia varietà di tipi di ruoli. Le storie d’odio hanno di solito due ruoli quasi stabili: il colpevole, che deve essere odiato, e la vittima, che deve odiare. Come ha fatto notare Baumeister, le persone che fanno del male si considerano, in genere, vittime di coloro che perseguitano! Le storie d’odio crescono soprattutto a livello sociale, attraverso la propaganda: ciò significa che l’odio è, in buona parte, appreso»[10].
Il fatto che l’odio sia una forma di fuga dalla complessità e dall’ambiguità proprie della realtà per costruirsi un mondo di fantasia malata, troverebbe conferma nei ripetuti gesti di violenza collettiva riportati dalla cronaca. Gli autori della strage al liceo di Columbine — per citare uno degli esempi più noti —, avvenuta a Denver il 20 aprile 1999, erano due studenti timidi, introversi e appartati, con scarse relazioni sociali, che trascorrevano il tempo libero a fantasticare sul modo di vendicarsi per presunti torti subìti. Altre manifestazioni di violenza esplosiva simili mostrano questa combinazione di isolamento sociale, fuga nella fantasia, prevalenza delle valutazioni emotive, morbosa attrazione verso la violenza distruttiva.
Nell’odio è presente un aspetto cognitivo, il desiderio di far capire all’altro l’entità della sofferenza subìta, e l’odio risulta più accentuato quando è rivolto a una persona estranea. Ciò confermerebbe la sua componente immaginativa, perché, a differenza di un conoscente o di un familiare, vengono con più facilità a mancare informazioni essenziali, sostituite dalle emozioni suscitate.
L’odio non porta mai ai risultati sperati ma assomma dolore a dolore, distruggendo chi lo prova. Primo Levi, rievocando la vicenda di P. Améry — come lui scampato ad Auschwitz, ma intenzionato a vendicarsi, rendendo colpo su colpo — e la sua tragica conclusione, commentava: «Chi “fa a pugni” col mondo intero ritrova la sua dignità, ma la paga ad un prezzo altissimo, perché è sicuro di venire sconfitto»[11].
Per uscire da questa gabbia, si è chiamati a operare, come direbbe Freud, «il lavoro del lutto», lasciando andare quanto è accaduto; ciò è indispensabile per rileggerlo sotto nuova forma, e ricominciare a vivere. È il primo passo verso il perdono, «lo sforzo di raccontare altrimenti e dal punto di vista dell’altro gli eventi fondatori dell’esperienza personale e comunitaria»[12]. Un tale approccio, certamente faticoso, svincola da facili semplificazioni e apre a una possibile comprensione dell’altro.
Il primo a beneficiarne è la persona stessa che lo compie. Spezzare il meccanismo del risentimento può interrompere la macerazione interiore e aprire la porta del proprio animo ad altre componenti affettive e cognitive: il soggetto inizia ad avvertire un senso di pacificazione interiore, smette di essere ossessionato, e può finalmente investire le sue energie, i pensieri, i sentimenti su altro[13].
Possibili aiuti affettivi al perdono: empatia e gratitudine
L’empatia, come il risentimento, è stata studiata dalla filosofia prima che dalla psicologia: è la capacità di provare i medesimi sentimenti dell’altro, unita al desiderio di conoscere un mondo differente dal proprio.
Nell’antichità classica, essa trova un posto privilegiato nei dilemmi propri della tragedia. In queste situazioni viene caratterizzata, in linea con quanto osservato sopra, come una modalità anzitutto cognitiva, come flessibilità, condizione di accesso alla complessità della situazione: nella flessibilità i sensi restano attenti e l’animo pronto a riconoscere ciò che è meglio.
Sofocle, nell’Antigone, mostra questa caratteristica fondamentale dell’empatia mediante il personaggio di Èmone, secondo il quale l’incapacità di ascolto e di dialogo, propri di un cuore indurito, nascondono una povertà interiore: «Chi ritiene di avere lui soltanto il senno oppure una facondia, un’anima preclusa ad altri, se lo smonti e guardi dentro, c’è il vuoto». La flessibilità rende invece la persona più forte e maggiormente capace di affrontare le difficoltà della vita: «Presso i torrenti, quelle piante che, percosse, si piegano cedendo, salvano i rami, e quelle che resistono sono schiantate fin dalle radici. Così chi tiene le scotte ben tese senza mollare, rovescia la nave e naviga coi banchi capovolti»[14]. Questa capacità consente inoltre di imparare qualcosa dalle esperienze vissute, anche da quelle negative, e di vivere diversamente i dilemmi futuri, guardando ad essi con speranza e libertà, accogliendo la fragilità — propria e dell’altro — e spezzando il circolo vizioso del risentimento.
L’insegnamento etico di Sofocle viene ripreso e approfondito in sede filosofica da Aristotele, il quale reca l’esempio dei buoni architetti di Lesbo, che usavano un regolo di piombo non rigido, capace di adattarsi alla forma della pietra su cui costruire, così da poter decidere ciò che era meglio nel caso specifico[15]. L’empatia consente di riconoscere la complessità della situazione e delle parti in gioco, superando le semplificazioni e i riduzionismi: si tratta di un approccio faticoso, perché richiede di rivedere le proprie posizioni, ma che consente di apprezzare la ricchezza della vita, aprendo alla speranza. A differenza dell’odio, l’empatia si mostra più vicina alla verità, perché capace di differenziare.
Questa caratteristica complessa dell’empatia, indispensabile per un approccio autentico alla realtà dell’altro, viene ripresa nella filosofia contemporanea. Per Husserl, essa consente di fare «esperienza dell’estraneo», inteso come qualcosa di non riconducibile al soggetto, è la condizione per riconoscere la diversità, e accedere così al reale[16]. M. Scheler preferisce invece usare il termine «sim-patia», in cui non ci si limita solo a conoscere l’altro, ma soprattutto se ne condividono gli affetti.
La versione «simpatica» dell’empatia viene fatta propria dalla prospettiva psicologica, secondo la quale si può parlare di comprensione solo quando si è in grado di riconoscere e apprezzare gli stati d’animo dell’altro, di immedesimarsi con esso[17]. L’empatia in questa sede, oltre a quanto già notato (in particolare circa la flessibilità e la capacità di apprezzare la diversità), è indice di una buona salute psichica della persona: essa mostra infatti la capacità di vivere relazioni profonde e stabili, senza essere turbati dalla complessità, dai limiti e dalla presenza di un orizzonte di pensiero differente dal proprio. È anche segno di una buona struttura della personalità, in quanto capace di superare l’approccio «primitivo» dello splitting, notando le sfumature.
All’empatia è inoltre collegato un altro sentimento proprio di una elevata maturità cognitiva, e ugualmente essenziale per il perdono: l’umiltà, la conoscenza realistica dei propri limiti e delle proprie lacune (in termini conoscitivi e di scelte compiute). Applicata alle relazioni e al vissuto, essa è la consapevolezza di essere incapaci di cogliere un’intera vicenda e la situazione interiore dei protagonisti. È indice anche di una concreta stima di sé, perché non si ha paura di riconoscere eventuali proprie mancanze e difetti.
Umiltà viene da una parola latina, humus, che indica letteralmente la conoscenza della «terra» che caratterizza l’uomo e gli permette di «radicarsi», di vivere in profondità, di accogliere i limiti e la fragilità come elementi essenziali della verità di se stesso. Essa è anche legata alla consapevolezza di un dono ricevuto, senza proprio merito, senza perciò sentirsi superiori agli altri. Per questo l’umiltà è alla radice della gratitudine e del perdono: «L’umiltà è orientata agli altri, non a se stessi. Essendo orientata agli altri, la persona umile è grata di ciò che gli altri hanno fatto. È grata a Dio, ai genitori, agli amici, ai sostenitori»[18].
Un altro atteggiamento di fondamentale aiuto per iniziare un cammino di perdono è il senso di gratitudine. Essere grati significa esplicitare ciò che si vive interiormente di fronte a un beneficio ricevuto. Quando questo viene compiuto, ci si appropria di quel bene nella maniera più piena; l’atto di ringraziare si traduce in gioia e soddisfazione interiore, come osserva Clive Staples Lewis: «Amiamo lodare ciò che apprezziamo, perché la lode non soltanto esprime la gioia, ma la completa: è il suo compimento. Non è solo per questione di complimenti che gli amanti continuano a dirsi quanto siano belli; il diletto è incompleto finché non viene espresso»[19]. Essere grati aiuta inoltre ad affrontare situazioni difficili e a mantenersi in buona salute anche dal punto di vista psicologico e mentale. C’è infatti un evidente collegamento tra questo tipo di atteggiamento e la contentezza di vivere: «Più le persone riconoscono di essere grate, più esprimono soddisfazione nella loro vita […]. Le persone grate tendono ad essere felici»[20].
Per questo un approccio alla vita improntato alla gratitudine può diventare un efficace antidoto alla ruminazione interiore propria della depressione: il senso di gratitudine presenta infatti un andamento e una crescita inversamente proporzionali agli atteggiamenti propri del risentimento, dell’invidia, dell’autocommiserazione e del ripiegamento su di sé[21].
La gratitudine può con più facilità aprire al perdono, perché è antitetica ai sentimenti negativi propri della memoria negativa, come il risentimento e il rancore, che, come si è visto, sono di grande ostacolo al perdono. In altre parole, gratitudine e rancore sono tra loro incompatibili: l’accoglienza dell’uno comporta l’assenza dell’altro.
Aprirsi al perdono
Si è più volte osservato come il perdono sia un atto che coinvolge aspetti molteplici della persona: cognitivo, affettivo ed eventualmente anche relazionale. Esso non è mai un gesto magico capace di dissolvere il male ricevuto: richiede una sorta di guarigione della memoria, di confronto con la complessità e il mistero dell’altro, ben diverso dal tentativo di giustificazione o razionalizzazione di quanto accaduto.
Nello stesso tempo, esso è indispensabile per poter vivere; in caso contrario, l’accaduto rimane non più rivisitabile, anticipando il «definitivo» proprio della morte, come accade nel risentimento. Concedersi la possibilità di un’altra lettura è salutare per se stessi, come riconosce Etty Hillesum di fronte alla propria situazione di reclusa nel lager: «Se noi abbandoniamo al loro destino i duri fatti che dobbiamo irrevocabilmente affrontare — se non li ospitiamo nelle nostre teste e nei nostri cuori, per farli decantare e farli diventare fattori di crescita e di comprensione —, allora non siamo una generazione vitale»[22].
Se il perdono viene considerato anzitutto come uno stato interiore, il suo punto di arrivo, dal punto di vista psicologico, è di sostituire con sentimenti positivi la negatività provata nei confronti dell’offensore e della situazione di sofferenza, passando dalla contrapposizione all’integrazione tra loro, fino alla prevalenza dei sentimenti positivi.
Tale passaggio è possibile perché questi sentimenti avversi non sono primari, come le emozioni (ad esempio, la paura), ma una risonanza finale, variegata e complessa, della valutazione dell’accadimento compiuta dal soggetto. Nel momento in cui vengono esplorati, si scopre che il rancore, il risentimento e l’odio sono spesso la copertura di altre sensazioni basilari, ritenute inaccettabili dal soggetto e usate perciò in forma difensiva, ma regressiva, impedendo cioè di affrontare in maniera più matura ed equilibrata la complessità e ricchezza di interpretazioni possibili: «Le persone possono essere spaventate dalla propria rabbia o vergognarsi della propria paura o aver imparato che la tristezza è inaccettabile. La ruminazione si verifica quando è presente una rabbia secondaria che copre un’emozione primaria adattiva di tristezza»[23]. Questi atteggiamenti possono anche avere una seconda funzione, di tipo simbolico, per dominare l’altro; la tristezza interiore, per esempio, può diventare un modo manipolativo di far sentire in colpa, o suscitare compassione, ricavando vantaggi da quanto accaduto.
Va anche messo in conto che prendere contatto con i sentimenti più profondi comporta un’esperienza di perdita, di lutto, perché si deve abbandonare qualcosa cui si era fortemente affezionati: fare verità di tutto ciò implica un punto di non ritorno nei confronti del passato, per entrare nella realtà dell’oggi e aprirsi a un possibile differente domani.
Poter dare spazio a questi atteggiamenti positivi è indispensabile per tornare a vivere. Smettere di tormentarsi è il primo segno che si sta perdonando, con risvolti benefici anche sulla salute fisica del soggetto.
Copyright © La Civiltà Cattolica 2015
Riproduzione riservata
[1]. Cfr G. Cucci, «Il perdono, un atto difficile ma necessario», in Civ. Catt. 2015 I 142-156. Per un approfondimento della tematica, cfr Id., P come perdono, Assisi (Pg), Cittadella, 2011.
[2]. M. Ravenna, Odiare, Bologna, il Mulino, 2009, 58.
[3]. A. Ceccarelli – E. Molinari, «Il processo del perdono: aspetti psicologici», in www.rivistadipsicologiaclinica.it/italiano/numero3_07/Molinari_Ceccarelli.htm, 5.
[4]. J. Exile – R. Baumeister, «Expressing Forgiveness and Repentance: Benefits and Barriers», in M. E. McCullough – K. I. Pargament – C. E. Thoresen (eds), Forgiveness: Theory, Research and Practice, New York, Guilford, 2000, 141; cfr G. Cucci, «Il perdono, un atto difficile ma necessario», cit., 154-156.
[5]. M. Scheler, Il risentimento nella edificazione delle morali, Milano, Vita e Pensiero, 1975, 31.
[6]. L. Kancyper, Il risentimento e il rimorso. Uno studio psicoanalitico, Milano, FrancoAngeli, 2003, 22.
[7] . P. Ricœur, «Se l’identità è un’opinione», in la Repubblica, 9 agosto 2004.
[8] . L. Kancyper, Il risentimento e il rimorso…, cit., 22.
[9] . Cfr Aristotele, Retorica, II, 4, Bari, Laterza, 1983.
[10]. R. J. Sternberg, «Capire e combattere l’odio», in Id. (ed.), Psicologia dell’odio. Conoscerlo per superarlo, Trento, Erickson, 2007, 50; cfr R. F. Baumeister, Evil: Inside human violence and cruelty, New York, Freeman, 1999.
[11]. P. Levi, I sommersi e i salvati, Torino, Einaudi, 1994, 110.
[12]. P. Ricœur, «Il perdono può guarire?», in Hermeneutica (n.s.) 5 (1998) 160.
[13]. Cfr R. F. Baumeister – J. Exline – K. L. Sommer, «The victim role, grudge theory, and two dimensions of forgiveness», in E. L. Worthington Jr. (ed.), Dimensions of forgiveness: Psychological research and theological perspectives, Philadelphia, Templeton Foundation Press, 1998, 79-106.
[14]. Sofocle, Antigone, vv. 708-710; 712-717, in Id., Tutte le tragedie, Roma, Newton & Compton, 2000.
[15]. Cfr Aristotele, Etica Nicomachea, 1137 b 30-32, Milano, Rizzoli, 1996.
[16]. Cfr E. Husserl, Meditazioni cartesiane, Milano, Bompiani, 1989, 115.
[17]. Cfr M. Scheler, Essenza e forma della simpatia, Roma, Città Nuova, 1980, 69; K. Jaspers, Psicopatologia generale, Roma, Il Pensiero Scientifico, 1964, 330; S. Bonino – A. Lo Coco – F. Tani, Empatia. I processi di condivisione delle emozioni, Firenze, Giunti, 1998, 12 s.
[18]. E. Worthington Jr., L’arte del perdono, Milano, Eco, 2003, 112.
[19]. C. S. Lewis, Reflections on the Psalms, New York, Harcourt Brace, 1958, 95 (in it.: I Salmi, Torino, Lindau, 2014, 128).
[20]. M. McCullough – R. Emmons (eds), The Psychology of Gratitude, New York, Oxford University Press, 2004, 169/172. Per un approfondimento, cfr G. Cucci, «La gratitudine, radice del ben-essere», in Civ. Catt. 2008 IV 466-473.
[21]. Cfr M. R. Hagerty, «Social comparison of income in one’s community: Evidence from national surveys of income and happiness», in Journal of Personality and Social Psychology 78 (2000) 764-771; R. Ingram, «Self-focused attention in clinical disorders. Review and a conceptual model», in Psychological Bulletin 107 (1990) 156-176.
[22]. E. Hillesum, Lettere 1942-1943, Milano, Adelphi, 1998, 45.
[23]. E. Giusti – B. Corte, La terapia del per-dono. Dal risentimento alla riconciliazione, Roma, Sovera, 2009, 207.








