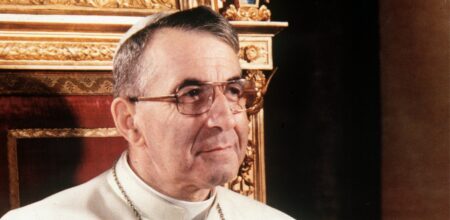|
|
Nei primi secoli il cristianesimo si è diffuso in un mondo completamente pervaso dalla religione, sia nella sfera privata sia in quella pubblica. Non c’era gesto o azione che non fosse accompagnato da un atto religioso, ma soprattutto non c’era luogo, a cominciare dagli astri, che non fosse abitato da qualche divinità.

Il sacrificio dei suovetaurilia (Museo del Louvre).
Il sole, la luna, le costellazioni erano considerati esseri divini. Quanto alle cose della Terra, sorgenti, fiumi, mari, monti, boschi, tutto portava l’impronta di un dio, sia pure di rango inferiore. Anche la sfera umana, fatta di emozioni, sentimenti, paure e speranze, era popolata da divinità, che con i loro miti potevano essere di aiuto a superare le ansie della vita e ad elaborarne i dolori.
Come si sono comportati i primi cristiani di fronte a questa religiosità diffusa, che potremmo chiamare «naturale»?
Provenendo da una matrice ebraica, essi per prima cosa hanno distinto nettamente la creatura dal Creatore. Il mondo, per quanto bello e ordinato, non poteva essere adorato come Dio. Il concetto di creazione dal nulla, fondamentale nella fede ebraico-cristiana, era estraneo non soltanto alla religione greco-romana, ma anche alle varie scuole filosofiche, al pari di quello di un Dio trascendente.
L’idea del divino, che in qualche modo si può dire innata nell’uomo, in assenza di una chiara distinzione ontologica diventa facilmente materializzabile nelle cose. Così, ad esempio, si esprime il libro della Sapienza: «Davvero vani per natura tutti gli uomini che vivevano nell’ignoranza di Dio, e dai beni visibili non furono capaci di riconoscere colui che è, né, esaminandone le opere, riconobbero l’artefice. Ma o il fuoco o il vento o l’aria veloce, la volta stellata o l’acqua impetuosa o le luci del cielo essi considerarono come dèi, reggitori del mondo» (Sap 13,1-2).
Nondimeno l’autore sacro trova quasi una scusante per questa idolatria del creato, tanto sono belle le opere del Creatore…