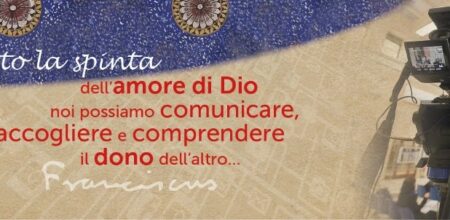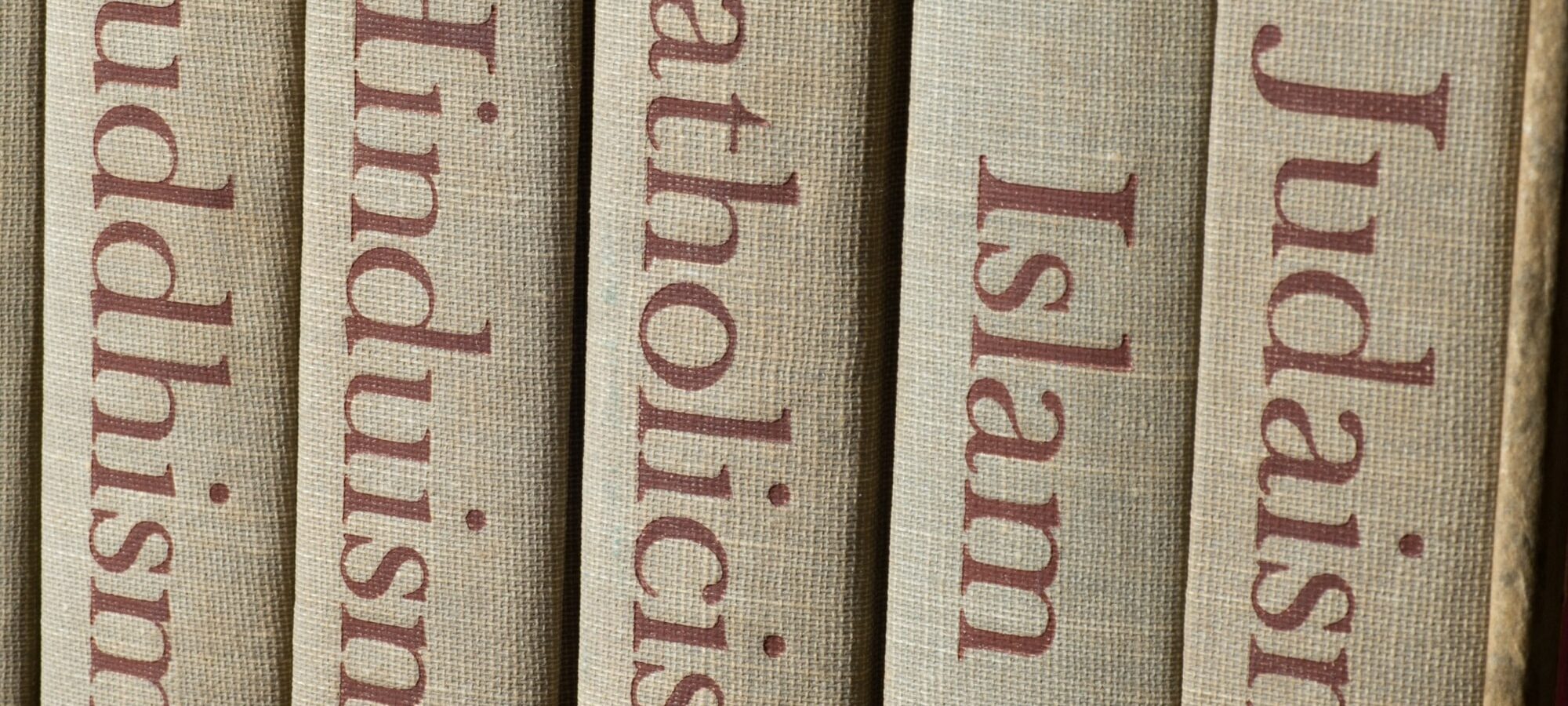
Dal Concilio alla globalizzazione postmoderna
Sviluppando le indicazioni già contenute nell’enciclica Ecclesiam suam (1964) di san Paolo VI circa il dialogo della salvezza e l’insegnamento della costituzione dogmatica Lumen gentium sulla Chiesa che l’aveva di poco preceduta, la dichiarazione Nostra aetate, dopo una travagliata gestazione, pone il dialogo al centro delle relazioni della Chiesa cattolica con le altre religioni. L’attuale fenomeno della globalizzazione sta focalizzando l’attenzione piuttosto sul pluralismo religioso e sulla sfida del fondamentalismo, e non solo di quello di marca islamica. E questo in un contesto culturale sempre più segnato da un pervicace relativismo che corrompe ogni certezza in un magma liquido perfettamente funzionale agli sviluppi di una società consumista, dove l’«usa e getta» viene facilmente trasferito dal prodotto al consumatore e alle sue relazioni sociali, nonché a Dio stesso.
Anche in questo nuovo contesto la fede cristiana non potrà mai rinunciare ad affermare insieme, pena il venir meno a sé stessa, che Dio «vuole che tutti gli uomini siano salvati e giungano alla conoscenza della verità» (1 Tm 2,4) e che «non vi è […] altro nome dato agli uomini, nel quale sia stabilito che noi siamo salvati» (At 4,12) se non quello di Gesù, morto e risorto precisamente per donare a ogni essere umano questa salvezza. E proprio il cercare di tenere aperta tale tensione, senza sacrificare nessuno dei due poli, è stata tra l’altro la caratteristica teologica di Joseph Ratzinger, quando essa si è trovata a toccare la questione del dialogo interreligioso.
Il primo passo per articolare correttamente queste due esigenze è rendersi conto che ci sono state modalità differenti per farlo, spesso dipendenti dai diversi contesti storico-sociali e pastorali. Esse sono strettamente legate allo sviluppo della dottrina secondo la quale «fuori dalla Chiesa non c’è salvezza» (extra ecclesiam nulla salus), la cui interpretazione ha spesso condizionato la corretta ricezione del «dialogo di salvezza» promosso dal Concilio Vaticano II.
Un caso di sviluppo dogmatico
Questa espressione venne usata per la prima volta da Origene, subendo poi uno sviluppo ermeneutico al di là del suo contesto originario, passando attraverso una storia degli effetti spesso collegata all’allargamento dei confini culturali e geografici della Chiesa. Nell’iniziale contesto patristico l’espressione faceva infatti principalmente riferimento a coloro che si erano volontariamente separati dalla comunione ecclesiale, da loro un tempo goduta e fuori dalla quale per essi non poteva appunto esservi salvezza alcuna. Il discorso era dunque per lo più intraecclesiale e in un contesto dove
Contenuto riservato agli abbonati
Vuoi continuare a leggere questo contenuto?
Clicca quioppure
Acquista il quaderno cartaceoAbbonati
Per leggere questo contenuto devi essere abbonato a La Civiltà Cattolica. Scegli subito tra i nostri abbonamenti quello che fa al caso tuo.
Scegli l'abbonamento