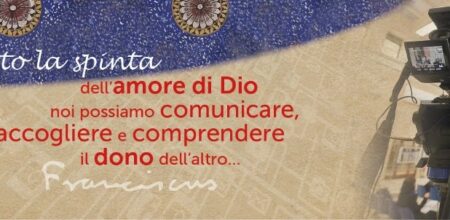Uno sguardo alla storia ci mostra che il cristianesimo, per molti secoli, ha accettato la schiavitù come una realtà sociale ed economica propria della maggior parte delle società. Il pensiero cristiano ha accettato la schiavitù in determinate circostanze e, quando si è sviluppata la tratta atlantica, lo sforzo dei teologi e giuristi è stato quello di delimitare con esattezza le occasioni di perdita legittima della libertà. Fu il caso, nel secolo XVI, di pensatori come Luis de Molina e Tomás de Mercado. Come scrive papa Francesco, la morale e il diritto stabilivano «chi nasceva libero e chi, invece, nasceva schiavo, nonché in quali condizioni la persona, nata libera, poteva perdere la propria libertà, o riacquistarla. In altri termini, il diritto stesso ammetteva che alcune persone potevano o dovevano essere considerate proprietà di un’altra persona, la quale poteva liberamente disporre di esse»[1].
Nel periodo dell’espansione europea e, in particolare, con l’arrivo in America alla fine del secolo XV, la Chiesa ha difeso la libertà dei popoli amerindi. Ne sono esempio papa Paolo III con la bolla Sublimis Deus, del 1537, e pastori e missionari, come i domenicani Antonio de Montesinos e Bartolomé de Las Casas nell’America spagnola, e i gesuiti Manuel da Nóbrega e António Vieira nell’America portoghese. Per quanto riguarda la schiavitù degli africani, la Chiesa l’ha più facilmente accettata, limitando la propria azione alla richiesta di rispetto del diritto e della morale dell’epoca, alla cura pastorale e all’esigenza di condizioni di vita degne. Tra le cause di questa accettazione, al pari degli argomenti giuridici e morali, c’è la constatazione dell’esistenza della schiavitù in Africa prima dell’arrivo degli europei, nonché della tratta verso il mondo arabo. Tuttavia va riconosciuto chiaramente che l’arrivo degli europei e la tratta atlantica, che forniva manodopera all’America, hanno moltiplicato la domanda di schiavi e, di conseguenza, la loro offerta in punti strategici del litorale africano. Per questo la domanda europea di manodopera a buon mercato ha portato alla crescita della conflittualità tra le popolazioni africane i cui capi non erano indifferenti agli scambi commerciali con gli europei[2]. In tale contesto, non destava scalpore il fatto che, in diversi Continenti, molte istituzioni ecclesiali facessero ricorso all’impiego di schiavi per i lavori domestici e agricoli. E non stupisce neppure che qualche voce più radicale in favore della libertà sia rimasta isolata e inascoltata. Con luci e ombre, possiamo dire, in ogni caso, che il
Contenuto riservato agli abbonati
Vuoi continuare a leggere questo contenuto?
Clicca quioppure
Acquista il quaderno cartaceoAbbonati
Per leggere questo contenuto devi essere abbonato a La Civiltà Cattolica. Scegli subito tra i nostri abbonamenti quello che fa al caso tuo.
Scegli l'abbonamento