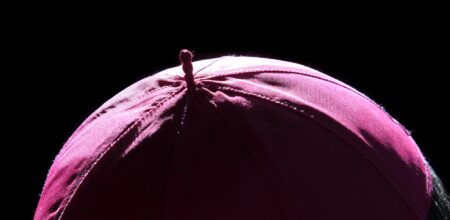|
|
Le mappe geografiche sono uno specchio del tempo: frontiere e confini si spostano sullo scacchiere della storia e raccontano di guerre, occupazioni e trattati internazionali. «Scrivere la storia significa incasinare la geografia», per dirla con Pennac[1]. Ne era consapevole Élisée Reclus, geografo e politico francese, che negli anni Cinquanta dell’Ottocento scrisse un’importante opera, intitolata Nouvelle Géographie Universelle.
Personalità inquieta e studioso brillante, Reclus fu per ben due volte esiliato dalla Francia a causa delle sue idee anarchiche. Scrisse le sue opere più importanti durante il tempo dell’esilio, viaggiando tra Algeria, Stati Uniti, Canada e Sud America. Nella sua vita professionale alternò sempre l’attività scientifica a quella politica, giungendo alla conclusione che «la geografia non è altra cosa che la storia nello spazio, così come la storia è la geografia nel tempo»[2].
Oggi è l’esodo forzato di milioni di rifugiati a raccontare una «storia nello spazio»: quella di una nazione di profughi, apolidi e sfollati che nel 2016 ha superato i 65 milioni di persone. Una geografia fluida, che interroga non soltanto sociologi, politici e opinionisti, ma anche geografi e artisti di tutto il mondo.
Sì, perché al pari dei geografi, gli artisti da sempre realizzano mappe concettuali per narrare l’esodo interiore ed esteriore dell’uomo. Utilizzano prospettive diverse per raccontare la fuga di milioni di persone in cerca di futuro e di pace. Carte geografiche, itinerari, racconti di sbarchi ed esperienze di accoglienza sono così entrati prepotentemente nell’immaginario collettivo di tanti artisti e scrittori.
Itinerari spezzati
La geografia, come la storia, è scritta dai vincitori. Ma c’è una geografia della sopravvivenza che supera i confini della storia. Lo racconta Bouchra Khalili, autrice della videoinstallazione The Mapping Journey Project, presentata nel 2016 al Moma di New York. «Il mio progetto – dice l’artista – è consistito nel dare potere a persone che subiscono l’arbitrarietà del tracciato dei confini, per produrre la loro propria mappa e narrazione. Così svelo una contro-mappatura, risultato di esperienze singolari, ma universali»[3].
Nel progetto della giovane artista franco-marocchina, otto protagonisti, uomini e donne, tracciano su una carta geografica il loro itinerario di fuga. È il tragitto di tanti sopravvissuti che hanno lasciato l’Africa, il Medio Oriente e l’Asia per trovare rifugio in Europa.
Volti sconosciuti disegnano con un pennarello tracce indelebili di speranza, dolorosi itinerari di libertà. Il pennarello si ferma su città, porti, strade. I protagonisti del video disegnano piccole frecce, come lancette di una bussola che orienta le tappe di un itinerario sconosciuto. A volte la mano esita, altre volte con sicurezza traccia una linea precisa. Brevi scritte compaiono sullo schermo per individuare nomi e località. Dietro quelle sobrie indicazioni s’intuisce un itinerario in cui le tappe non sono luoghi, ma incontri. Incontri con scafisti, poliziotti, compagni di sventura.
I protagonisti del video raccontano con chiarezza le tappe del viaggio. Per molti rifugiati, il racconto della fuga si scontra con la fatica di ricostruire un percorso doloroso, fatto di violenza e di solitudine. Un tempo da dimenticare. È difficile ricostruire le coordinate topografiche della disperazione.
I villaggi attraversati, le rotte percorse, le strade abbandonate sono tanto più significativi quanto più sono lontani dai luoghi di persecuzione. Non è la destinazione a determinare il percorso, ma la paura. Il terrore di essere catturati traccia vie impensabili, sconosciute. Spesso l’unica speranza si chiama confine: una riga tracciata con il righello dalla storia, o una linea di matita disegnata da colonizzatori stranieri.
Arte per resistere, biografia e provocazione
Molteplici sono i modi in cui l’arte del nostro tempo ha raccolto la sfida di raccontare il mondo delle migrazioni forzate. C’è chi ha scelto la provocazione, chi l’immediatezza della cronaca; c’è chi ha fatto della propria fuga il soggetto di un’esperienza artistica.
Nel febbraio del 2016, l’artista cinese Ai Weiwei decise di coprire le sue opere esposte a Praga con i teli termici usati dai migranti. Lo stesso artista, a Lesbos, si fece fotografare sdraiato a pancia in giù sulla spiaggia, come il piccolo Aylan, il bambino trovato morto sul litorale di Bodrum, in Turchia.
Ai Weiwei ama stupire, interrogare. Lo ha fatto anche alla Konzerthaus di Berlino, ricoprendo le colonne dell’ingresso di piazza Gendarmenmarkt con oltre 14.000 giubbotti di salvataggio.
Anche a Firenze, in occasione della sua prima retrospettiva italiana, a Palazzo Strozzi, ha ricoperto le finestre dell’edificio rinascimentale con 22 canotti di salvataggio, scatenando polemiche ed entusiastici commenti.
Un tema, quello dei gommoni e dei soccorsi in mare, che è presente anche nell’installazione di Arabella Dorman, nella chiesa di Saint James a Londra, dove un canotto pende sospeso sulle teste dei visitatori. E poi ci sono le tante imbarcazioni costruite con scarpe, stracci e valigie, realizzate da Sislej Xhafa e da Barthélémy Toguo.
Provocazione e memoria si ritrovano in dialogo nelle opere di chi ha raccontato il mondo dei migranti a partire dalla propria esperienza personale. Non pochi sono gli artisti che, a causa di guerre e persecuzioni, hanno dovuto lasciare il proprio Paese per cercare protezione in un Paese straniero. Tra questi, vogliamo ricordare Rabee Kiwan e Adrian Paci. Mondi lontani, biografie diverse: l’uno siriano l’altro albanese. In molte delle loro opere il confine tra biografia e ricerca artistica si dissolve, lasciando in prospettiva spazi di narrazione collettiva.
Rabee Kiwan: fototessere e identità
In una delle opere più originali di Rabee Kiwan, Passport photo (2014), vediamo quel delicato rapporto che ogni rifugiato instaura con i propri documenti. Kiwan dipinge una serie di fototessere e di timbri su sfondo neutro. Ritratti anonimi, sfigurati, simili a passaporti sgualciti. Documenti che rivelano fughe e identità negate. È di fronte all’esodo siriano che Kiwan riflette sull’identità personale e collettiva di un popolo schiacciato da cinque interminabili anni di guerra.
Le fototessere sui passaporti rivelano, in effetti, un duplice messaggio: sono ciò che ci identifica in modo unico e personale, e nello stesso tempo sono ciò che testimonia un’appartenenza collettiva a un popolo, a una nazione.
Nell’arte del Novecento, l’uso della fototessera ha incontrato numerosi apprezzamenti: da Max Ernst a Marcel Duchamp, da Andy Warhol a Piero Vaccari, fino ai più giovani Cindy Sherman e Thomas Ruff. Martin Crawl definì le vecchie cabine per fototessere automatiche delle vere e proprie «macchine socratiche».
La fototessera avrebbe l’arduo compito di descrivere l’identità, ma difficilmente può spingersi oltre l’apparenza. È uno sguardo muto e decontestualizzato sulla realtà personale del soggetto fotografato. Lo stato interiore di chi è ritratto, il carattere e la storia personale del soggetto rimangono per lo più impenetrabili. Lo sfondo rigorosamente neutro e la luce frontale cancellano involontariamente quell’ultima possibilità di caratterizzazione individuale. È una superficie atona che cattura l’apparenza, negando la soggettività. Quanto più l’obiettivo si avvicina al volto del soggetto, tanto meno si percepisce la sua personalità. Fototessere e impronte digitali non sono altro che il «precipitato» della nostra identità.
Chi è il soggetto da identificare: la persona o la foto del documento? Chi conferma chi? Più l’indagine è accurata, più si rivela umiliante. La foto del documento tenta un’approssimazione. Senza documenti noi non siamo. Lo scriveva Joseph Roth negli anni Trenta: agli occhi delle autorità un uomo senza documenti vale «meno di un documento senza l’uomo»[4]. È questa la tragedia di tanti rifugiati.
Adrian Paci e il suo «Centro di permanenza temporanea»
Nelle opere di Adrian Paci esperienza biografica e ricerca artistica s’influenzano vicendevolmente, creando inconsueti paesaggi dell’anima. Scenari in movimento, identità nomadi, sconfinamenti e contaminazioni sono la grammatica di un percorso professionale che ha condotto l’artista albanese a produrre opere che spaziano dalla pittura al video, dalla fotografia alla scultura. Cambiano le forme, i supporti, le espressioni, ma il flusso della vita e il dolore del transito sono il tratto caratteristico delle sue narrazioni.
Nato nel 1969 a Scutari, e giunto all’età di 22 anni a Milano, Adrian nel 1997 decide di lasciare definitivamente il suo Paese a causa dei continui disordini politici. La scoperta del video era avvenuta già negli anni dell’Accademia di Belle Arti, a Tirana. Erano gli anni del cambiamento politico: «Ho iniziato a usare il video per raccontare le mie esperienze. I pennelli non mi bastavano, mi serviva qualcos’altro. Ma l’impronta della pittura è rimasta, anche quando scattavo foto o giravo con la camera»[5].
Paci comincia a catturare il transito. Come davanti a un video al rallentatore, congela movimenti, espressioni, isolando gesti e personaggi. Non è un esercizio di cronaca, ma l’esigenza di dipingere una realtà in disfacimento. L’artista non vuole fissare momenti, ma raccontare processi: «Attraverso dei piccoli frammenti, cercavo di ricomporre il mosaico di una storia più grande»[6]. Ispirandosi ai grandi registi del passato, egli utilizza scene tratte dal Decameron di Pasolini, dipingendo frammenti del film. Parlando del suo omaggio all’artista friulano, ricorda che la sua intenzione era quella di «andare a pescare nel suo sguardo […], per poi tradurre quelle immagini in pittura»[7]. Paci non cattura soggetti, ma sguardi. Non sono semplici citazioni riprodotte su tela, ma intenzioni, modi inconsueti di guardare e pensare la realtà.
Nel video Centro di permanenza temporanea (2007), un gruppo di persone attraversa lentamente la pista d’atterraggio di un aeroporto per salire sulla scaletta che conduce al portellone dell’aereo. La telecamera inquadra in successione i passi e i volti di una processione disperata. Indifferenza, attesa, preoccupazione sono dipinte su volti scarni e illuminati da un sole meridiano che accorcia ombre e speranze. Dietro di loro, il nulla. L’artista albanese non chiede di immedesimarsi nei soggetti, ma nel loro sguardo. Che cosa guardano?
Finalmente il piano si allarga e lo spettatore capisce. Sullo sfondo, aerei attraversano la pista. In sottofondo, il rumore dei motori infrange il silenzio della scena. Davanti a loro, il vuoto. Assiepati sulla scaletta, si ritrovano isolati, sospesi. Per loro non c’è approdo, nessun aereo.
È un viaggio interrotto, forse mai iniziato. È una scala senza accesso, un muro invisibile, capace di arrestare qualsiasi sogno. Un «non-luogo». Non si vive su una scala, non si staziona al centro di una pista di volo. Luoghi di passaggio diventano inospitali tempi sospesi. Un uomo si è seduto, la telecamera indietreggia ancora per restituirci il panorama completo. A un passo da un ipotetico volo, il viaggio si è spezzato. Enormi aerei si librano in aria con la leggerezza di una piuma, ma la scala è pesante, e l’attesa sotto il sole è interminabile: è un Centro di permanenza temporanea.
Uno sguardo al passato: tra verismo e contemporaneità
«Quando arrivai, verso sera, l’imbarco degli emigranti era già cominciato da un’ora […]. La maggior parte di loro, avendo passato una o due notti all’aria aperta, accucciati come cani per le strade […], erano stanchi e pieni di sonno. Operai, contadini, donne con bambini alla mammella, […] robusti lavoratori dagli occhi tristi, vecchi cenciosi e sporchi, donne gravide, ragazze allegre, giovanotti brilli, villani in maniche di camicia […]. Due ore dopo che era cominciato l’imbarco, il grande piroscafo, sempre immobile, come un cetaceo enorme che addentasse la riva, succhiava ancora sangue italiano»[8].
Sono le parole che Edmondo De Amicis scrisse – nel 1884, imbarcandosi su un piroscafo di emigranti italiani – per documentare l’esodo di migliaia di uomini e donne che espatriavano per sopravvivere. A quel tempo, dei nostri connazionali si diceva che erano «la parte più lurida e miserabile di esseri umani mai sbarcati a Castle Garden» (New York Times, 6 novembre 1879).
È la stessa realtà dipinta da numerosi artisti italiani di fine Ottocento. Negli ultimi decenni del XIX secolo, il Verismo assunse il faticoso ruolo di documentare le disuguaglianze e le miserie dell’Italia postunitaria. L’adesione alla realtà e il desiderio di una pittura anticlassica trasformò soggetti di genere in vere e proprie opere di denuncia sociale. È in questo contesto che la pittura italiana venne a contatto con il doloroso mondo dell’emigrazione. Ne è testimone il pittore Angiolo Tommasi, il quale, nel grande dipinto intitolato Emigranti, ha raccontato le paure e le speranze di tanti nostri connazionali.
Tommasi dipinge un porto e l’attesa di una folla in partenza. Sullo sfondo, le navi: un futuro sospeso, irraggiungibile. In primo piano, contadini, commercianti, artigiani. Volti scavati dalla fame popolano una banchina gremita.
Alcuni uomini già volgono le spalle al passato, altri non riescono ancora a guardare oltre il mare. Una donna pensosa si tiene il capo con la mano; un’altra allatta il proprio bambino; un’altra ancora accarezza il grembo gravido; un’anziana signora fissa distrattamente la corona del rosario che scivola fra le sue dita. Nei volti di queste donne si addensano i dubbi e le domande di tutti. Precarietà, speranza, fame: tutto è ritratto in questa attesa.
Accanto a queste grandi narrazioni, c’è chi ha voluto ritrarre l’ultimo saluto sulla banchina, il bacio dei figli a un padre in partenza, il distacco e la solitudine che irrompe al momento dell’addio. Tra questi, Raffaello Gambogi e Arnaldo Ferraguti.
Non è la narrativa epica de I profughi di Parga di Francesco Hayez a ispirare il realismo sociale di questi artisti, ma quell’istanza figurativa che dal naturalismo lombardo approda al realismo francese e al verismo italiano, passando attraverso Caravaggio, Goya, Daumier, Courbet, Delacroix, Pellizza da Volpedo, Telemaco Signorini e molti altri.
Una pittura capace di dare voce alle miserie e alle contraddizioni del tempo. Un’arte che assume la responsabilità della denuncia. Il tempo in cui viviamo può far dubitare della buonafede di tanti artisti impegnati nel raccontare il mondo delle migrazioni forzate. Nonostante le precauzioni, non possiamo non rilevare un positivo desiderio di denuncia che stimola messaggi di solidarietà attraverso forme artistiche spesso accusate di narcisismo e di autoreferenzialità.
Abbiamo ancora bisogno di un’arte che produca una ferita nello sguardo, senza la quale le nostre conoscenze rimarrebbero prive di senso e di umanità.
Copyright © La Civiltà Cattolica 2017
Riproduzione riservata
***
[1] D. Pennac, La fata carabina, Roma, Feltrinelli, 1992.
[2] E. Reclus, Natura e società. Scritti di geografia sovversiva, Milano, Elèuthera, 1999.
[3] F. Pini, «Un artista ci salverà: se il mondo è a una svolta serve sforzo di creatività», in Corriere della Sera (www.corriere.it), 15 aprile 2016.
[4] J. Roth, Ebrei erranti, Milano, Adelphi, 1985.
[5] B. Casavecchia, «Paci: dipingere è pentirsi, e questo è il bello dell’arte», in Vivaverdi (www.siae.it), 24 marzo 2016.
[6] Ivi
[7] Ivi
[8] E. De Amicis, Sull’oceano, Milano, Garzanti, 2009, 16.
********
PAINFUL ITINERARIES OF FREEDOM. Art recounts the refugees plight
The exile Élisée Reclus wrote that «geography is nothing more than history in space, just as history is geography over time». The forced exodus of millions of refugees, which we are witnessing today, tells a «story in space»: that of a nation of refugees, stateless and displaced persons who exceeded 65 million people in 2016. A fluid geography that questions not only sociologists, politicians, columnists and, of course, geographers, but also artists from all over the world, who realize conceptual maps to tell the inner and outer exodus of man.