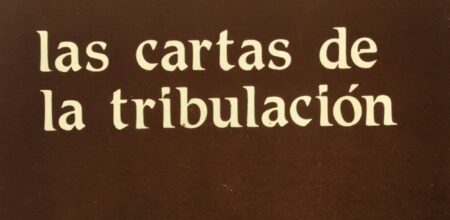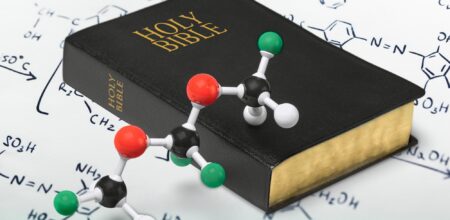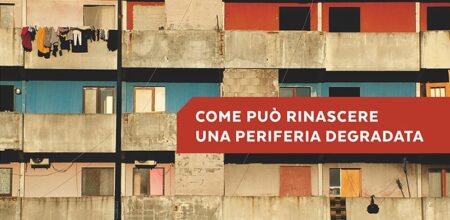Lo «spirito di accanimento» è sempre stato presente nella storia dell’umanità. Cambia la forma, ma si tratta sempre dello stesso dinamismo che porta alcuni ad accanirsi contro gli altri. Si è manifestato per la prima volta nella rabbia di Caino, che lo spinse a uccidere suo fratello, e continua a scatenarsi nella furia del demonio che, non potendo uccidere la Donna – figura della Chiesa –, si volge contro «il resto della sua discendenza» (cfr Gen 4,6 e Ap 12,17). Le nuove forme oggi prendono nomi quali «bullismo», «persecuzione mediatica».
In una recente omelia a Santa Marta, papa Francesco ha riflettuto sul mistero del male che si rivela nel bullismo, nell’atto di «aggredire la persona più debole». «Gli psicologi daranno spiegazioni buone, profonde – ha affermato –, ma io soltanto dico [che lo fanno] anche i bambini […], e questa è una delle tracce del peccato originale, questa è opera di Satana»[1].
Il fatto che venga menzionato Satana ci avverte del carattere prettamente spirituale di un comportamento che, in base ad alcune espressioni che utilizziamo per denominarlo – «accanimento» in italiano, encarnizamiento in spagnolo –, indurrebbe a pensare che si tratti di qualcosa di animalesco, ma non è così. Mescolato e confuso con la dimensione carnale, si nasconde un plus di ferocia e di crudeltà gratuita che, quando ne vediamo gli effetti, produce enorme sconforto e confusione mentale. Il pensiero, ad esempio, va all’adolescente che si suicida perché non può sopportare che una sua immagine intima sia diffusa in internet, fino a divenire virale.
Lo spirito di accanimento è demoniaco, nel senso che è contrario alle leggi della natura: non soltanto distruttivo, ma autodistruttivo. È contagioso e genera effetti nocivi a livello sociale: abbandono, sentimenti di sconforto e spaesamento, confusione. E poiché si nasconde e si confonde all’interno di altri fenomeni, è necessario esporlo alla luce del discernimento spirituale per non sbagliarsi sul modo di resistergli: è possibile, per esempio, cadere nel contagio del suo dinamismo perverso, pur combattendone alcuni effetti.
Bisogna tener conto del fatto che, accanto all’accanimento palesemente distruttivo, ce n’è un altro «educato»[2], che agisce subdolamente, ma con identica e sistematica crudeltà. Non è forse sintomatico il fatto che usiamo i termini «inumano» e «disumano» senza riflettere a volte che, con essi, non intendiamo «animale», bensì qualcosa di altra natura?
Una breve fenomenologia dello «spirito di accanimento» ci aiuterà a riconoscerlo meglio, per poterne interpretare la malignità, affinché
Contenuto riservato agli abbonati
Vuoi continuare a leggere questo contenuto?
Clicca quioppure
Acquista il quaderno cartaceoAbbonati
Per leggere questo contenuto devi essere abbonato a La Civiltà Cattolica. Scegli subito tra i nostri abbonamenti quello che fa al caso tuo.
Scegli l'abbonamento