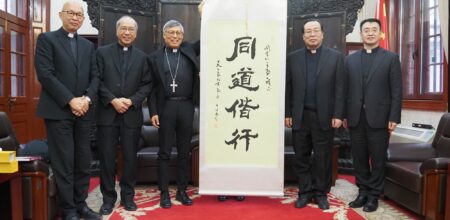|
|
P. Enrico Cantore (1926-2014) è un gesuita piemontese che, nel corso della sua lunga vita religiosa, ha perseguito con grande costanza una linea di apostolato che egli stesso definiva «umanistico-scientifico». Convinto del ruolo determinante della scienza nel mondo contemporaneo e del fatto che non ci sia estraneità né contraddizione tra scienza e fede, si è dedicato con tutte le forze a studiare e comprendere dall’interno l’attività scientifica, per promuoverne il valore per la crescita della dignità umana in una prospettiva cristiana.
Considerando gli Stati Uniti, e in particolare la città di New York, come luogo strategico per lo sviluppo della cultura contemporanea, vi ha trascorso gran parte della sua vita, pubblicando in inglese i suoi scritti principali. Quello più importante è Scientific Man. The Humanistic Significance of Science (1977), pubblicato nel 1987 anche in italiano (L’uomo scientifico. Il significato umanistico della scienza, Bologna, EDB) e ristampato nel 2021.
La sua opera è rimasta poco conosciuta, anche perché il suo lavoro non si è svolto all’interno di un’istituzione accademica, ma in modo relativamente solitario, pur coltivando rapporti significativi con il mondo degli scienziati. Tuttavia, la sua eredità culturale non si è persa, anche perché ha trovato un autorevole estimatore in Giuseppe Tanzella-Nitti, professore dell’Università della Santa Croce a Roma e fondatore di una «Scuola internazionale superiore per la ricerca interdisciplinare», nella quale Cantore, nei suoi ultimi anni, vide in certo senso una traduzione concreta dell’impegno della sua vita.
Tanzella-Nitti e il suo collaboratore Claudio Tagliapietra sono autori di due pregevoli contributi che introducono il volume che presentiamo. Esso raccoglie in versione italiana 17 articoli di p. Cantore, pubblicati in diverse riviste – tra cui anche La Civiltà Cattolica – e in volumi collettanei, fra il 1956 e il 2002. I contributi sono organizzati in tre parti, i cui titoli esprimono bene le tematiche affrontate: «La dimensione filosofica della scienza»; «La vocazione scientifica dell’uomo»; «La dimensione religiosa della ricerca scientifica».
Come spiega Tanzella-Nitti, il lavoro di Cantore non va collocato nell’ambito della «filosofia della scienza», poiché «il suo pensare sulla scienza è principalmente un pensiero sull’attività scientifica, cioè sul lavoro dello scienziato, di cui sa cogliere con rara profondità le dimensioni umanistiche, esistenziali e religiose, ma anche le implicazioni etiche e sociali».
Inoltre, «la sua interdisciplinarità non si ferma alla filosofia, ma partendo dalle scienze giunge fino alla teologia». Cantore non ha solo studiato l’attività scientifica sui libri, ma ha anche dialogato personalmente in profondità con scienziati del calibro di Werner Karl Heisenberg e Jean Piaget.
Negli articoli della terza parte abbiamo una testimonianza eloquente della dimensione biblica e teologica degli studi di Cantore. Appassionato cultore della letteratura sapienziale biblica e di una visione cristocentrica dell’intera realtà umana e cosmica, egli ha saputo integrare scienza-sapienza-amore in una prospettiva esperienziale e ideale al tempo stesso profonda e molto alta. Tanzella-Nitti ricorda che al termine delle sue conferenze veniva spesso osservato che Cantore aveva un’idea della scienza «troppo alta», idealizzata. Allo stesso tempo bisogna osservare che proprio per questa idea i giovani si sentono attratti dalla ricerca scientifica, gli scienziati si sobbarcano fatiche e sacrifici nelle loro ricerche, la società si attende dagli uomini di scienza nobiltà d’animo e sguardo lungimirante per il bene dell’umanità.
Pur avendo toccato, per certi aspetti, le questioni dello sviluppo socioeconomico, Cantore non entra ancora nelle questioni che oggi ci angosciano sulla distruzione del Pianeta e sulle dimensioni disumanizzanti delle dinamiche del sistema scientifico-economico-tecnologico, né in quelle delle trasformazioni antropologiche portate dal mondo digitale.
Il suo procedere ordinato e sistematico e il suo linguaggio limpido possono apparire estranei alla drammaticità delle dinamiche travolgenti della scienza e della tecnologia di oggi con le loro conseguenze. Ci possiamo quindi interrogare su quanto sia attuale la sua eredità.
In realtà, egli non ci spinge a evitare le grandi questioni di oggi, ma a cercarne piuttosto una soluzione radicale, non dall’esterno ma dall’interno dell’attività scientifica stessa, ritrovandone la dimensione umanizzante e contrastandone quella disumanizzante. Impresa ardua, certamente, ma davvero degna di quella visione razionale, sapienziale e religiosa di cui Cantore è stato laborioso e fedele testimone e apostolo, e su cui vale certamente la pena di tornare a riflettere.