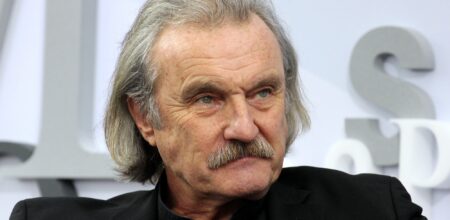|
|
Il De vera religione fu scritto da sant’Agostino verso la fine del 390, poco prima di essere ordinato prete. L’opera è indirizzata a Romaniano, il padre di Licenzio, il migliore degli allievi che vivevano a Cassiciacum con il santo di Tagaste. Lo scopo principale per cui venne composta era far sì che Romaniano abbandonasse il manicheismo e aderisse definitivamente al cristianesimo.
L’opera è piuttosto breve, ma contiene alcune importanti dottrine filosofiche e teologiche che verranno approfondite da Agostino in vari scritti posteriori. Marco Vannini, uno dei maggiori studiosi italiani di mistica, si è avvicinato al testo agostiniano in modo certamente originale, mettendone in evidenza due tesi: la prima, celeberrima, è quella secondo cui la Verità abita nell’interiorità dell’uomo; la seconda, che l’A. reputa assai rilevante e convincente, riguarda l’identità sostanziale che Agostino stabilisce tra fede cristiana e filosofia.
Per quanto concerne l’uomo interiore, Vannini afferma che Agostino ha scritto «pagine fondamentali nella storia della filosofia occidentale» (p. 16); con esse, infatti, «l’idea squisitamente neoplatonica della luce che illumina l’anima, che diventa la luce stessa dell’anima, si salda con il concetto giovanneo del Cristo-Logos» (ivi). Il cristianesimo, come religione del Logos, trova dunque il suo fondamento nell’interiorità e riceve una testimonianza dall’anima stessa. L’adesione autentica al cristianesimo richiede una radicale spoliazione, una piena disponibilità a perdere sé stessi, e ciò fa sì che la fede evangelica assomigli alla filosofia degli antichi maestri greci – soprattutto a quella di Platone e dei neoplatonici, che tanto affascinarono Agostino –, i quali definirono la filosofia esercizio di morte, distacco totale e incondizionato.
Vannini insiste molto sul ruolo decisivo esercitato da Plotino nella conversione di Agostino al cristianesimo: il grande pensatore di Licopoli gli indicò la via del ritorno all’interiorità e quella del distacco, le due strade essenziali per praticare l’antico ascetismo che caratterizza il vero cristianesimo. «A buon diritto perciò – afferma l’A. -, nel De vera religione, di fronte all’esempio di tanti uomini e donne che scelgono la via dell’interiorità e del distacco, desiderando “allontanarsi dalle cose di questo mondo e convertirsi all’unico vero Dio”, può presentare i cristiani come autentici discepoli della filosofia» (p. 80).
L’A. non esita a definire il santo vescovo di Ippona «il maestro di tutta la mistica cristiana, almeno nel suo versante più speculativo, e ciò proprio in quanto platonico e diffusore del platonismo in ambito cristiano» (p. 87). Certamente l’Agostino più anziano, quello sulle cui spalle grava il compito di guidare la Chiesa affidatagli, manifesta una sensibilità diversa rispetto a quella che caratterizza il De vera religione, quella che, come si legge più volte nel libro, poggia su due pilastri: la dimensione mistica dell’interiorità e l’identificazione tra cristianesimo e filosofia. Assai eloquente è la seguente affermazione contenuta nel De vera religione, con la quale Vannini conclude il suo scritto: «Filosofia – cioè ricerca della saggezza – e religione sono la stessa cosa: questo il principio della salvezza per l’uomo» (p. 176).