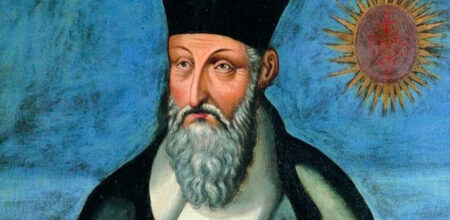|
|
Non è, questa, la semplice versione italiana di una precedente edizione tedesca: è un libro nuovo, molto più ampio, una vera e propria editio maior, che la Fondazione Lorenzo Valla presenta nella «Collana degli Scrittori greci e latini». Presocratici comprende tre volumi: Sentieri di sapienza attraverso la Ionia e oltre: da Talete a Eraclito; Sentieri di sapienza da Velia ad Agrigento: da Parmenide ad Empedocle; Sentieri di sapienza dalla Ionia ad Atene: da Anassagora agli atomisti (gli ultimi due sono in preparazione).
Il primo volume tratta di Talete, Anassimandro, Anassimene, Pitagora e i pitagorici antichi, Senofane ed Eraclito. L’opera, a cura di Laura Gemelli-Marciano, già docente di filologia classica all’Università di Zurigo e in altri atenei, presenta una storia puntuale delle origini della filosofia e della scienza, del termine «presocratici» e delle sue interpretazioni; una visione della storiografia filosofica a partire dal Settecento; e un saggio su ciascuno dei suddetti filosofi. E dà la parola a filosofi e scrittori antichi, che ricostruiscono vita e opera dei sei personaggi. Una galleria di ritratti suggestivi, accattivanti, vivi.
Di Talete non ci sono pervenuti scritti. Ne scopriamo ogni aspetto – da quello di consigliere politico a quello di astronomo, e da quello di esperto di geometria a quello di filosofo della natura – attraverso le parole di Aristotele, Seneca, Erodoto, Ippia e Aezio.
Anassimandro è autore di un libro Sulla natura, considerato il primo «vero» testo di filosofia «che sia mai stato messo per iscritto in Occidente (anche se non ci è pervenuto)».
Anassimene, di Mileto, appare lontano dal suo concittadino Anassimandro, suo «presunto maestro per metodologia e dottrina» (p. 63). Tuttavia entrambi, mossi dalla passione per la ricerca di un «principio», studiano cosmologia e fenomeni naturali.
Il libro Sulla natura di Eraclito (il primo, come apprendiamo da Clemente Alessandrino, ad attribuirsi il titolo di «filosofo») tratta molteplici argomenti, dalla politica ai segreti della natura. Fu scritto, come leggiamo in un frammento di Diogene Laerzio, «in una lingua più oscura, affinché solo quelli capaci di intenderlo vi avessero accesso e non fosse oggetto di spregio da parte del volgo» (p. 381).
Senofane critica Omero e i grandi poeti che concepiscono gli dèi come uomini: una tesi che può dare l’avvio a un discorso teologico.
Pitagora, approdato a Crotone, accolto con entusiasmo dal consiglio degli anziani, aprì una scuola frequentata da numerosi discepoli, uomini e donne; rivolse «esortazioni ai giovani commisurate alla loro età e, in seguito, ai fanciulli accorsi in folla dalle scuole, poi alle donne; da lui fu istituita anche un’associazione di donne» (p. 155). Le pagine dedicate a lui e alla sua scuola sono un viaggio nella geografia, nell’esperienza religiosa, nella cultura, nelle sorgenti della scienza e nel pensiero.
L’A. ci presenta questi personaggi con il suo stile sobrio, con la sua attenzione alle fonti, con le sue sintesi robuste e incisive.