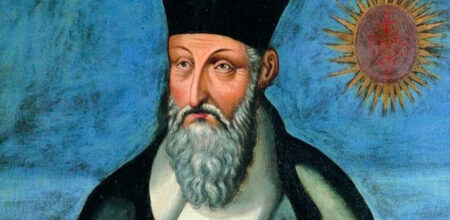Nella medievale Tour de l’Archet di Morgex (Aosta), ai piedi del Monte Bianco, sede della Fondazione «Centro di studi storico-letterari Natalino Sapegno», si è tenuto lo scorso anno un convegno su «Manzoni e la scuola»[1]. La relazione introduttiva, dal titolo «Sul “moralismo” manzoniano», è stata tenuta dal professor Bruno Germano, presidente della Fondazione, che ha insegnato Letteratura italiana per 35 anni nelle scuole superiori di Aosta, 22 dei quali nel locale Liceo classico. È anche autore di diverse fiabe in versi, destinate ai ragazzi delle scuole primarie e medie. A lui Natalino Sapegno, nativo di Aosta e molto legato alla sua città natale, affidò il compito di curare l’istituzione, per conto della Regione Valle d’Aosta, della Fondazione che porta il suo nome e ne onora la memoria. Nella sua conferenza, il professor Germano ha trattato il tema dell’impegno morale e civile del Manzoni ne «I Promessi Sposi» in una prospettiva di sorprendente modernità, anche in una concezione laica dell’uomo e della storia. Abbiamo voluto incontrare il professor Germano a Roisan, il piccolo comune vicino ad Aosta in cui risiede, e gli siamo grati per aver accettato di rispondere alle nostre domande.
Professor Germano, per la sua esperienza di studioso e di insegnante, quali erano le ragioni morali che hanno spinto il Manzoni a scrivere il suo capolavoro? Quanto sono presenti, in maniera più o meno esplicita, ne «I Promessi Sposi»?
Voglio mettere a fuoco le ragioni morali che hanno ispirato l’opera manzoniana rifacendomi a una celebre digressione del Fermo e Lucia, l’abbozzo composto tra il 1821 e il 1823, che, successivamente rielaborato e in gran parte riscritto tra il 1823 e il 1825, diventò I Promessi Sposi. All’inizio del secondo tomo dell’abbozzo, Manzoni immagina che un ipotetico lettore gli rimproveri una scarsa adesione sentimentale alla materia del suo racconto, dal momento che non si sofferma a descrivere gli slanci affettivi dei suoi protagonisti, che pure sono due innamorati e, appunto, promessi sposi. Non dimentichiamo che Manzoni aderiva al Romanticismo, le cui istanze innovative ha difeso e teorizzato (basti pensare alla Lettera a M. Chauvet, pubblicata nel 1823, proprio in quegli anni); ma evidentemente non approvava e voleva tenere le distanze dalla tendenza a solleticare gli istinti passionali dei lettori. In quel passaggio Manzoni si autoassolve dall’accusa ipotizzata, sostenendo che «l’amore è necessario a questo mondo; ma ve n’ha […], facendo un calcolo moderato, seicento volte più di quello che sia
Contenuto riservato agli abbonati
Vuoi continuare a leggere questo contenuto?
Clicca quioppure
Acquista il quaderno cartaceoAbbonati
Per leggere questo contenuto devi essere abbonato a La Civiltà Cattolica. Scegli subito tra i nostri abbonamenti quello che fa al caso tuo.
Scegli l'abbonamento