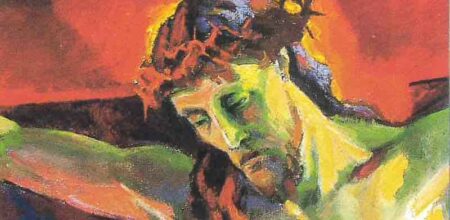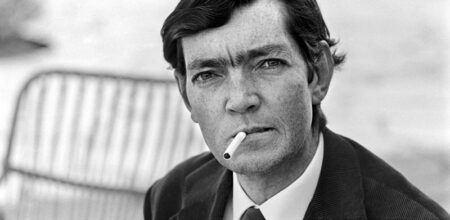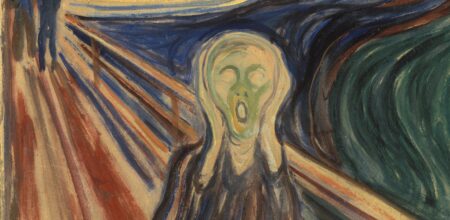|
|
Nel 1939 la filosofa spagnola María Zambrano aveva 35 anni. Dopo l’avvento del franchismo, aveva lasciato la Spagna e si era trasferita prima a Parigi, poi a L’Avana e da lì in Messico. In quell’anno ha pubblicato due opere di grande importanza – Pensiero e poesia nella vita spagnola e Filosofia e poesia –, ora raccolte nel volume di cui ci stiamo occupando, che contiene anche una ricca Introduzione di Armando Savignano e una densa Postfazione di Massimo Cacciari.
È proprio Savignano a offrire al lettore la prima indispensabile chiave interpretativa dei testi zambraniani, che consiste nel riconoscimento della «teoria della ragione poetica» come nucleo centrale del pensiero della filosofa di Vélez-Málaga: «Per Zambrano – scrive Savignano – non c’è poesia senza pensiero né ragione senza poesia. Solo l’unione di entrambi può indicarci il vero cammino» (p. 5). La filosofa si dimostra convinta che l’essenza della Spagna «emerga soprattutto nella poesia e nel romanzo, più che in una filosofia della storia» (p. 7). Con questo Zambrano non intende rinnegare la modernità, caratterizzata dalla conoscenza scientifica sperimentale e dalla conoscenza riflessivo-trascendentale della filosofia, ma vuole rivendicare il grande valore della «conoscenza poetica esperienziale che implica un contatto diretto con la realtà, una presenza carnale con riverberazioni sull’immaginazione creatrice, sulla memoria e il sentimento» (p. 10). È in questo contesto che lei fa riferimento al realismo spagnolo, che, a suo giudizio, rappresenta «la visione del mondo tipica della cultura spagnola» (p. 11).
Nei due scritti redatti nel 1939 l’A. mostra di aver pienamente compreso la crisi della modernità e, in particolare, della ragione, che di essa è stata l’elemento fondante e caratteristico. A questo punto si impone la necessità di elaborare un nuovo modello di razionalità che, non casualmente, sarà da lei identificato con la «ragione poetica». Secondo Zambrano, filosofia e poesia hanno una medesima origine, ma a un certo punto le loro strade divergono; e tuttavia non dobbiamo smettere di sperare che un giorno esse si riuniscano, dando vita a un logos che superi gli evidenti limiti del razionalismo, incapace di cogliere quella «verità rivelata e indecifrabile, al di là dell’essere e della creazione» (p. 22).
L’A. esprime un giudizio critico sull’intellettualismo e sul razionalismo, mentre sottolinea il valore conoscitivo dell’immaginazione, della visione e della rivelazione. Non sorprende che, muovendosi su questo piano, rivaluti l’importanza della dimensione mistica, della quale coglie la vicinanza con la poesia. Non a caso un affascinante capitolo di Filosofia e poesia è dedicato alla relazione esistente tra mistica e poesia (cfr pp. 219-241): si tratta di pagine fondamentali per la comprensione del pensiero zambraniano nella sua interezza, culminanti nell’affermazione dell’affinità dell’anima col divino. A questo riguardo, appare davvero illuminante il fatto che Massimo Cacciari definisca la filosofia di María Zambrano «un sapere dell’anima» (p. 335).