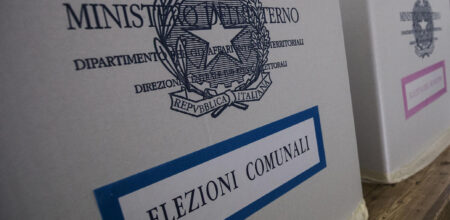|
|
Il Partito comunista d’Italia, divenuto nel 1943 Partito comunista italiano, nasce a Livorno, da una scissione del Partito socialista, il 21 gennaio del 1921. Dagli anni Novanta del secolo scorso non esiste più, e nel centenario della sua formazione Vannino Chiti, politico e studioso del movimento cattolico, ripercorre la storia e l’evoluzione del Pci dal punto di vista del suo rapporto con il cattolicesimo italiano. Come un «palombaro» d’eccezione, egli ci conduce nelle profondità di certi valori politici, recuperandoli all’attualità delle urgenze dei nostri tempi e in vista di un progetto comune.
Tre sono i protagonisti che scandiscono i temi principali di questa avventura politica: Gramsci, Togliatti, Berlinguer. Essi non erano cattolici, ma, nell’interrogarsi sulla società italiana, incontrarono il cattolicesimo in molteplici aspetti. Anzitutto, con la «questione romana» e la presenza della Santa Sede dopo il 1870, ma poi anche nelle abitudini del popolo e nelle attività sindacali e associazioniste.
Per Gramsci l’obiettivo fondamentale era «la liberazione dell’uomo: la critica alla religione si giustifica quando costituisce un impedimento a realizzarla» (p. 31). Per Togliatti, invece, si trattava di riconoscere la possibilità di impegnarsi in un movimento di orientamento socialista non «nonostante» la propria fede religiosa, ma in piena coerenza, e sapendo che «tale aspirazione può trovare uno stimolo in una sofferta coscienza religiosa posta di fronte ai drammatici problemi del mondo contemporaneo» (p. 69). Infine Berlinguer, che, in una lettera del 1976 indirizzata a monsignor Luigi Bettazzi, affermava: «Nel Partito comunista italiano esiste e opera la volontà non solo di costruire e di far vivere qui in Italia un partito laico e democratico, come tale non teista, non ateista e non antiteista; ma di volere anche, per diretta conseguenza, uno Stato laico e democratico, anch’esso dunque non teista, non ateista, non antiteista» (p. 115).
L’autore allora si chiede: «Esiste ancora una questione cattolica?». La domanda non riguarda soltanto l’Italia, ma l’Europa e il mondo, pur nella diversità delle forme con cui le religioni, nei vari continenti, si sono presentate sulla scena pubblica. Per poter rispondere in modo giusto a questa domanda, essa dovrebbe essere formulata in termini più appropriati: «Esiste per la politica una questione religiosa con cui misurarsi?» (p. 181). Secondo Chiti, sì, esiste, e la sinistra in Europa la sta sottovalutando. Le religioni esprimono una radicalità – non radicalismo – che non è da confondere con l’individualismo: la radicalità delle proprie convinzioni, che spingono al ripensamento della comunità dentro la quale si realizzano le nostre individualità, i diritti, ma anche «il dialogo tra i credenti e i diversamente credenti» (card. Martini).
La sinistra dovrebbe promuovere una profonda riforma dell’economia di mercato attraverso un nuovo compromesso con il capitalismo, fondandola su tre cardini: dignità della persona, non più del solo lavoratore; welfare universale; ecologia. Questa riformulazione fondamentale apre la via a quello che da tanti anni l’autore definisce un «nuovo umanesimo» (p. 203). Nelle parole di Chiti si avverte l’eco di due importanti encicliche di papa Francesco: Laudato si’, in cui c’è l’invito del Papa a costruire un sistema economico e sociale più giusto e rispettoso del creato, che abbia al centro l’uomo e non l’idolatria del denaro; e Fratelli tutti, dove il Papa indica la via su cui camminare per raggiungere questo obiettivo: il riconoscersi fratelli e sorelle, custodi l’uno dell’altro.
VANNINO CHITI
Il destino di un’idea e il futuro della sinistra. Pci e cattolici una radice della diversità
Milano, Guerini e Associati, 2021, 208, € 18,50.