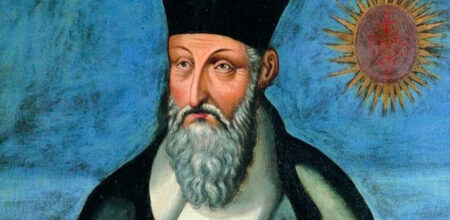|
|
Dopo averci regalato la monumentale e pregevole Grande storia della Germania, un’opera nella quale ha analizzato tra l’altro la progressiva rinuncia al Sonderweg e l’adesione ai valori della cultura occidentale da parte della Repubblica federale, il decano degli storici tedeschi Heinrich August Winkler ripercorre le vicende vissute dal suo Paese nel lasso di tempo che va dal 1848 al 1989, seguendo, in particolare, il filo costituito dal complesso rapporto che i suoi connazionali hanno avuto con la Rivoluzione, intesa come sovvertimento radicale dei rapporti di potere. Si tratta di uno studio lucido e approfondito, circostanziato e incisivo, che mette a disposizione del lettore sia la puntuale ricostruzione degli eventi sia le acute riflessioni su alcuni nodi della storia tedesca.
L’indagine di Winkler prende le mosse dalla «Rivoluzione del 1848-49», un’insurrezione che non riuscì a raggiungere il duplice obiettivo del conseguimento della libertà politica e dell’unità nazionale, cui mirava. Si rivelò pertanto qualcosa di molto simile a un fallimento, al quale Bismarck contrappose una «Rivoluzione dall’alto» – messa cioè in atto dai detentori del potere –, i cui risultati furono la fondazione del Secondo Reich e l’unificazione della Germania, conseguite entrambe nel 1871. Poi, nel corso di quegli anni Settanta, vi sarebbe stato il Kulturkampf e, nel decennio seguente, il Cancelliere avrebbe dato avvio alle riforme sociali.
Sarebbero state successivamente la «Rivoluzione del 1918-19» e la nascita della Repubblica di Weimar a dare a molti l’illusione che gli ideali di libertà, uguaglianza sociale e democrazia politica fossero a portata di mano. Esemplare per quanto concerneva i diritti fondamentali, la Costituzione del Reich si rivelò tuttavia fonte di aspri conflitti istituzionali. Nel gennaio del 1933 vi fu di conseguenza la presa del potere da parte di Hitler, alla quale avrebbe fatto seguito la «Rivoluzione di destra», incarnata dal totalitarismo nazionalsocialista, un sistema in cui le norme della convivenza civile, nel senso transatlantico e occidentale del termine, persero ogni validità.
La «rivoluzione pacifica» e la successiva riunificazione della Germania hanno infine condotto a una definitiva soluzione la «questione tedesca», che aveva costituito per diversi decenni un problema irrisolto e provocato ricorrenti tensioni tra i due blocchi durante la Guerra fredda. Il 3 ottobre del 1990 tale questione sarebbe stata archiviata e il «Paese dei poeti e dei pensatori» avrebbe ritrovato il proprio posto tra le democrazie occidentali. Scrive inoltre Winkler: «Il capovolgimento nella Germania Est è parte di un’ondata rivoluzionaria sovranazionale che ha interessato tutta l’Europa orientale, la più europea delle rivoluzioni dal 1848. Essa ha portato al più vittorioso cambio di sistema politico che si sia mai visto in Germania» (p. 124).
L’aggressione russa nei confronti dell’Ucraina ha poi provveduto a evidenziare la profonda crisi di identità della classe politica tedesca, che, abituata a individuare la chiave delle relazioni internazionali esclusivamente nella competizione economica, si è trovata – di fronte alla ripresa della guerra – nella necessità di tornare a pensare in termini geopolitici, essendosi scoperta estremamente vulnerabile alla luce della sua dipendenza dalle importazioni di alcune materie prime. È questo il mondo multipolare, nel quale rivestono una fondamentale importanza sia l’azione politica sia la forza militare: un contesto in cui Berlino si muove tra mille indecisioni, tante quante sono quelle che caratterizzano le sofferte scelte dell’Unione europea, leader mondiale del commercio, ma incapace di intraprendere iniziative diplomatiche che incidano sulle relazioni internazionali.