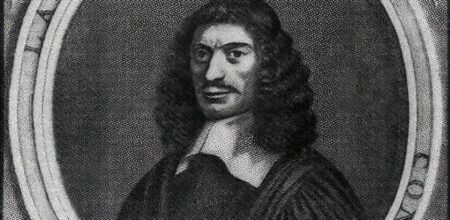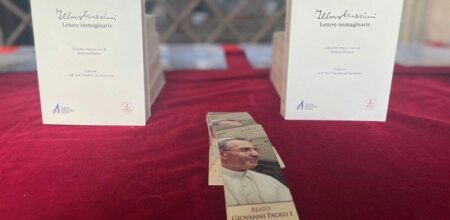|
|
«Questo libro vuole essere l’omaggio a un’arte che fa nascere di nuovo, amorevolmente» (p. 22). Con tali parole, scritte nella Prefazione, il monaco di Bose Matteo Nicolini–Zani, coordinatore del gruppo italiano del Dialogo interreligioso monastico, informa il lettore in merito al significato e allo scopo di questo volume. Ma qual è quest’arte che conduce a una rinascita? È l’arte della meditazione, che sgorga da un’esigenza inscritta nel cuore umano: «L’atto del meditare – afferma Nicolini-Zani – è una dimensione antropologica costitutiva dell’esistenza: meditare humanum est, potremmo dire. Meditare è un atteggiamento umano universale e connaturale all’uomo. Coltivare la meditazione contribuisce all’umanizzazione dell’essere umano» (p. 6).
Attraverso vari interventi, redatti da qualificati studiosi (Axel Bayer, Maciej Bielawski, Pinuccia Caracchi, Patrick Goujon, Jean-Marie Gueullette, Mauricio Yūshin Marassi, Chiara Mascarello, Jacques Scheuer, Francesco Sferra, Benoît Standaert), il lettore viene condotto all’interno di un universo davvero affascinante.
A un’Introduzione dedicata a chiarire che cosa si debba intendere per meditazione, seguono un capitolo sulla meditazione cristiana e uno sulla dimensione spirituale e biblica dell’arte di meditare. Molto interessanti risultano le pagine in cui vengono presentati alcuni autori cristiani che si sono occupati di quella che viene definita «preghiera del cuore» o «preghiera di Gesù»: tra loro spiccano i nomi di alcuni celebri antichi maestri, quali Evagrio Pontico, Giovanni Cassiano, Giovanni Climaco e Isacco di Ninive. Vi è poi un significativo contributo riguardante la specificità della meditazione cristiana. Ampio spazio è stato riservato, infine, al ruolo occupato dalla meditazione nelle grandi tradizioni dell’Oriente, in particolare a quelle induiste e buddhiste.
Nell’ultimo capitolo del libro vengono tratteggiate le linee essenziali di uno sguardo cristiano su tali vie orientali di meditazione. A questo proposito, risultano illuminanti le seguenti considerazioni di Scheuer: «Accettare insegnamenti o ricorrere a pratiche “altre” non suppone di mettere tra parentesi la propria identità. Praticare il discernimento richiede tanto una certa “sospensione” del giudizio, quanto la progressiva formazione di un nuovo giudizio» (p. 239).
Al termine della lettura del libro, si comprende bene ciò che afferma Bielawski: «Il tempo della meditazione […] crea un suo piccolo regno che cresce, non per conquistare la vita quotidiana, ma per fecondarla, arricchirla, insaporirla e renderla più feconda. La meditazione non può sostituire la vita: la vita deve rimanere vita, e al massimo diventare una vita meditativa. Non si vive per meditare, ma si medita per vivere» (p. 7).