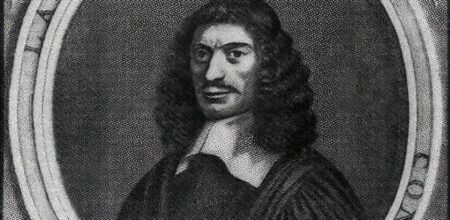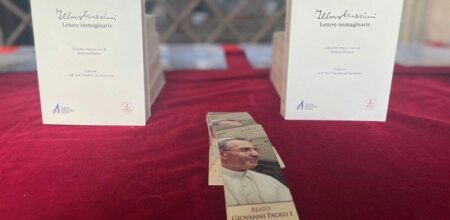Fin dove può spingersi il cinema per sfumare i confini tra realtà e finzione? Quali sono le frontiere tra vero e falso?
Marcello mio (regia di Christophe Honoré, Francia-Italia, 2024), film presentato in concorso all’ultimo festival di Cannes, gioca con lo spettatore e la memoria ancora viva di una «gloria» del cinema italiano e mondiale come Marcello Mastroianni. Il gioco narrativo coinvolge alcune star francesi e internazionali nel ruolo di sé stesse. Innanzitutto, Catherine Deneuve e Chiara Mastroianni, rispettivamente compagna e figlia dell’attore scomparso. A seguire, una ricca galleria di personaggi noti al grande pubblico francese, tra cui Melvil Poupaud e Benjamin Biolay (due ex compagni di Chiara) e Fabrice Luchini.
La bizzarra premessa narrativa stravolge ulteriormente il rapporto cinema-mondo reale: Chiara, stanca di essere considerata come «figlia di», invece di essere apprezzata per il suo talento attoriale, inizia a travestirsi da suo padre e a farsi chiamare «Marcello». Il paradosso è sconcertante: il cinema, l’arte per eccellenza capace di tratteggiare «la realtà mediante la realtà»[1], sfonda i confini del mondo reale, pur rimanendo finzione. Fino a che punto l’aggrovigliato rapporto tra vero e falso può dire qualcosa di vero?
Il regista Honoré è un artista poliedrico: scrittore per adulti e bambini, regista teatrale, sceneggiatore e cineasta, è una presenza eclettica nel panorama culturale francese. La sua versatilità artistica lo rende capace di esplorare le straordinarie possibilità di finzione offerte dal mezzo cinematografico per dire e osservare il mondo con prospettive originali. Con la commedia Marcello mio, il cinema diventa un magico gioco poetico, leggero e nostalgico, aperto sul passato e orientato al futuro.
Dove inizia il «set»?
L’intricato e ambiguo rapporto tra realtà e finzione, tra dimensione attoriale e sfera privata, è affermato con autorialità dalla prima scena. Chiara, il capo ricoperto da una artificiosa parrucca bionda, si appresta a far rivivere, per un servizio fotografico, l’indimenticabile momento de La dolce vita: la «danza» di Anita Ekberg nella fontana di Trevi. Il primo piano di Chiara, avvolta dalla parrucca, mette in luce – per contrasto – la somiglianza dell’attrice con il padre Marcello. L’artificio è stridente: sembra di vedere l’attore stesso interpretare la sua partner del capolavoro felliniano. La fontana è quella di Saint-Sulpice; senza nulla togliere alla piazza parigina, il confronto non regge. Il ritmo incalzante del montaggio, l’atteggiamento rabbioso della sgradevole fotografa ispanofona, la luce «violenta» di una mattinata di piena estate creano un divario incolmabile con l’originale. L’atmosfera incantata
Contenuto riservato agli abbonati
Vuoi continuare a leggere questo contenuto?
Clicca quioppure
Acquista il quaderno cartaceoAbbonati
Per leggere questo contenuto devi essere abbonato a La Civiltà Cattolica. Scegli subito tra i nostri abbonamenti quello che fa al caso tuo.
Scegli l'abbonamento