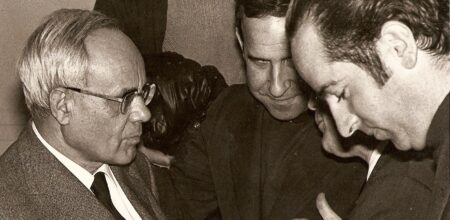|
|
Questo libro esamina un fenomeno preoccupante, ma forse ancora poco avvertito e gravido di conseguenze drammatiche. Si dice che le grandi crisi di civiltà siano anzitutto crisi demografiche. Tuttavia, a differenza delle epoche passate, l’attuale diminuzione di nascite non è legata a fattori imprevedibili – come le carestie, le malattie o le guerre –, ma è una scelta consapevole. In tutto questo l’Italia detiene un triste primato negativo (1,2 figli per donna), che risulta anche dal confronto con Paesi vicini, quali la Germania, in leggera crescita (da 1,33 nel 2016 a 1,54 nel 2019), e la Francia, il Paese europeo che registra il numero di nascite più alto (1,86).
Va però anche precisato che questi due Paesi hanno da anni attuato una politica attenta a promuovere la genitorialità. Per la Germania, si possono ricordare il sistema dei congedi (fino a 14 mesi, e ne può usufruire in parte anche il padre), i servizi per la prima infanzia e i trasferimenti monetari per i figli (219 euro al mese per il primo e secondo figlio, 225 euro per il terzo, e 250 euro per ogni ulteriore figlio), assieme alla possibilità di un assegno supplementare per i meno abbienti. Asili e cure sono gratuiti, ed è prevista una detrazione fiscale per specifiche spese per i bambini fino a 14 anni.
La Francia ha iniziato da più di 40 anni una politica pro-natalità, basata su tre pilastri: la possibilità del part-time nei primi anni di vita dei figli, assegni familiari e diversi altri sussidi «in relazione alle condizioni economiche e alla composizione del nucleo familiare», cui va ulteriormente aggiunto «il celebre quoziente familiare, per cui si pagano le tasse in base al numero dei componenti della famiglia» (p. 50). Ultimo fattore, ma non certo per importanza, è l’agevolazione fiscale.
L’Italia ha finora attuato aiuti di gran lunga inferiori: «La percentuale italiana di spesa in famiglie e minori rispetto al PIL si è attestata sempre attorno all’1% […]. Nel 2019 il dato francese si attesta sul 2,3%, quello tedesco (1,7%) è leggermente inferiore alla media UE (1,8%)». La spesa pro capite mostra un divario ancora più impressionante: «In Germania, nel 2019, era 1.347 euro, in Francia 781 e in Italia 331» (p. 43). Anche il sistema fiscale del nostro Paese non è certamente benevolo nei confronti della natalità.
In ogni caso, nessun Paese europeo raggiunge il minimo richiesto per un ricambio di popolazione (2,2), segno che il problema non è soltanto di tipo politico o economico, ma soprattutto culturale. L’A. lo mostra con le parole dell’economista Leonardo Becchetti: «L’aspetto economico non dice tutto. La carenza di natalità è anche indice di una crisi di generatività, di capacità e voglia di costruire relazioni e progettare futuro […]. Per usare dei termini dell’economia, tale cultura considera le relazioni alla stregua di beni di consumo, da rottamare e sostituire progressivamente, e non beni d’investimento su cui costruire un progetto duraturo» (p. 52).
I capitoli centrali del libro si soffermano sugli aspetti culturali e psicologici che sembrano caratterizzare le nuove generazioni e che sono alla base della scelta di non generare: la precaria condizione economica e occupazionale, la difficoltà a entrare nella fase adulta della vita, l’eccessiva preoccupazione per il benessere personale, un’antropologia che valuta negativamente la genitorialità, perché considerata di impedimento alla realizzazione personale. La denatalità incrocia così problematiche complesse, che segnano un passaggio epocale e mostrano, al di là delle dichiarazioni di principio, una crisi e un disagio crescenti. «L’adulto contemporaneo si avvia a perdere il senso delle stagioni della vita, ognuna con la sua ricchezza e, ancor più, a perdere il senso pieno della libertà che è vera e potente quando in un atto di accoglienza si lega indissolubilmente agli altri esseri umani» (p. 85).
I giovani rischiano così di essere i nuovi poveri, che si vedono rubare il futuro da chi è venuto prima di loro ed è incapace di creare opportunità, senza rendersi conto che in tal modo si prepara il suicidio di un’intera società. È dunque urgente sollevare il problema e mobilitare le risorse a disposizione per offrire ciascuno il proprio contributo, promuovendo la «capacità critica nei confronti della realtà e determinati a non vivere nella banalità dell’effimero» (p. 163). Più che con riflessioni teoriche, l’A. preferisce farlo dando la parola all’esperienza vissuta di alcuni genitori: alla luce dell’attuale contesto culturale, essi «sembrano marziani, però marziani di un mondo desiderabile».