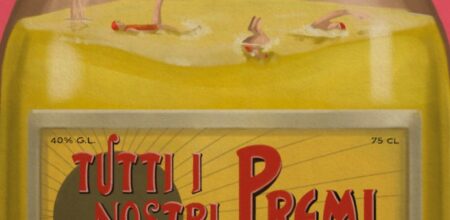|
|
L’A., attualmente parroco e segretario della Curia di Bergamo, in questo volume si interroga sul tema della normalità, mettendola a confronto con possibili sinonimi tendenti a svalutarla: la quotidiana ripetitività della vita ordinaria, la noia, il profilo basso e non appariscente. Invece, le vicende della vita, se vissute con slancio e generosità, non cadono in queste derive. Il libro lo mostra presentando alcune tematiche poste in un ideale ordine alfabetico ed esemplificate da alcuni personaggi del Vangelo, che rappresentano, appunto, l’elogio della normalità: «Loro sono la dimostrazione che la quotidianità è una caccia al tesoro perché ovunque sono nascosti scrigni misteriosi pieni di ricchezze» (p. 5).
Normalità di persone, ma anche di azioni, che mostrano il segreto della vita. Ad esempio, il mangiare, un gesto solo in apparenza ovvio, ma non a caso oggetto della prima grande tentazione e dell’ancora più grande opera di redenzione. In esso si ritrova l’invito a una visione pacificata, capace di unire nella maniera più inaspettata amici e nemici. Come viene indicato in un episodio de Il sergente nella neve, di Mario Rigoni Stern: nel corso della terribile ritirata di Russia il protagonista s’imbatte in un’isba piena di soldati russi; eppure, pur essendo tutti armati, ognuno continua a mangiare tranquillamente; «[una donna] prende un piatto, lo riempie di latte e miglio […]; mi metto il fucile in spalla e mangio […]. Una volta tanto le circostanze avevano portato degli uomini a saper restare uomini» (p. 17).
Questo non significa edulcorare le durezze della vita. Gesù ricorda esplicitamente che i nemici esistono, ma chiede di pregare per loro, perché non sono soltanto «quella cosa». Pur sapendo di essere tradito, Gesù chiama Giuda «amico», rifiutando di rinchiuderlo nel ruolo con cui la tradizione lo ricorderà: «Giuda non è l’iscariota, Giuda è Giuda, innanzitutto “figlio di Simone” precisa il Vangelo […]. Nessuno è mai il suo errore. Nessuno è solo quello che fa» (p. 24). La lezione di Giuda è drammatica, ma preziosa: ammonisce a non disperare mai di una possibilità di riscatto, neppure quando si sbaglia pesantemente, ma a confidare sempre nel Signore. È ciò che ha fatto Zaccheo: «La folla lo giudica squallido. Gesù non si ferma al male del passato, ma intravede il bene nel futuro […]. Ciò che spiazza è la scoperta che Dio crede in me più di quanto io creda in Lui, e quando lo si sente assume un nuovo senso» (p. 136).
La capacità di reagire alle difficoltà viene da un altro personaggio in apparenza marginale, Bartimeo, l’unico tra la folla capace di vedere l’invisibile e di profittare delle occasioni che la vita presenta – Gesù che passa –, senza arrendersi di fronte ai possibili ostacoli, siano essi la cecità o le opinioni della gente. E l’incontro con Gesù cambia completamente la prospettiva. Lo stesso avviene con Cleopa, il discepolo deluso. Gesù lo ascolta, con calma, non ha fretta di dare risposte, ma pone domande che costruiscono una relazione. L’evangelista Luca, per raccontare l’incontro, usa in greco quattro verbi, in un crescendo di intensità: discorrere, spiegare, cercare insieme, interrogare. Gesù non risolve il problema, ma ravviva il cuore, riporta vita in una situazione in cui si vedeva solo morte. «Cleopa è la prova che il primo passo non ti porta dove vuoi, ma ti toglie da dove sei» (p. 157). E Simone di Cirene ricorda l’importanza di prestare aiuto a un bisognoso, anche quando si è costretti, perché ignoriamo con chi abbiamo veramente a che fare.
Si tratta di modalità diverse, che giungono da persone marginali, nelle circostanze più diverse. Esse indicano, tuttavia, sotto sfumature differenti, che il Signore opera nella vita, in situazioni ordinarie e insieme preziose, dove si mostra il significato autentico della «normalità». Perché la vita piena, cercata invano su molteplici strade, è alla portata di chiunque abbia un cuore attento agli incontri quotidiani.
Un testo del card. Martini, scritto pochi giorni prima della sua morte, ne rievoca la testimonianza e il possibile insegnamento per l’oggi, non senza nostalgia: «Dove sono le singole persone piene di generosità come il buon samaritano? Che hanno fede come il centurione romano? Che sono entusiaste come Giovanni il Battista? Che osano il nuovo come Paolo? Che sono fedeli come Maria Maddalena? Io consiglio al papa e ai vescovi di cercare dodici persone fuori dalle righe per i posti direzionali […]. Abbiamo bisogno del confronto con uomini che ardono» (pp. 170 s).