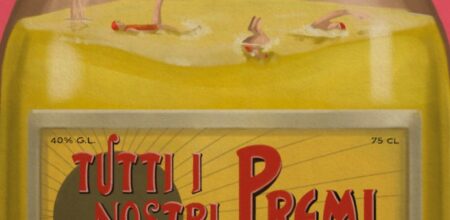Sono trascorsi 60 anni dallo storico viaggio di Paolo VI in Terra Santa, che si svolse dal 4 al 6 gennaio 1964[1]. Questo anniversario cade in un momento molto difficile, a causa del conflitto che lo Stato di Israele sta conducendo nei confronti di Hamas (dopo i tragici fatti del 7 ottobre 2023), in una guerra che ha già prodotto un numero molto alto di vittime (1.200 di parte israeliana e circa 21.000 di parte palestinese) e che purtroppo, nonostante i recenti accordi su una breve tregua e la liberazione di parte degli ostaggi israeliani in cambio di detenuti palestinesi, sembra destinata a continuare. L’obiettivo dichiarato del governo israeliano è quello di sradicare Hamas dalla Striscia di Gaza, e in particolare eliminare i suoi capi, ovunque essi si trovino. Come nel recente passato avevano fatto gli Stati Uniti nei confronti dei capi di Al Qaeda dopo l’11 settembre 2001. Quel «viaggio benedetto», nel quale fu continuamente invocata dal Papa la concordia tra le religioni e tra gli Stati, ci ricorda il valore del bene della pace, che va sempre custodito, anche in questi tempi in cui sembra oscurato e smarrito.
Quel viaggio è considerato giustamente dagli storici come uno degli eventi religiosi più importanti del lungo Novecento. Paolo VI, che era stato eletto al soglio pontificio da meno di un anno, fu il primo pontefice a uscire dal Vecchio Continente e a viaggiare in aereo, a quel tempo simbolo di progresso e di modernità. Soprattutto, era la prima volta che un Papa si recava nel luogo dove aveva avuto origine il cristianesimo: gesto evocativo e necessario, che successivamente avrebbero ripetuto – in altri contesti storici, anche difficili – i suoi successori. Egli visitò come pellegrino i luoghi santi di Gerusalemme e della Galilea e incontrò le comunità cristiane di rito orientale e i loro patriarchi. In particolare, a Gerusalemme avvenne il duplice incontro tra il vescovo di Roma e il patriarca ecumenico di Costantinopoli, Atenagora. Questo diede inizio alla stagione del dialogo ecumenico con le altre Chiese e comunità cristiane. I gesti di accoglienza e di amicizia compiuti in quel contesto anticiparono atti più coraggiosi, come il rimuovere dalla memoria le scomuniche – che erano state comminate nel lontano 1054 – tra le due Chiese sorelle, durante una celebrazione che si tenne contemporaneamente a San Pietro e nella sede patriarcale del Fanar, prima della chiusura del Concilio (7 dicembre
Contenuto riservato agli abbonati
Vuoi continuare a leggere questo contenuto?
Clicca quioppure
Acquista il quaderno cartaceoAbbonati
Per leggere questo contenuto devi essere abbonato a La Civiltà Cattolica. Scegli subito tra i nostri abbonamenti quello che fa al caso tuo.
Scegli l'abbonamento