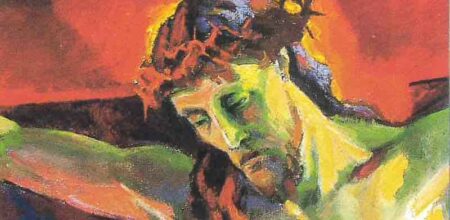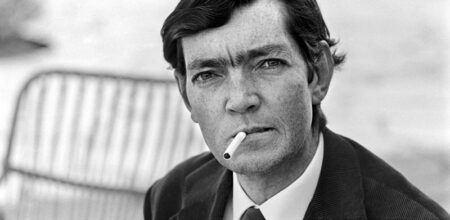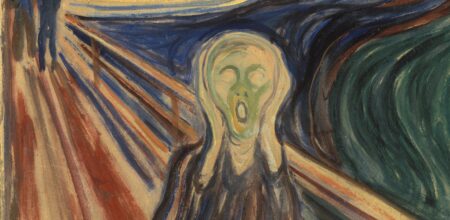|
|
Al giorno d’oggi sono veramente pochi i luoghi rimasti con una natura incontaminata, dove poter stare in solitudine e in silenzio. Anzi, la natura è diventata oggetto di discussioni sociali, anche violente, in nome di un’ecologia da salvaguardare, senza conoscerla realmente. Bisognerebbe, invece, riuscire a immergersi di nuovo nella natura, per riscoprirne la bellezza, come nei secoli passati avveniva con più facilità: ad esempio, nel Rinascimento, ai tempi del grande pittore veneziano Tiziano Vecellio. La scrittrice Monica Ferrando prova a immergersi proprio in questo «sentire la natura», dopo aver osservato, anzi scrutato con molta attenzione, il dipinto del 1507 di Tiziano Fuga in Egitto, conservato all’Ermitage di San Pietroburgo, ma esposto nel 2012 alle Gallerie dell’Accademia di Venezia dopo il suo restauro.
L’idea di questo libro così particolare si inserisce all’interno di un progetto editoriale del filosofo Massimo Cacciari, intitolato Icone, pensare per immagini. Ferrando traccia un percorso accattivante, puntellato da riferimenti eruditi e da citazioni che dimostrano una ricerca accurata e ben documentata. L’iconografia della Fuga in Egitto apre alla prospettiva di un «ritorno in un’Arcadia familiare e sacra al tempo stesso» (p. 9).
Il fine del libro consiste proprio nel riuscire a definire le caratteristiche di questa Arcadia sacra, riabilitandone l’essenza ontologica e le radici antiche. Generalmente il termine rimanda ai componimenti pastorali settecenteschi in letteratura, pittura e musica, che esaltano luoghi ideali e incontaminati o, se si volesse anticiparne il contesto storico, ci si riferisce di solito alla venatura moraleggiante barocca del memento mori, riscontrabile nel famoso quadro di Guercino Et in Arcadia ego.
Al contrario, la natura dipinta da Tiziano, attraversata dalla santa Famiglia in cammino, non ha caratteri di penitenza, ma è un’Arcadia veneziana verdeggiante, musicale (cfr p. 13). Ferrando inizia nel primo capitolo – Concepita tra i monti dell’Irpinia e Napoli, l’Arcadia rivede la luce a Venezia – un percorso di ricerca legato alla storia dell’Arcadia. Per ritrovare il suo significato più oggettivamente consono bisogna risalire al pensiero poetico umanistico, e in particolare all’opera Arcadia di Jacopo Sannazzaro, pubblicata a Venezia nel 1503 senza il consenso dell’autore e a Napoli l’anno seguente con la sua autorizzazione. Qui la natura viene mostrata viva e ispira la poesia. È una vera ode alla semplicità della vita umana, contro il superfluo e il lusso. L’umanità deve saper godere della natura, intesa come paesaggio spirituale, e quindi come luogo dove vivere nella pace. Non mancano i riferimenti agli autori classici – Lucrezio, Virgilio e anche Teocrito –, che descrivono il personalissimo rapporto inscindibile dell’uomo con la natura.
L’A. riesce a dimostrare che l’Arcadia non è luogo ideale e utopico, ma piuttosto un territorio svincolato da situazioni politiche compromesse, dove la natura è lasciata libera e selvaggia, anche con le sue zone pericolose, ma capace, attraverso una propria espressione di sacralità, di riportare in auge l’essenza dell’umanità.
Nel secondo capitolo – Ma Arcadia era già – Ferrando individua i vari «luoghi arcadici» che anticamente si sono succeduti. Ripercorre così varie fonti poetiche e storiche greche e latine, nelle quali sono riscontrabili tracce «arcadiche» degne di nota. All’Arcadia rinascimentale l’A. dà un nome: Venezia, la Venezia dei tempi di Tiziano. Per giungere a questa affermazione elabora il terzo capitolo – Fuga in Arcadia nella Venezia di Tiziano –, in cui analizza filologicamente il dipinto di Tiziano, mostrandone caratteri originali e anche legati alla tradizione pittorica veneziana. Vengono citati, per dei confronti di paesaggi, alcuni dipinti della medesima epoca: la Madonna del Prato e la Sacra conversazione Giovanelli di Giovanni Bellini, e la Tempesta e i Tre filosofi di Giorgione.
Il libro è denso di suggestioni e composto con una scrittura accurata, che va oltre il semplice dato scientifico. È una meditazione aperta che l’A. condivide con chi cerca un’Arcadia sacra, «forse per andarci un giorno, anche noi, ad abitare» (p. 130).