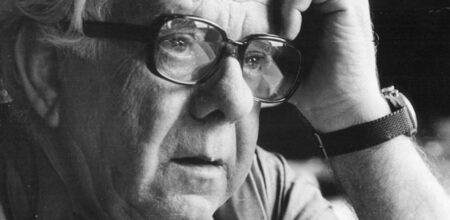|
|
Gli scaffali delle librerie sono ricchi di manuali di scrittura creativa(1). Cominciano ad apparire anche raccolte di testimonianze di scrittori o antologie di loro saggi e diari utili per coloro che intendono imparare a scrivere poesia o un racconto o un romanzo. La domanda che poniamo al lettore all’inizio di queste pagine è la seguente: gli scrittori mistici possono essere assunti, proprio per il loro stile, il loro linguaggio, come guida all’espressione creativa per poeti e narratori?
Ogni spiritualità cristiana non è soltanto un modo di pregare, ma anche un modo di vedere la realtà e di essere al mondo: essa dà «forma» a una vita umana e le conferisce una particolare sensibilità, che si proietta anche in un certo stile di vita. In concreto, chi si riconosce in una via spirituale (benedettina, carmelitana, ignaziana…) non solo vive la sua fede, ma anche la propria esperienza di vita alla luce di un carisma particolare, coinvolgendo anche gli aspetti ordinari dell’esistenza. Sulla base di questa semplice considerazione, in un nostro precedente articolo avevamo affermato che esistono spiritualità cristiane che hanno una ricaduta specifica anche a livello della lettura di un testo letterario(2). In particolare, abbiamo già illustrato il modo peculiare di «lettura letteraria» generato della spiritualità degli Esercizi Spirituali di sant’Ignazio di Loyola.
Esperienza mistica ed espressione creativa
In queste pagine ci soffermeremo sull’esperienza di scrittura che ha generato gli Esercizi ignaziani, chiedendoci se essa possa dare indicazioni utili a uno scrittore. Cercheremo così di segnalare alcuni spunti interessanti per coloro che desiderano imparare a esprimersi in maniera creativa, consapevoli del fatto che «il divino soffio dello Spirito creatore s’incontra con il genio dell’uomo e ne stimola la capacità creativa»(3).
Grandi autori spirituali sono stati anche grandi scrittori, ad esempio gli innografi cristiani(4). Come non pensare poi alla scrittura di Caterina da Siena, di Giovanni della Croce e Teresa d’Avila, mistici ampiamente studiati anche come scrittori. Scoprire poi le assonanze e le affinità fra i grandi mistici e gli scrittori sarebbe un lavoro complesso quanto affascinante. Qui però occorre notare la differenza semplice e radicale tra il mistico e il poeta. Il carattere proprio dell’esperienza poetica è di essere comunicabile. Non si è poeti soltanto per se stessi, ma per un lettore, esplicito o implicito. Il poeta ha il dono di rendere le parole capaci di una comunicazione che ci fa accedere alla sua esperienza. Del mistico invece si deve dire ciò che il grande filologo padre Giovanni Pozzi scrisse di Maria Maddalena de’ Pazzi: «Il suo parlare ignora l’interlocutore umano; parlando ad alta voce, lei non trasmette minimamente informazioni per ascoltatori né immediati né mediati. Perciò il lettore, leggendo le sue pagine, deve sapere che Maria Maddalena non si rivolge mai a lui»(5). A sua volta Giovanni Getto così commenta la scrittura di Caterina da Siena: «Essa conserva nei momenti più ispirati tutta la forza nativa con cui si genera. Un suggestivo senso di movimento viene prodotto da alcuni bellissimi anacoluti, nei quali lo spezzarsi della costruzione contribuisce a creare un’atmosfera vibrata, che è autentica immagine dell’appassionata meditazione della santa»(6). Ma gli esempi sono numerosi, e lo studio della scrittura delle mistiche e dei mistici è ormai molto diffuso(7).
Eppure si intuisce una strada: quella che considera questa scrittura «selvaggia» come guida alla scrittura creativa. Persino Veronica Giuliani — scarsamente alfabetizzata, che scrive perché costretta, e a cui si vieta di rileggere ciò che ha scritto — stimola alla riflessione. La sua competenza linguistica coincide quasi con la pura oralità: ortografia sballata, mancanza di punteggiatura, incapacità di dividere le parole, brachilogie sintattiche, anacoluti…(8). Veronica si rende conto che l’«amore operante in un’anima, opera cose che fanno impazzire. Queste pazzie raccontare non si possono; tuttociò che dico parmi che mi faccia affatto ammutolire. Niente dico di quel che provo; tacendo dirò tutto; dicendo non dico niente»(9). Non è questa una travolgente esperienza di scrittura, sebbene sotto la cifra dell’oralità?
In alcuni casi conosciamo bene le relazioni profonde tra scrittori e mistici: tra Petrarca e Agostino (si pensi al Secretum[10]) o tra Federigo Tozzi e Caterina da Siena, e persino lo spunto che Teresa d’Avila diede a Raymond Carver(11). Non si contano le versioni musicali e le composizioni ispirate dai versi di Giovanni della Croce. Teniamo sullo sfondo l’amplissimo tema dei rapporti tra scrittura biblica e letteratura, sui quali la bibliografia è ampia(12). All’interno di questo compito, dunque, si potrebbe provare a comprendere se e come gli scrittori mistici possano essere assunti, proprio per il loro stile, il loro linguaggio e soprattutto per il loro specifico approccio all’esperienza dello scrivere, come guida all’espressione creativa per poeti e narratori.
Qui cercheremo di comprendere quale tipo di esperienza creativa possa essere generata dagli Esercizi Spirituali di sant’Ignazio di Loyola(13). Procederemo descrivendo il carattere peculiare del testo degli Esercizi e l’esperienza ignaziana di scrittura, cioè l’«attività creatrice che diede vita a quei foglietti che a poco a poco si organizzeranno in “documenti ed esercizi”»(14).
Un testo a raccordi
Innanzitutto occorre precisare che siamo di fronte a un testo di spiritualità alquanto singolare, in quanto esso non prevede la lettura continua. Gli Esercizi sono una guida all’esperienza spirituale, utile innanzitutto a colui che aiuta e accompagna una persona che intende compiere un itinerario interiore alla scoperta della volontà di Dio sulla propria vita. Non un insieme di elevazioni a firma dell’autore, dunque: in brevi ma dense note gli Esercizi indicano un itinerario spirituale, che è stato vissuto da chi li ha scritti. Essi però non risolvono in se stessi l’esperienza spirituale e, perciò, non intendono affatto dire tutto. Non sono il racconto dell’esperienza del santo. Anzi, non sono affatto una «narrazione», né una espressione lirica, ma una «guida», che prevede un interlocutore: innanzitutto chi dà gli esercizi e chi li riceve.
L’interlocuzione degli Esercizi, in realtà, è molto complessa e avviene a parecchi livelli. Lo ha compreso molto bene il semiologo francese Roland Barthes(15). Al di là di alcune prese di posizione che rivelano una incomprensione del significato dell’esperienza spirituale, Barthes invita correttamente a scorgere nel testo degli Esercizi quattro tipi di «testo» o, potremmo dire meglio, di rapporto comunicativo. Li illustriamo in estrema sintesi. Il testo scritto da Ignazio è destinato a chi dà gli esercizi, alla guida. È questo il primo «testo». La guida poi elabora un suo testo che rivolge all’esercitante in un rapporto diretto e adattato alla peculiare personalità dell’altro: è il secondo «testo». A sua volta poi l’esercitante nel suo esercizio spirituale si rivolge a Dio nel linguaggio della preghiera, che costituisce il terzo «testo». Ignazio paragona questo rapporto di comunicazione linguistica a quello che intercorre tra due amici, o tra un servo e il suo padrone: así como un amigo habla a otro, o un siervo a su señor (cfr Es, n. 54). Infine c’è un quarto «testo», ben più difficile da isolare: qui è Dio che risponde all’esercitante o che lo mueve y atrae, cioè lo stimola e lo attrae a sé (Es, n. 175)(16).
Come si nota già da questa descrizione estremamente sintetica dei quattro «testi», gli Esercizi sono una struttura di interlocuzione a raccordi, in cui ogni «attore» riceve e trasmette(17). In questo senso si distinguono nettamente dalle pagine di Caterina da Siena, Veronica Giuliani, Maria Maddalena de’ Pazzi o di Giovanni della Croce. Non sono la narrazione di un’esperienza, ma uno stimolo perchè essa sia vissuta dall’esercitante.
Ogni livello di testo degli Esercizi genera linguaggio creativo. Noi ci soffermeremo principalmente sul primo, cioè quello che è scritto da Ignazio, perché qui egli rivela la sua personale esperienza di scrittura. Il secondo testo genera dialogo, il terzo preghiera, il quarto ispirazione. In particolare il terzo testo è centrato sulla creatività dell’esercitante, cioè del lettore, che è sempre anche un attore(18).
Il linguaggio dell’esperienza
Soffermiamoci sul primo testo con un esempio: quando è il momento di contemplare un mistero della vita di Gesù (i re magi, la conversione della Maddalena, i misteri compiuti sulla croce, le singole apparizioni dopo la resurrezione…), Ignazio non si ferma a raccontare la scena con la ricchezza delle immagini e del linguaggio. Al contrario, sintetizza quel mistero in poche battute, cioè in tre «punti», che ne rivelano la densità e aprono lo spirito alla visione personale. Sono i punti che colui che dà gli esercizi offrirà all’esercitante, a cui spetta — come ben ha intuito Italo Calvino — il compito di «dipingere lui stesso sulle pareti della sua mente degli affreschi gremiti di figure, partendo dalle sollecitazioni che la sua immaginazione visiva riesce a estrarre da un enunciato teologico o da un laconico versetto dei Vangeli»(19). La scrittura di Ignazio non tende a esaurire. Essa è affilata, precisa, ma secca, asciutta, capace più di evocare che di definire ed esaurire la possibilità di immaginare.
Il fine degli Esercizi non è di produrre una conoscenza più esatta della storia di Gesù, ma il coinvolgimento pieno dell’esercitante in quella storia. Molto dunque dev’essere lasciato a ciò che se puede meditar piamente (Es, n. 54), cioè alla libera ricostruzione. Ignazio prevede la libertà creativa di vedere, ad esempio, se la via da Nazareth a Betlemme sia «pianeggiante o se attraversa valli o alture», e se «il luogo o grotta della natività […] sia grande o piccolo, basso o alto» (Es, n. 112). Ciò che a Ignazio interessa è il narrar fielmente la historia in modo che la persona che contempla tenga presente el fundamento verdadero de la historia (Es, n. 2). Il facile spagnolo di queste affermazioni fa comprendere come la fedeltà alla storia non si opponga affatto alla meditazione «pia», e dunque libera di ricostruire creativamente. Anzi, ne è il suo necessario presupposto.
Lo aveva compreso perfettamente la scrittrice Marguerite Yourcenar, la quale nel suo taccuino di appunti scriveva, a proposito del suo capolavoro Memorie di Adriano ambientato nel II secolo d.C.: «Le regole del gioco: imparare tutto, leggere tutto, informarsi di tutto e, al tempo stesso, applicare al proprio fine gli esercizi di Ignazio di Loyola»(20). Questo metodo si condensa nell’espressione: como si presente me hallase, cioè «come se mi trovassi lì presente» (Es, n. 114). E infatti prosegue la Yourcenar: «Perseguire l’attualità dei fatti, cercare di rendere a quei volti la loro mobilità, l’agilità della cosa viva. […] eliminare finché è possibile tutte le idee, i sentimenti che si sono accumulati, strato su strato, tra quegli esseri e noi»(21). Il linguaggio della narrativa è, in questo senso, il linguaggio dell’esperienza.
Il testo è una porta di ingresso
Gli Esercizi ignaziani dunque possono suggerire una forma di scrittura dove l’espressione è essenziale, a tratti anche scabra, minimalista o, meglio, precisa. La precisione ignaziana elimina ogni situazione astratta, rarefatta o sentimentale. Ciò che va meditato deve essere visto, sentito, toccato, anche se con i sensi spirituali e con l’immaginazione. Il mistero non è mai evanescente, ma sempre storico e concreto. Ha commentato in maniera pertinente Italo Calvino: «L’idea che il Dio di Mosè non tollerasse d’essere rappresentato in immagine sembra non sfiorare mai Ignacio de Loyola. Al contrario, si direbbe che egli rivendichi per ogni cristiano la grandiosa dote visionaria di Dante e di Michelangelo – senza neppure il freno che Dante si sente in dovere di mettere alla propria immaginazione figurale di fronte alle supreme visioni celesti del Paradiso»(22).
Il sentimento legato alla rappresentazione dei misteri di Gesù non è mai espresso. Ignazio usa il sentimento in maniera straordinariamente parca ed essenziale. Il dolore per Gesù crocifisso non va descritto, né dev’essere esaurito dalla prosa dello scrittore. Occorre invece presentare e descrivere il mistero storico, cioè il fatto, perché il sentimento nasca nel cuore dell’esercitante: «Non c’è ferro che possa trafiggere il cuore con più forza di un punto messo al punto giusto», aveva scritto Maupassant. La scrittura ignaziana mette in fila le parole giuste, le immagini precise, ma anche la punteggiatura più efficace e adeguata.
Il testo dunque è una porta di ingresso nella storia narrata. Sovraccaricare il lettore di dettagli significherebbe esaurire lo spazio della sua immaginazione, limitarlo. Il coinvolgimento è la condizione perché la lettura si faccia esperienza e metta in gioco «le facoltà immaginative e percettive del lettore, al fine di fargli aggiustare e differenziare la sua messa a fuoco»(23). È necessario uno spazio vuoto, che il lettore cerca di riempire per una buona continuazione della lettura. Questi spazi vuoti, il non detto, le lacune, le reticenze dunque ostacolano la continuazione e, nello stesso tempo, stimolano il processo di costruzione delle immagini. I testi letterari non possono avere la determinatezza degli oggetti reali e, anzi, è proprio tale indeterminatezza che consente al testo di comunicare col lettore.
Ignazio di Loyola ha scritto un testo per leggere il quale occorre in realtà «esercitarsi». Per questo il suo autore spiega il titolo stabilendo un parallelo con gli esercizi fisici. Egli precisa: «Come il passeggiare, il camminare e il correre sono esercizi corporali, analogamente si chiamano esercizi spirituali i vari modi di preparare e disporre l’anima…» (Es, n. 1). Ogni lettura così può diventare una performance. Ignazio non descrive l’esperienza degli Esercizi, ma la introduce, la orienta, la stimola, ne suggerisce le condizioni.
Scrittura e biografia
Ignazio scrive secondo criteri precisi. La scrittura degli Esercizi non è narrativa, ampia, fluviale; non è neanche lirica o ermetica. L’origine è carismatica e, dunque, biografica: il testo è la traduzione in metodo del suo cammino spirituale. Tra testo e biografia, in realtà, c’è un rapporto stretto. Tuttavia non è la sua pura e semplice trascrizione narrativa. Ignazio accettò — e non senza resistenze e con molte interruzioni — di raccontare la sua vita in terza persona, ma non di scriverla di proprio pugno(24). A trascrivere il suo racconto fu un compagno gesuita portoghese, Luis Gonçalves da Câmara. Per questo l’Autobiografia ignaziana è uno strumento molto importante per comprendere gli Esercizi Spirituali. Essa narra il pellegrinaggio spirituale di Ignazio dalla conversione a una crescente purificazione e unione con Dio in termini di preghiera e di servizio.
Sin dall’inizio, l’esperienza della scrittura ebbe per lui un ruolo importante. Durante la convalescenza successiva al ferimento avvenuto nel corso della battaglia di Pamplona, egli si trovò casualmente a leggere libri spirituali: di libri di altro genere in quella casa non ce n’erano. Poiché nella lettura di questi libri provava molto gusto, «gli venne l’idea di stralciare alcuni passi più significativi della vita di Cristo e dei santi. Perciò […] si mise a compilare con molta diligenza un libro. Esso arrivò a occupare quasi 300 fogli, in quarto, completamente scritti. Scriveva le parole di Gesù in rosso, quelle di nostra Signora in azzurro, su carta lucida a righe, con elegante scrittura, mettendo a profitto la sua grafia molto bella. Impiegava il suo tempo in parte a scrivere, in parte a pregare»(25). Ignazio dunque scrive perché ricopia frasi che lo colpiscono.
La crescita spirituale successiva a questi inizi si riflette nelle settimane degli Esercizi. Ignazio non dice nulla circa le tappe della loro redazione. Alla fine del suo racconto autobiografico, rispondendo a una domanda del p. Gonçalves da Câmara, disse che «gli Essercitii non gli haveva fatti tutti in una volta, senonché alcune cose che lui osservava nell’anima sua et le trovava utili, gli pareva che potrebbero anche essere utili ad altri, et così le metteva in scritto, verbi gratia, dello examinar la conscientia con quel modo delle linee, etc. Le electioni spetialmente mi disse che le haveva cavate da quella varietà di spirito et pensieri, che haveva quando era in Loyola, quando stava anchora malo della gamba»(26). Così abbiamo una conferma del fatto che lo scrivere è maturato a partire dall’accadere e motivato dal desiderio di giovare.
L’importanza dell’osservazione
Il primo elemento è dunque l’«osservare» ciò che accade. Nel suo uso parco e circostanziato della parola scritta, Ignazio attribuisce all’osservazione un ruolo fondamentale. Egli raccomanda di annotare sempre le parti che si avvertono come più importanti nelle contemplazioni, cioè quelle nelle quali si comprende qualcosa o si hanno reazioni affettive di consolazione o desolazione (cfr Es, n. 118). Il suo Diario Spirituale rappresenta un documento esemplare, che consente di constatare come Ignazio scrivesse ogni giorno quello che osservava accadere in lui. La scrittura ignaziana nasce dall’esperienza capace di coinvolgere mente (conocimiento) e affettività (consolación, desolación), non da elucubrazioni teoriche o da pure ipotesi. Non risponde a una combinatoria astratta, ma a una sorta di reportage che prevede sempre un quaderno di appunti nel quale annotare siempre algunas partes más principales (Es, n. 118).
Per questo motivo, gli Esercizi hanno generato molta scrittura: ogni esercitante ha avuto nei secoli fino ad oggi il proprio quaderno di appunti. È un’atteggiamento che nello scrittore diventa decisivo. In alcuni casi gli appunti sono vere e proprie opere originali. È il caso, ad esempio, degli appunti del poeta Gerard Manley Hopkins(27), dei testi raccolti nell’antologia Hearts on Fire(28) o dello splendido volume Thirty Days del poeta e critico letterario statunitense Paul Mariani(29). Ma questi sono soltanto alcuni esempi.
Ignazio dunque insegna che si scrive perchè si osserva interiormente qualcosa, perchè ci si è trovati in una condizione che ha aperto gli occhi, che ha fatto vedere meglio la vita, il mondo, un oggetto, la realtà(30). Soprattutto perché la fantasia permette a chi scrive di stabilire con la propria esperienza un rapporto più intenso, a tal punto da osservare o da provare sentimenti o avere pensieri anche non comuni, ordinari e ovvi(31).
Il criterio dell’«utilità»
L’accentuazione sull’osservazione è importante, ma non sufficiente nella prospettiva ignaziana. Ignazio scrive gli Esercizi non per puro diletto personale, ma per riavviare l’esperienza propria o altrui. Scrivere è frutto dell’esperienza filtrata dall’«utilità», perché è trampolino di lancio per un’ulteriore esperienza, quella dell’esercitante. Ignazio non annota tutto, ma soltanto le cose che trovava utili e gli pareva che potessero essere utili anche ad altri(32). Ovviamente l’appello all’«utilità» può lasciare interdetto chi intende scrivere in maniera libera e creativa. Come può una simile esperienza di scrittura «utilitaristica» aiutare o ispirare uno scrittore? In realtà, la domanda potrebbe essere il frutto di un fraintendimento. Infatti va tenuto presente che, nel momento in cui scrive, Ignazio si pone in un orizzonte di comunicazione. Se il testo non comunica, è «inutile». Ignazio ha davanti a sé un lettore, almeno implicito. L’appello all’utilità ha il significato preciso di puntare l’attenzione su una persona che sta al di là del libro. Scrivere non è, in questo senso, un atto narcisistico di pura espressione di sé. È un atto comunicativo rivolto ad altri.
Anzi Ignazio, in quanto autore, sparisce dal suo testo(33). Si nasconde fino all’estremo quasi paradossale: quando egli parla in prima persona negli Esercizi, il soggetto non è lui! Il pronome «io», prima persona singolare, è di ordine didattico e favorisce una identificazione personalizzata con il testo, abolendo la distanza della terza persona (cfr Es, n. 58)(34). L’«io» è lo stesso esercitante, il lettore. Così, mentre molti testi mistici si servono della poesia, il testo degli Esercizi mira all’economia linguistica, alla sobrietà di espressione, per stabilire una distanza dell’autore e una «deriva» del testo, che appunto è lasciato in balìa, se così possiamo dire, dell’esercitante e al suo personale rapporto col Signore, all’interno del quale si compie la scelta degli «esercizi» da fare. In questo orizzonte «altruistico» è il senso dell’utilità del testo.
Quindi scrivere ignazianamente non è pura espressione o esibizione di sé. Il narcisismo sembra non avere il minimo spazio, e non c’è niente di più distante da questa scrittura dell’esibizionismo. Scrivere significa selezionare qualcosa tra l’esperienza e le tante cose da dire. Tagliare, selezionare, essenzializzare, ridurre all’osso non è un vuoto esercizio stilistico, ma un’arte comunicativa. È un lavoro di scavo, dunque. Infatti, il vocabolo che Ignazio usa per le sue parole è il participio «cavate»(35). Esso sembra implicare un lavoro profondo di delucidazione e formulazione, che ricorda gli intensi versi di Giuseppe Ungaretti: Quando trovo / in questo mio silenzio / una parola / scavata è nella mia vita / come un abisso (Commiato).
L’uso ignaziano della parola
Ignazio conserva sempre l’attitudine alla concisione: parla poco, e la sua parola è nuda e chiara. Non ama le esagerazioni, per cui la sua lingua è molto parca in aggettivi e superlativi. Nota con semplicità, senza orpelli, consiglia in modo diretto. Pensa molto a ciò che dice e come lo dice e a chi. Non è mai stato un predicatore, ma proprio con la parola ha realizzato le sue conquiste decisive: la conversazione è la sua arte, non certo un artificio umanistico, nè, tanto meno, esibizione. Egli corregge senza sosta i suoi scritti e li lima per bene. Ciò comporta una lettura lenta e calma per cogliere i particolari, che egli espresse mediante la cesellatura di ogni frase. È significativo il fatto che di lui non abbiamo nessun brano di oratoria o di catechesi. Egli è maestro del dialogo interpersonale, nella comunicazione profonda, non in quella esteriore o di circostanza(36).
Tutto ciò denota una cura massima della parola, di ogni singola parola, e dell’espressione. Quando espone l’esame generale di coscienza, egli consiglia di pesare il valore della parola e conoscere la sua direzione (Es, nn. 38-41). L’equilibrio nell’uso della parola è un indice della conversione e dell’orientamento del cuore e del pensiero. L’esercitante deve «chiedere conto all’anima […] delle parole» (Es, n. 43). Ignazio detesta la palabra ociosa (Es, n. 40), cioè quella inutile e vuota che non serve a niente e non è «utile» a nessuno.
Nell’itinerario spirituale proposto dagli Esercizi, uno dei modi di pregare «consiste nel contemplare il significato di ogni parola della preghiera» (Es, n. 249). Ogni parola va pesata, e il suo significato è chiamato ad allargarsi come i cerchi concentrici prodotti da una pietra che cade nell’acqua. Ignazio prevede «occhi chiusi o fissi in un punto, senza girarli qua e là»; poi chiede di pronunciare una sola parola della preghiera (ad esempio, «Padre» nella preghiera del «Padre nostro»). Così chiede a chi si esercita spiritualmente di riflettere «su questa parola per tutto il tempo che, nelle considerazioni pertinenti a tale parola, troverà significati, paragoni, gusti e consolazioni» (Es, n. 252).
La sua è una sorta di ermeneutica di assonanze interiori che non tollera tempi rigidi né eccessiva quantità di parole: in «una o due parole» soltanto si può trovare «molta materia di meditazione, insieme a gusto e consolazione» (Es, n. 254). Infatti «non il molto sapere sazia e soddisfa (harta y satisface) l’anima, ma il sentire e gustare (sentir y gustar) le cose internamente» (Es, n. 2). Si può dunque restare fermi su una sola parola della preghiera anche per tutto il tempo dell’esercizio. Nel «terzo modo di pregare» Ignazio propone la ripetizione di una singola parola al ritmo del movimento respiratorio «in modo tale che una singola parola venga detta tra un respiro e l’altro» (Es, n. 258). Chiunque scriva un’opera di qualche valore letterario trova in queste indicazioni sul valore di ogni singola parola una guida sicura all’espressione concisa, essenziale, ma insieme anche capace di dare «respiro». È questa la vera parola poetica, precisa, puntuale e pregna di significati e suggestioni.
Gli Esercizi come manuale di espressione creativa
Gli Esercizi Spirituali non sono propriamente né un testo poetico né un testo narrativo, né un saggio, né un diario. Essi sono una guida, un vero e proprio manuale di espressione creativa tra l’esercitante e Dio. Negli Esercizi la contemplazione non è utile solamente a raggiungere una pura passività: all’esercitante serve per imparare a parlare con Dio, a inventare un linguaggio di interlocuzione. La contemplazione produce linguaggio.
Questa palestra di creatività non può che plasmare tutta l’esistenza dell’essere umano, non semplicemente la sua preghiera, i suoi momenti di orazione. L’esercizio spirituale, se ben inteso e vissuto, offre un allenamento che irrobustisce la capacità espressiva e comunicativa dell’uomo in ogni ambito della sua esperienza di vita. Riprova di tale connessione è il fatto che, viceversa, si moltiplicano i manuali di scrittura creativa che fanno spesso riferimento — in un modo o nell’altro, in maniera pertinente o ambigua — alla dimensione «spirituale»(37), proponendo la crescita nella capacità di scrivere in parallelo a un progresso nella vita interiore(38). Ciò non significa, ovviamente, che colui che compie il cammino proposto dagli Esercizi diventi come per incanto anche scrittore (o musicista o pittore…). Significa se mai che egli vive un’esperienza che gli dà modo y orden (Es, n. 2), cioè un metodo di espressione spirituale che fa intimamente appello alle sue più profonde risorse creative. La principale è l’apertura radicale all’evento dell’ispirazione, intesa come qualcosa che lo raggiunge dall’esterno, da un «altro».
Ma questo manuale non assomiglia a un orario ferroviario. Se mai, se vogliamo rimanere nel paragone manualistico, potrebbe essere più vicino a un ricettario di cucina quale l’Artusi(39). In realtà, come ha riconosciuto il poeta Giovanni Giudici, traduttore degli Esercizi, questo libretto ha un «fascino, malgrado tutto, letterario» e lo si può considerare e tradurre come un «testo poetico»(40). Sono, infatti, frutto di una peculiare esperienza spirituale e creativa di ispirazione. Afferma Giudici, forte della sua affinità con il linguaggio poetico, che essi sono «un’opera che, nata in una sfera istituzionale assolutamente estranea alla letteratura, in forza della passione da cui fu ispirata partecipa dei più alti valori di letterarietà. Il suo stile povero diventa perciò […] “grande stile”; le sue incongruenze sintattiche diventano procedimenti di “lingua poetica”; le sue trasandatezze, i suoi ad sensum ed anche certe apparenti ambiguità agiscono come elementi di seduzione: proprio perchè su ogni altra preoccupazione e su ogni altro intento prevale appunto l’urgenza delle cose da dire, anzi da fare»(41).
Stile sobrio, cura peculiare dell’osservazione, spiccata capacità di valorizzare ogni singola parola, intensità comunicativa rendono la scrittura di Ignazio di Loyola un contributo importante per coloro che sentono il desiderio di imparare a mettere per iscritto qualcosa della loro «varietà di spirito et pensieri».
1 Per «scrittura creativa» si intende quella che non ha solamente lo scopo di comunicare informazioni in maniera efficace e funzionale (una relazione, uno scritto accademico, una ricetta medica…), ma ha anche una funzione espressiva e una forte connotazione estetica. È un altro modo per parlare di «scrittura letteraria».
2 A. SPADARO, «La lettura come immersione interattiva. Tra “Esercizi Spirituali” e “Realtà Virtuale”», in Civ. Catt. 2004 II 37-49. Cfr L. COCO (ed.), L’atto del leggere. Il mondo dei libri e l’esperienza della lettura nelle parole dei Padri della Chiesa, Magnano (Bi), Qiqajon, 2004.
3 GIOVANNI PAOLO II, Lettera agli artisti, n. 15.
4 Pensiamo alle opere di grandi teologi che componevano inni, come Prudenzio, Efrem il Siro, Gregorio Nazianzeno, Ambrogio di Milano, Paolino da Nola, Andrea di Creta, Romano il Melode, Venanzio Fortunato, Adamo di San Vittore, ma anche Bonaventura e Tommaso d’Aquino. L’elenco è vastissimo.
5 G. POZZI, «Introduzione», in M. M. DE’ PAZZI, Le parole dell’estasi, Milano, Adelphi, 1984, 26.
6 G. GETTO, Letteratura religiosa del Trecento, Firenze, Sansoni, 1967, 196 s.
7 Per una prima introduzione al linguaggio dei mistici cfr M. BALDINI, Il linguaggio dei mistici, Brescia, Queriniana, 19902.
8 Cfr G. POZZI, «Il “parere” autobiografico di Veronica Giuliani», in Strumenti critici II (1987) n. 2, 178.
9 Citato in M. BALDINI, Il linguaggio dei mistici, cit., 70.
10 Il Secretum è un trattato in latino in tre libri composto dal Petrarca tra il 1342 e il 1343, ma ritoccato successivamente. Ogni libro corrisponde alle tre giornate di discussione che il poeta immagina di sostenere con sant’Agostino alla presenza muta di una figura di donna, che è la Verità. È una sorta di testamento spirituale.
11 Cfr l’antologia di testi cateriniani curata da Tozzi: CATERINA DA SIENA, Le cose più belle [1918], Firenze, Le Lettere, 1996; R. CARVER, «Meditazione su una frase di santa Teresa», in Id., Il mestiere di scrivere. Esercizi, lezioni, saggi di scrittura creativa, Torino, Einaudi, 1997.
12 A parte il fondamentale N. FRYE, Il grande codice. La Bibbia e la letteratura, Torino, Einaudi, 1986, consigliamo: R. ALTER, L’arte della narrativa biblica, Brescia, Queriniana, 1990.
13 Un’intuizione sul rapporto tra Esercizi Spirituali e scrittura creativa l’abbiamo trovata in G. MOZZI, Parole private dette in pubblico. Conversazioni e racconti sullo scrivere, Roma – Napoli, Theoria, 1997.
14 M. GIULIANI, «Lo scritto e il silenzio. All’origine degli Esercizi Spirituali di Ignazio di Loyola», in Ignazio di Loyola e gli Esercizi Spirituali, supplemento a Notizie dei Gesuiti d’Italia 25 (1992) n. 6, 57.
15 Cfr R. BARTHES, Sade, Fourier, Loyola. La scrittura come eccesso, Torino, Einaudi, 1977.
16 I rapporti però, a ben guardare, sono più dei quattro descritti da Barthes. Esiste un rapporto tra l’esercitante e il direttore, cioè il reciproco del secondo rapporto. Non si può tacere il rapporto reciproco anche tra il direttore e Dio: si tratta di un rapporto sfumato, appena accennato tra le righe da Ignazio, e più in termini negativi di «lasciar fare» più che di «fare». Potremmo ricordare anche una rete di rapporti che sono documentati, ad esempio, dai Direttorî, costituiti da coloro che danno gli Esercizi: colui che li dà deve innanzitutto averli ricevuti e praticati. E, infine, notiamo che non bisogna dimenticare un altro «testo», cioè quello che Dio rivolge a Ignazio, il quale descrive nell’Autobiografia con una breve frase la modalità di questo rapporto: «Dio si comportava con lui come fa un maestro di scuola con un bambino: gli insegnava» (Autobiografia, n. 27).
17 Questa comunicazione non è scontata: l’esercitante non sa nulla in anticipo sulle esperienze che gli verranno proposte, come il lettore di un romanzo che vive la suspense propria della trama. Neanche il rapporto tra Dio e l’esercitante può essere prevedibile.
18 Ci siamo già occupati di questo «testo» in un nostro precedente articolo: «La lettura come immersione interattiva»…, cit.
19 I. CALVINO, Lezioni americane. Sei proposte per il prossimo millennio, Milano, Mondadori, 1993, 96 s.
20 M. YOURCENAR, Memorie di Adriano, Torino, Einaudi, 1988, 289.
21 Ivi.
22 I. CALVINO, Lezioni americane…, cit., 95.
23 W. ISER, L’atto della lettura. Una teoria della risposta estetica, Bologna, il Mulino, 1987, 26.
24 In realtà sembra che egli abbia raccontato non tanto i suoi successi quanto le proprie debolezze e la forza della presenza del Signore nella sua vita.
25 Ignazio di Loyola, s., Autobiografia, n. 11.
26 Ivi, n. 99 (corsivo nostro). Qui citiamo il testo originale che è in italiano dell’epoca. Infatti, come scrive il p. Gonçalves, trovandosi a Genova e non avendo più a disposizione un amanuense spagnolo, egli dettò in italiano gli appunti che aveva portato con sé da Roma. Era il dicembre 1555.
27 Cfr C. DEVLIN, The Sermons and Devotional Writings of Gerard Manley Hopkins, London, Oxford University Press, 1967. I testi sono tradotti parzialmente in L. DEL ZANNA (ed.), Gli Esercizi spirituali di S. Ignazio commentati dal poeta Gerard Manley Hopkins, S.J. (1844-1889), Firenze, Mir, 2000.
28 Cfr M. HARTER (ed.), Hearts on Fire. Praying with Jesuits, Chicago, Loyola Press, 20052.
29 Cfr P. MARIANI, Thirty Days on Retreat with the Exercises of St. Ignatius, New York, Viking Compass, 2002.
30 Consigliamo la lettura del racconto di C. S. Lewis dal titolo «L’uomo nato cieco», in Prima che faccia notte. Racconti e scritti inediti, Milano, Rizzoli, 2005, 29-44.
31 Cfr il nostro «La fantasia: evasione o visione?», in Civ. Catt. 2005 II 28-39.
32 Il criterio dell’utilità è stato ben esposto in M. GIULIANI, «Lo scritto e il silenzio», cit.
33 Lo ha ben illustrato P.-H. Kolvenbach nel suo «Gli Esercizi Spirituali di sant’Ignazio. Il messaggio spirituale attraverso le particolarità linguistiche», in Civ. Catt. 1997 I 351-364.
34 Cfr ivi, 352 s.
35 Ignazio di Loyola, s., Autobiografia, n. 99.
36 Cfr I. TELLECHEA IDIGORAS, Ignazio di Loyola solo e a piedi, Roma, Borla, 1990, 407-410.
37 All’aggettivo, specialmente in area anglofona, si dà una valenza ben più ampia rispetto a quella a cui siamo abituati. Esso corrisponde a una sorta di generica ricerca di senso.
38 Cfr, ad esempio, N. GOLDBERG, Scrivere zen. Manuale di scrittura creativa, Roma, Ubaldini, 1987. Cfr anche J. CAMERON, La via dell’artista. Come ascoltare e far crescere l’artista che è in noi, Milano, Longanesi, 1992. L’autrice ha scritto numerosi titoli di grande successo sull’argomento. È interessante notare che proprio The Artist’s Way compone un itinerario articolato in «settimane» come quello degli Esercizi ignaziani.
39 Pellegrino Artusi (1820-1911) fu gastronomo e scrittore. Compose in stile brioso un libro di culinaria di grande successo dal titolo La scienza in cucina o l’arte di mangiar bene, oggi conosciuto col solo cognome del suo autore.
40 G. GIUDICI, «“Gli Esercizi spirituali” come testo poetico», in IGNACIO DE LOYOLA, Esercizi spirituali, Milano, Mondadori, 1984, 7.
41 Ivi, 15. L’unica parola che giudichiamo errata nell’affermazione di Giudici è «seduzione». In nessun modo e a nessun titolo la si può attribuire al testo ignaziano, che è «eccessivo» (cioè eccede, porta fuori di sé, come abbiamo visto) e per natura sua mai, appunto, seduttivo (nel senso che tende a centrare l’attenzione su di sé).