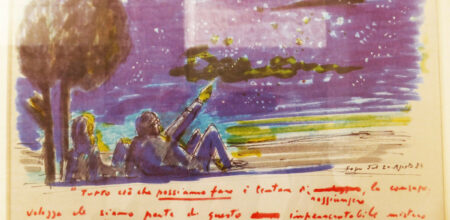|
|
Nel discorso al Corpo diplomatico accreditato presso la Santa Sede per gli auguri del nuovo anno, papa Francesco ha ricordato i 500 anni dalla morte di Raffaello Sanzio, «il grande artista di Urbino, deceduto a Roma il 6 aprile 1520»; a lui «dobbiamo un ingente patrimonio d’inestimabile bellezza. Come il genio dell’artista sa comporre armonicamente materie grezze, colori e suoni diversi rendendoli parte di un’unica opera d’arte, così la diplomazia è chiamata ad armonizzare le peculiarità dei vari popoli e Stati per edificare un mondo di giustizia e di pace, che è il bel quadro che vorremmo poter ammirare»[1].
Il Papa ha poi proseguito, sottolineando altri due meriti di Raffaello. Il primo: che lui «è stato un figlio importante di un’epoca, quella del Rinascimento, che ha arricchito l’umanità intera. Un’epoca non priva di difficoltà, ma animata da fiducia e speranza». Il secondo merito è quello di aver dedicato alla Madonna diversi quadri: «Uno dei soggetti preferiti della pittura di Raffaello era Maria. A lei ha dedicato numerose tele che possono oggi essere ammirate in diversi musei del mondo»[2]. Papa Francesco ha colto bene una delle caratteristiche del grande artista: nel dipingere la Madonna, raffigurata quasi sempre con il Figlio, Raffaello ha fissato una tipologia che ha avuto un grande successo religioso e sociale nella storia delle raffigurazioni mariane tramandate lungo i secoli fino al Novecento[3].
La bellezza e l’armonia
Raffaello Sanzio nasce a Urbino nel 1483. Il padre è pittore e letterato, e dà al figlio le prime nozioni d’arte. Il ragazzo è favorito anche dall’ambiente culturale urbinate dei duchi di Montefeltro, dove Piero della Francesca aveva lasciato l’impronta della sua presenza. Dopo la morte precoce del padre, Raffaello entra a far parte degli allievi del Perugino, il caposcuola umbro alla fine del secolo, che si era formato a Firenze con il Verrocchio, insieme con Lorenzo di Credi e Leonardo da Vinci. Il Perugino interpreta l’arte di Piero in forme semplificate e aggraziate: in tali modalità giunge a Raffaello. Questi, a sua volta, dalle opere del grande Piero sa mutuare quella limpidezza cristallina – sia nella sfera prospettica sia nei rapporti tra spazio e figura – che in seguito lo accompagnerà sempre.
Il Perugino, ormai giunto all’apice della fama, volge al tramonto: il giovane Raffaello vive la crisi interiore della concezione artistica del maestro e del Signorelli, che vedono l’arte come comunicazione ed esortazione, con una funzione sociale e spirituale.
L’occasione per farsi conoscere Raffaello la trova a Città di Castello quando la famiglia Albizzini, nel 1504, gli commissiona uno Sposalizio della Vergine per la chiesa di San Francesco. È il primo dipinto in cui egli mette in rilievo la firma e la data, proprio al centro della tela, sul frontale del tempio che sovrasta la scena: «Raffaello Urbinas 1504». Qui egli valorizza l’idea di fondo dello stesso quadro che il Perugino sta dipingendo per la Cappella della reliquia dell’anello nuziale della Vergine, nel duomo di Perugia: quasi una sfida tra l’allievo e il maestro. Il maestro riprende lo schema della Consegna delle chiavi (1484, nella Cappella Sistina): un primo piano con l’episodio biblico, e sullo sfondo il tempio e due archi trionfali. L’affresco era stato celebrato come una delle migliori costruzioni prospettiche del Quattrocento.
Raffaello stravolge il taglio dell’immagine: innanzitutto esalta la prospettiva e il senso dello spazio generato dal lastricato del pavimento e dalla struttura architettonica del tempio (che ricorda quello di San Pietro in Montorio, del Bramante), e poi sa dare ai personaggi una vitalità sorprendente, mantenendoli nelle pose più naturali e ritraendoli partecipi in diversi modi all’evento. Sulla destra, san Giuseppe emerge con il suo ramo fiorito tra i pretendenti delusi (uno perfino spezza il bastoncino secco sul ginocchio); a sinistra, Maria richiama l’attenzione delle fanciulle che, trasognate, le fanno corona. I gruppi formano due curve: una verso l’interno, che riecheggia quella frontale del tempio; l’altra verso l’esterno, che pare includere gli spettatori nella scena.
Completamente diverse invece sono le figure che il Perugino va dipingendo nello Sposalizio della Vergine: sono personaggi rigidi, statici, quasi delle comparse che non generano spazio e che sembrano non partecipare a una cerimonia così solenne. In breve, Raffaello ha dipinto un capolavoro da ammirare: l’allievo, con la novità della sua visione dello spazio e dell’espressione dei volti, supera il maestro. Tuttavia, come nota il critico Strinati, ci troviamo di fronte a un’opera che fa pensare: «L’analisi minuta del dettaglio ha un tratto epico e il grande dipinto umanistico denota la bravura della mano ma anche l’ambiguità della proposta in esso implicitamente contenuta. Con lo Sposalizio della Vergine Raffaello dimostra compiutamente di essere il pittore più bravo e più capace. L’opera è eccelsa, ma la cultura che vi è sottesa potrebbe essere sospetta di un vizio di sterilità perché completamente volta verso il passato»[4]. Giudizio rigoroso e qualificato, eppure l’artista ha solo 21 anni ed è tutto proiettato verso il futuro.
L’esperienza fiorentina
Dopo il primo successo, Raffaello sente l’esigenza di sviluppare le sue esperienze, e per lui diventa imprescindibile guardare a Firenze, per ripercorrere l’itinerario fiorentino del maestro, allievo del Verrocchio. Egli porta con sé una lettera di presentazione di Giovanna da Montefeltro, sorella di Guidobaldo, per il gonfaloniere della Repubblica fiorentina, Pier Soderini. Reca la data dell’1 ottobre 1504.
Prima della fine dell’anno Raffaello giunge a Firenze, dove intanto si sono affermati i due grandi geni del Rinascimento italiano: Leonardo da Vinci (1452-1519) e Michelangelo Buonarroti (1475-1564) si contendono il primato nell’agone fiorentino. Raffaello rimane meravigliato di quanto hanno dipinto, scolpito, e vanno sperimentando nella Sala del Gran Consiglio di Palazzo Vecchio. Fiuta subito le novità, capisce che essi sono i maestri con cui deve confrontarsi in un momento particolarmente vivace della sua formazione. Studia a fondo le loro opere e scopre che essi rappresentano due posizioni antitetiche e non facilmente conciliabili: in Leonardo l’arte è in funzione della conoscenza della natura, della vita, della scoperta del mondo; in Michelangelo, invece, è proiettata verso la comprensione dell’uomo, del mistero della persona, mettendo in luce il groviglio e le contraddizioni dell’animo umano[5].
Raffaello è aperto a tutte le esperienze; con ammirazione coglie la profondità dell’uno e dell’altro, e tenta perfino di competere con questi personaggi ineguagliabili. Sa imitare intelligentemente le loro novità, carpirne i segreti, e comprende bene dove è diretto il mercato dell’arte. Per lui Firenze è davvero un banco di prova, in cui tenta di coniugare i pregi dei due grandi artisti e integrarli nell’archetipo della bellezza. Il Vasari, nella biografia dell’artista, lo afferma chiaramente: «[Nella sua pittura] pare che spiri veramente un fiato di divinità nella bellezza delle figure e nella nobiltà di quella pittura, la quale fa maravigliare chi intensissimamente la considera come possa un ingegno umano, con l’imperfezione di semplici colori, ridurre con l’eccellenzia del disegno le cose di pittura a parere vive»[6]. L’osservazione è interessante: le pitture di Raffaello sono davvero vive, e per di più nella semplicità e naturalità delle loro espressioni sono colme di energia e comunicano qualcosa che attira, meraviglia e ammalia: è il mistero della bellezza che affascina.
Insuccesso e successo di Raffaello
Nonostante la lettera di presentazione, l’Urbinate rimane deluso. Pier Soderini non gli affida alcun incarico importante, e Raffaello deve accontentarsi di qualche ordine marginale, da parte di alcuni mercanti. Uno di essi, Taddeo Taddei, uomo di affari ma anche intellettuale, gli commissiona il quadro di una Vergine col bambino. Raffaello non è nuovo a questo lavoro, e ne ha già collezionati diversi tra Città di Castello e Perugia; ma questi risentono molto dello stile del Perugino e rivelano un modo di dipingere un po’ freddo e ripetitivo, che sta passando di moda. Ora l’incarico del Taddei gli dà modo di esprimere la propria originalità: con la Madonna del prato (o del Belvedere), del 1506, Raffaello raggiunge il culmine nella sua produzione fiorentina.
La composizione piramidale deriva chiaramente da Leonardo (si veda la Sant’Anna, la Vergine e il Bambino) e presenta la Madonna seduta, immersa in un paesaggio lacustre sullo sfondo di un ampio orizzonte: Maria sorregge con le mani il Bambino, che muove i primi passi incerti e gioca con la croce astile del Battista, segno della sua futura missione salvifica. L’artista riformula il senso di mistero leonardesco in una calma maestosa e affettuosa, data dalla concatenazione di sguardi e di gesti che si intrecciano e accentuano la bellezza dell’immagine[7]. Il dipinto è il primo di una serie che, come si è detto, fa di Raffaello uno specialista della tipologia mariana: la figura della Vergine rappresenterà un esempio di bellezza, di umanità e di dolcezza.
Più o meno contemporanea è la Madonna del Cardellino, a suo modo un esperimento che pure raggiunge la perfezione. Seguono la Sacra famiglia Canigiani e la Grande Madonna Cowper del 1508 (dal nome della collezione di cui faceva parte un’altra Madonna di Raffaello), dove Gesù compie un gesto affettuoso ponendo la manina sullo scollo della veste di Maria.
Il soggiorno fiorentino costituisce anche l’epoca dei ritratti: se ne ricordano molti, tra cui quello di Agnolo Doni e della moglie Maddalena Strozzi Doni. L’impostazione di quest’ultimo riprende smaccatamente quello della Gioconda. Ma Raffaello ne fa una pittura nuova. La dama non deve essere per forza bella, ma deve essere «vera»[8]. Se, da un lato, imita la Gioconda, dall’altro appare una donna poco idealizzata, anzi con qualche difetto: i capelli sollevati dal vento, la sua obesità e il modo ostentato con cui sul petto indossa il prezioso gioiello. Eppure l’immagine emerge con una certa maestosità, accentuando i lineamenti fisici e l’intensità dei colori dei vestiti di velluto e raso.
Una menzione particolare merita Il trasporto di Cristo (o Pala Baglioni), del 1507. Si tratta di un incarico importante: una pala d’altare destinata a una cappella di Perugia, e non a un ristretto ambito familiare. Per Raffaello rappresenta una svolta nell’ambiente artistico fiorentino. Gli è stata commissionata da Atalanta Baglioni[9] in ricordo del figlio, Grifonetto, assassinato nel 1500 in una guerra fratricida. Questi, coinvolto nell’omicidio del fratello, era stato cacciato di casa dalla madre e si era ritirato in esilio, quando venne ucciso dal cugino.
In quest’opera Raffaello ricorda la tragedia che ha coinvolto un’intera famiglia in una rappresentazione altamente emotiva. Al centro del quadro domina un giovane, pieno di vitalità, che trasporta la salma di Cristo appena deposto dalla croce, e il suo volto ha le sembianze di Grifonetto. Si trova in evidenza anche la Maddalena, che ha ancora i capelli sciolti, gli stessi con cui ha asciugato i piedi del Maestro; si nota la sua mano rosea a contatto con quella esangue di Gesù. Lei è l’unica che tocca il Signore.
Il suo dolore raccorda l’altra parte del quadro, dove è presentata la Madonna che sviene (forse immagine del dramma della Baglioni)[10]. Tra coloro che sorreggono il Signore c’è un personaggio anziano che guarda lo spettatore con un’espressione tra la fatica e la ripugnanza: Giuseppe d’Arimatea? Di certo riecheggia un volto matteano michelangiolesco che ha colpito l’immaginazione del pittore. La composizione del quadro richiama anche un bassorilievo di un sarcofago romano: il trasporto di Meleagro, del II secolo dopo Cristo. Per Raffaello, questo significa un incontro con la cultura antica: è il primo indizio del classicismo dell’artista. L’opera costituisce un modello che segnerà la storia della pittura[11].
Raffaello a Roma
Alla fine del 1508 Donato Bramante, nativo di un borgo di Urbino e amico del padre, convoca d’urgenza Raffaello a Roma. Bramante è l’architetto della ricostruzione della basilica di San Pietro e conosce bene il fermento artistico che Giulio II, il Papa guerriero, ha ora innescato nella città. Giulio II non vuole abitare nell’appartamento di Alessandro VI, suo predecessore e rivale, che gli aveva sottratto il trono pontificio; perciò decide di trasferirsi nelle stanze superiori di Niccolò V e intende rinnovarle integralmente[12].
Quando arriva l’Urbinate, nel nuovo appartamento lavorano pittori già affermati: Baldassarre Peruzzi, Lorenzo Lotto, il Bramantino e il Sodoma; inoltre, Michelangelo sta dipingendo la volta della Cappella Sistina. Su consiglio del Bramante, Giulio II affida a Raffaello la decorazione della Stanza della Segnatura. La stanza prende questo nome perché è destinata al tribunale De signatura Gratiae: sulla volta sono rappresentati, in quattro tondi, la Teologia, con la scritta Divinarum rerum notitia, cioè la rivelazione di Dio; poi la Filosofia, ossia la Causarum cognitio; e infine la Giustizia e la Poesia. Nelle pareti sottostanti Raffaello dipinge le scene che illustrano questi ideali, fondamento della cultura umanistica.
Così, sotto la Teologia vi è l’affresco della cosiddetta Disputa del Sacramento. Il tema è incentrato sulla Trinità, nell’iconografia tradizionale: il Padre, il Figlio e lo Spirito (sotto forma di colomba), che si libra proprio sull’altare, dove è l’ostensorio con l’Eucaristia. Sembra uno schema semplice: in realtà Raffaello crea una combinazione semicircolare, che parte dall’altare, ha per centro l’ostia consacrata e si amplia in due ali prospettiche, intorno alla Trinità. La prima comprende la Chiesa militante: si riconoscono dottori della Chiesa (Agostino, Gerolamo, Ambrogio, Tommaso d’Aquino), vescovi e fedeli (perfino Dante e il Savonarola: una riabilitazione dopo Alessandro VI?), che disputano sul mistero del sacramento. L’altra ala prospettica rappresenta la Chiesa trionfante: al centro, Gesù, con i segni della passione e della gloria, affiancato dalla Madonna e dal Battista, dagli apostoli, evangelisti e profeti. Al di sopra, il Padre, con la mano destra benedicente e con la sinistra che solleva un globo, con un coro di angeli e un paesaggio che sfuma nel cielo. Sembra davvero la conca di un’abside[13]. La spiegazione è chiara: la «rivelazione» prende forma nella Chiesa e diviene significativa nella struttura architettonica, dove la realtà celeste conferma quella terrena, e questa confluisce in quella del cielo. La Disputa del sacramento è il primo dei capolavori della Stanza della Segnatura.
La «Scuola di Atene»
Un altro capolavoro è la Scuola di Atene (cfr figura 1), sotto la Filosofia, di fronte alla Disputa, e simboleggia la sapienza antica: si dà quindi un’ideale continuità fra queste due pareti, fra quella della Teologia e l’altra della Filosofia. Ma i fatti nuovi sono davvero molti rispetto alla Disputa. Qui l’architettura è solenne, perché rappresenta l’eccellenza del pensiero umano, che ha il suo acme nella filosofia[14].

Al centro della prospettiva si trovano i due sommi filosofi dell’antichità, Platone e Aristotele, che incedono con passo risoluto, come se volessero scendere i gradini ed entrare nella Stanza. Il primo indica il cielo, cioè il mondo delle idee, e ha in mano un libro, il Timeo, il dialogo dell’eterno e del divenire, che spiega l’origine del cosmo, la natura degli elementi, l’uomo; il personaggio ha le sembianze di Leonardo da Vinci, l’artista infaticabile ricercatore della verità e delle leggi che regolano l’universo. Al suo fianco, Aristotele – un giovane con lo sguardo interrogativo rivolto a Platone e con il braccio destro disteso in avanti – ha nella sinistra l’Etica nicomachea, il libro della morale che costituisce il bene dell’uomo. Si discute chi sia il personaggio che rappresenta: forse si tratta di Bastiano da Sangallo, pittore e architetto così valente da ricevere l’appellativo di «Aristotele della prospettiva»[15]. Proprio lui potrebbe aver progettato la successione di piani prospettici dell’architettura monumentale che disegna uno spazio immenso che si libra all’infinito e che riprende la struttura del progetto di Bramante per San Pietro. Platone e Aristotele, con i lineamenti di due personaggi viventi, trasfigurano i problemi della filosofia antica in questioni moderne e contemporanee.
Inoltre, poiché si deve rappresentare l’eccellenza della sapienza umana, le figure umane sono imponenti: le persone si distinguono per la grandiosità dell’atteggiamento e l’energia dei loro gesti. Si riconoscono Socrate, Alcibiade, Pitagora, Euclide, e perfino Diogene. Non mancano personaggi dell’epoca. Si nota Bramante nell’immagine di Euclide, e risalta un giovane che si aggira tra i dotti, vestito di una tunica bianca: è un rampollo della dinastia della Rovere, un nipote di Giulio II[16]. Vi è anche l’autoritratto di Raffaello, accanto al Sodoma, all’estrema destra in basso, con un berretto nero, l’unico che guarda verso lo spettatore: la sua firma[17].
Forse è presente anche Michelangelo, nei panni di Eraclito, l’unico in abbigliamento del tempo e con gli stivali. Una diceria vorrebbe che il Papa stesso abbia chiesto di aggiungere la sua figura, dato che erano presenti Bramante e Leonardo. Michelangelo ricorda allusivamente le sembianze del profeta Isaia della Cappella Sistina, il cui ritratto era appena terminato, e proprio allora faceva parlare di sé per la novità dell’atteggiamento: solo che qui la sua figura, rappresentata da Raffaello, appare priva del pathos michelangiolesco.
La Poesia e la Giustizia
Sotto la Poesia, nel lunettone che sovrasta la finestra, vi è l’esaltazione dell’idea del bello con il Parnaso. Vi sono raffigurati Apollo, che suona una viola anziché la tradizionale lira, e le Muse con strumenti musicali, alla presenza di poeti antichi e contemporanei: dietro Omero si riconoscono Virgilio, Dante, Petrarca. Raffaello vuole proporre una continuità tra i due mondi.
Nell’affresco di fronte al Parnaso, nella lunetta sopra la finestra, l’artista celebra le virtù: tra quelle teologali, la Fede è impersonata da un genietto che indica il cielo, la Speranza da un altro con una fiaccola in mano, la Carità da un terzo che raccoglie qualcosa dalle fronde di una quercia (simbolo araldico di Giulio II). Tra le virtù cardinali, la Prudenza, la Temperanza e la Fortezza sono alternate a putti alati che corrono e animano la scena. Va notato che la Fortezza ha in mano un ramo di rovere, anziché una spada: altro omaggio alla famiglia del Papa.
I due affreschi ai lati della finestra celebrano la Giustizia, con il diritto civile (Giustiniano riceve le Pandette) e quello ecclesiastico (Gregorio IX approva le Decretali, la raccolta del diritto canonico medievale). Tuttavia nella figura del Papa, anziano e col viso dimesso, Raffaello ritrae Giulio II con la barba, un particolare segno di dolore che la dice lunga sulle vicende del Pontefice. Questi, nel 1510, viene sconfitto a Ferrara da Alfonso d’Este, marito di Lucrezia Borgia, con il sostegno dei francesi. I bolognesi ne approfittano per abbattere la statua del Pontefice realizzata da Michelangelo qualche tempo prima: una grave onta, a cui Giulio II reagisce con l’interdetto. Intanto Luigi XII convoca il Conciliabolo di Pisa per deporre il Papa, che, sorprendentemente, fa il voto di non tagliarsi la barba fino a quando non avrà cacciato tutti i francesi dall’Italia. Purtroppo dovrà tenere la barba fino alla morte.
Raffaello dipinge in seguito un ritratto ufficiale di Giulio II con la barba, che sarà esposto nella chiesa di Santa Maria del Popolo, a Roma. A quel tempo i fedeli vedevano raramente il Papa, e quel ritratto sarebbe stato la proclamazione solenne del suo programma religioso e politico, interpretato efficacemente dall’artista[18].
La «Stanza di Eliodoro»
Raffaello dipinge poi la Stanza di Eliodoro, chiamata così da uno degli affreschi che rappresenta la biblica Cacciata di Eliodoro, in cui il personaggio è inviato dal re Seleuco per depredare le ricchezze del tempio di Gerusalemme. Ma Dio ascolta le preghiere del sacerdote Onia, in ginocchio al centro della scena, inviando un cavaliere celeste che scaccia Eliodoro. Un modo antico e insieme moderno che allude, oltre che ai programmi spirituali e temporali di Giulio II, alla protezione divina per la Chiesa.
Al lato è rappresentato il bellissimo e innovativo notturno della Liberazione di san Pietro per mezzo di un luminoso angelo mandato da Dio. Vi è ancora la Messa di Bolsena, in cui spicca il dramma di un sacerdote boemo che, durante la consacrazione, ha dubbi sulla presenza reale di Cristo nell’Eucaristia: improvvisamente dall’ostia cadono gocce di sangue che macchiano il corporale. Sono tutti episodi della storia della Chiesa ideologizzati per mostrare la benedizione di Dio sul programma di Giulio II. In questa Stanza l’esecuzione dei dipinti è affiancata da diversi collaboratori e allievi, costantemente diretti e seguiti dal maestro: la mano di Raffaello invece scompare del tutto nell’Incontro di Leone Magno con Attila.
Nel 1513 Giulio II muore e sale al soglio pontificio Leone X, Giovanni de’ Medici, figlio di Lorenzo il Magnifico. Nel compimento dell’ultimo affresco è possibile riconoscere, nelle fattezze del Papa, il volto di Leone. Ma qui il livello artistico non raggiunge quello delle Stanze precedenti. Nell’ultima sala, quella dell’Incendio di Borgo, predomina la mano degli allievi.
Il successo romano: pittore e architetto
La fama dell’artista è ormai consolidata e, alla morte del Bramante, Raffaello viene nominato architetto della Fabbrica di San Pietro, incarico che porterà avanti fino alla morte. Per tale lavoro è importante il suo studio sui monumenti antichi, tanto che Leone X lo nomina «sovrastante» alle Antichità di Roma, divenendo quasi un pioniere della tutela archeologica[19]. Il Papa gli affida anche il progetto di una serie di arazzi per ornare la parte inferiore delle pareti della Sistina, già fatte decorare con finti tendaggi da Sisto IV della Rovere. L’opera sarà situata proprio sotto il capolavoro di Michelangelo. È un’altra sfida per Raffaello, che disegna una serie eccezionale di cartoni con le storie di san Pietro e san Paolo, i patroni della Chiesa e della città di Roma. I disegni saranno eseguiti a Bruxelles dal prestigioso arazziere Pieter van Aelst: un successo che rivoluzionerà la storia della pittura e l’arte degli arazzi[20].
Ora piovono commissioni prestigiose, e non solo a Roma. Va ricordata la Madonna Sistina per i monaci di San Sisto a Piacenza, famosa per la sua delicatezza e raffinatezza, tanto da essere annoverata tra i capolavori dell’Urbinate[21]. La tela si distingue per la rivelazione del soprannaturale nella Madonna col Bambino, che incede solennemente sulle nubi guardando verso i fedeli e sollecitandone la partecipazione[22]. Nella figura di san Sisto si riconoscono le fattezze del Papa, Giulio II; originalissimi sono i due angioletti che, sull’orlo della balaustra, ammirano trasognati la scena.
Una delle più importanti committenze a Roma è il Ritratto di Leone X tra i cardinali Giulio de’ Medici e Luigi de’ Rossi. Il Papa è dipinto in un intreccio di sguardi tra i nipoti «in muta conversazione» ed è rappresentato nell’atto di sfogliare una preziosa Bibbia miniata, con una lente in mano, per indicare i suoi interessi culturali, il gusto di collezionista e di intenditore raffinato delle arti[23].
Tra le opere di cui non è facile stabilire la data c’è il Trionfo di Galatea. L’affresco sembra parallelo al Trasporto di Cristo, ed è anche simile all’impostazione della Madonna del Prato. Non c’è traccia alcuna dello stile della Scuola di Atene, e tuttavia l’opera potrebbe esserle contemporanea. Agostino Chigi, un ricchissimo banchiere, commissiona all’artista l’affresco del mito di Galatea per la sontuosa villa costruita dal Peruzzi alla Lungara (detta poi la «Farnesina»). La ninfa è in piedi sulla conchiglia trainata dai delfini che la portano in salvo da Polifemo: nel rosso del manto che l’avvolge emerge in bilico, con il suo corpo in torsione; un tritone ha afferrato un’altra ninfa che cerca di svincolarsi dalla stretta violenta, mentre una terza si aggrappa alle spalle di un centauro. Sullo sfondo della lucentezza del mare vi sono l’occhio vigile di Eros e gli amorini pronti a scagliare le loro frecce.
Forse il dipinto narra la storia del Chigi che, rimasto vedovo, chiede la mano di Margherita Gonzaga e ne ottiene un rifiuto. Raffaello viene a sapere che margarites in greco significa «perla»: e Galatea, splendida e maestosa, risalta come una perla nella conchiglia. C’è un altro segreto: il suo volto sarebbe quello di Imperia Cognati, la cortigiana più famosa di Roma, amata del banchiere dopo il rifiuto della nobildonna[24]. Il Chigi la propone come modella a Raffaello, che ne apprezza la bellezza e il mestiere. Qui si rivela anche la vita avventurosa dell’artista.
Certo i due hanno in comune una passione smodata per le donne – documentata anche dal Vasari –, che è forse all’origine dei mali dell’Urbinate: «Fu Raffaello persona molto amorosa et affezzionata alle donne, e di continuo presto ai servigi loro. […] Onde facendogli Agostin Ghigi, amico suo caro, dipignere nel palazzo suo la prima loggia, Raffaello non poteva molto attendere a lavorare per lo amore che portava ad una sua donna; per il che Agostino si disperava […] e operò sì che appena ottenne che questa sua donna venne a stare con esso in casa continuamente, in quella parte dove Raffaello lavorava, il che fu cagione che il lavoro venisse a fine»[25].
L’episodio conferma il tormento di Raffaello per la bellezza femminile che segna le sue opere. Purtroppo le vicende personali non aiutano a interpretare alcuni suoi capolavori, tra cui la Fornarina. Il dipinto, un volto bellissimo senza nome, con i suoi occhi luccicanti quasi in segno di intesa e il seno delicato sfiorato dalle dita, è tanto caro al pittore da tenerlo sempre con sé, fino alla morte. Sull’armilla che cinge il braccio sinistro Raffaello incide il proprio nome: è la sua firma. La fanciulla sarebbe la figlia di un fornaio non lontano dalla villa della Lungara. Non vi è nessuna prova a documentarlo e il quadro non ha un committente: «Esattamente come la Gioconda di Leonardo, la Fornarina è una figura fantasma della storia dell’arte»[26].
La morte
Raffaello muore a 37 anni, il 6 aprile del 1520[27], per la sregolatezza della sua vita, afferma il Vasari[28]. Al suo capezzale gli allievi pongono la Trasfigurazione, il capolavoro ultimo, non ancora compiuto, che esprime quanto di più bello e più originale l’artista ha maturato in poco meno di 20 anni di lavoro intensissimo e appassionato, confrontandosi con la grandezza di Leonardo e di Michelangelo, talvolta forse, a detta di alcuni, superandola.
Così il Bembo celebra Raffaello nella lapide che sigilla il sepolcro al Pantheon: Ille hic est Raphael timuit quo sospite vinci / rerum magna parens moriente mori[29]. Sarebbe arduo aggiungere altro.
Copyright © 2020 – La Civiltà Cattolica
Riproduzione riservata
***
RAFFAELLO: LIGHTS AND SHADOWS IN THE LIFE OF A GENIUS
At the beginning of the new year, Pope Francis recalled the Quincentennial of the death of Raffaello Sanzio (1483-1520) and, among his merits, the numerous paintings dedicated to the Madonna, which marked the Marian typology until the last century. The artist, who died aged 37, stood out even when he was very young for his originality in proposing ancient themes in a personal and fascinating way. Raphael’s masterpieces, from the Marriage of the Virgin (1504) to the Vatican Rooms, the Triumph of Galatea, the Sistine Madonna, and the famous Transfiguration (1520), attest to the genius, the prodigious success of the artist, and also his competition with the two geniuses of the time: Leonardo and Michelangelo. His death reveals the shadow of an adventurous life.
***
[1]. Francesco, Discorso ai membri del Corpo diplomatico accreditato presso la Santa Sede per la presentazione degli auguri per il nuovo anno, 9 gennaio 2020, in w2.vatican.va
[2]. Ivi.
[3]. Cfr G. C. Argan, Storia dell’arte italiana. III. Il Cinquecento, il Seicento e il Settecento dal Neoclassicismo al Futurismo, Firenze, Sansoni, 1979, 26.
[4]. C. Strinati, Raffaello, Firenze – Milano, Giunti, 1995, 13.
[5]. Cfr G. C. Argan, Storia dell’arte italiana…, cit., 25.
[6]. G. Vasari, Vita di Raffaello da Urbino pittore e architetto, in Raffaello. I disegni, Firenze, Nardini, 1983, 145. E più avanti, a proposito di un quadro di sant’Anna che porge il bimbo a Maria: «Il suo figliuolo di tanta bellezza ne l’ignudo e nelle fattezze del volto, che nel suo ridere rallegra chiunque lo guarda: […] Raffaello mostrò nel dipignere la nostra Donna tutto quello che di bellezza si può fare nell’aria di una Vergine, dove sia accompagnata negli occhi modestia, nella fronte onore, nel naso grazia, e nella bocca virtù: […] l’abito suo è tale, che mostra una semplicità ed onestà infinita» (ivi, 149).
[7]. Cfr P. De Vecchi – E. Cerchiari, Arte nel tempo. I. Dal Gotico Internazionale alla Maniera Moderna, Milano, Bompiani, 1992, 339.
[8] . C. D’Orazio, Raffaello segreto. Dal mistero della «Fornarina» alle Stanze vaticane, Milano, Mondadori, 2019, 72.
[9] . Cfr G. Vasari, Vita di Raffaello da Urbino pittore e architetto, cit., 143.
[10]. Si noti qui il gomito della ragazza in torsione che sostiene la Madonna svenuta: è un velato tributo al Tondo Doni di Michelangelo.
[11]. Vi si ispireranno Andrea del Sarto e Fra’ Bartolomeo.
[12]. Per le Stanze, si veda R. Salvini, Stanze e logge di Raffaello, Novara, De Agostini, 1983; A. Paolucci, Raffaello in Vaticano, Firenze – Milano, Giunti, 2013; M. Faietti, «Con studio e fantasia», in M. Faietti – M. Lafranconi (eds), Raffaello 1520-1483, Catalogo delle Scuderie del Quirinale, Milano, Skira, 2020, 19-37. Cfr anche J. B. Fellay, «Raffaello; l’antitesi di Lutero?», in Civ. Catt. 2017 I 120-132.
[13]. Cfr G. C. Argan, Storia dell’arte italiana…, cit., 43.
[14]. Cfr A. Gnann, «L’attività di Raffaello sotto papa Giulio II», in M. Faietti – M. Lafranconi (eds), Raffaello 1520-1483, cit., 359-367.
[15]. Cfr C. Strinati, Raffaello, cit., 30.
[16]. Non è sicura l’identificazione: cfr A. Rocca, Il Raffaello dell’ Ambrosiana. In principio il Cartone, Milano, Mondadori, 2019, 46.
[17]. Il particolare non risulta nel cartone preparatorio e manca anche il ritratto del Sodoma: segno che Raffaello lo ha inserito all’ultimo momento (cfr ivi, 76).
[18]. Il ritratto è del 1512 e si trova ora a Londra, alla National Gallery.
[19]. Cfr E. C., «Raffaello architetto. L’altra faccia del pittore», in C. Strinati, Raffaello, cit., 47; interessante è la sua Lettera a papa Leone X, scritta con Baldassarre Castiglione, sulla protezione e conservazione dei monumenti di Roma antica (cfr il testo in C. D’Orazio, Raffaello segreto…, cit., 183-193).
[20]. «La tragedia e il pathos, l’emozione, la gloria, il dramma entrano negli arazzi così che ogni pezzo della serie è destinato a rimanere indimenticabile» (A. Paolucci, Raffaello in Vaticano, cit., 39).
[21]. La pala fu commissionata da Giulio II per onorare la memoria dello zio papa, Sisto IV, Francesco della Rovere. Oggi si trova alla Gemäldegalerie, a Dresda.
[22]. Cfr P. De Vecchi – E. Cerchiari, Arte nel tempo…, cit., 372.
[23]. Ivi, 376. La pagina della Bibbia che il Papa ha davanti è l’inizio del Vangelo di Giovanni (Gv 1,1): allusione al nome di Leone X. Il Ritratto, recentemente restaurato, si trova agli Uffizi.
[24]. Cfr C. D’Orazio, Raffaello segreto…, cit., 148.
[25]. G. Vasari, Vita di Raffaello da Urbino pittore e architetto, cit., 152.
[26]. C. D’Orazio, Raffaello segreto…, cit., 162.
[27]. Era il Venerdì santo. Anche il giorno della sua nascita, il 28 marzo del 1483, era un Venerdì santo.
[28]. «Raffaello, attendendo in tanto a’ suoi amori così di nascosto, continuò fuor di modo i piaceri amorosi, onde avvenne ch’una volta fra l’altre disordinò più del solito; perché tornato a casa con una grandissima febbre, fu creduto da’ medici che fosse riscaldato; onde, non confessando egli il disordine che aveva fatto, per poca prudenza, loro gli cavarono sangue; di maniera che indebilito si sentiva mancare, là dove egli aveva bisogno di ristoro. Perché fece testamento e prima come cristiano mandò l’amata sua fuor di casa e le lasciò modo di vivere onestamente. […] Poi confesso e contrito finì il corso della sua vita» (G. Vasari, Vita di Raffaello da Urbino pittore e architetto, cit., 155).
[29]. «Qui è quel Raffaello dal quale, fin che visse, Madre Natura temette di essere vinta e, mentre egli moriva, temette di morire». Cfr M. Lafranconi, «“Ille hic est Raphael”. La morte di Raffaello nelle parole dei contemporanei», in M. Faietti – M. Lafranconi (eds), Raffaello 1520-1483, cit., 43-51.