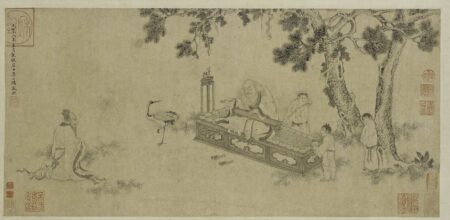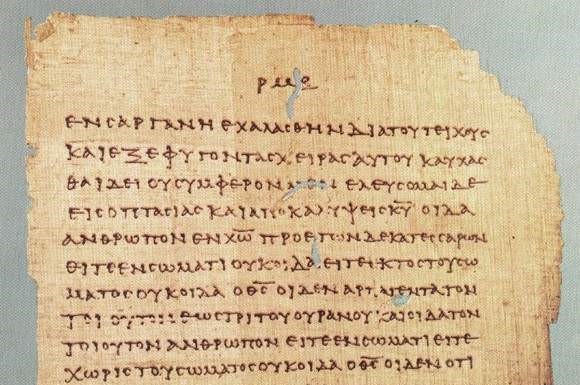
|
|
Il messaggio cristiano si riassume in una parola sola: «Vangelo», la Buona Notizia. E questo unico Vangelo è lungamente declinato in quattro Vangeli: Matteo, Marco, Luca e Giovanni. Questo non dovrebbe essere più che sufficiente per i cristiani? Eppure, nel Nuovo Testamento, ossia in quella parte della Bibbia cristiana relativa al messaggio evangelico, si trovano numerose lettere. Oltre alla grande collezione posta sotto il nome di Paolo (13 lettere), ve ne sono tre attribuite a Giovanni; poi due attribuite a Pietro, una a Giacomo e una a Giuda; e infine uno scritto molto difficile da classificare, la lettera agli Ebrei, che non è una lettera e non è indirizzata in particolare agli ebrei, ma che ha chiuso il ciclo paolino nel II secolo.
Il Vangelo dovrebbe bastare, eppure vi sono delle lettere, un modo di parlare in cui chi scrive appare in primo piano. Si tratta certamente di un uomo abitato dallo Spirito, senza dubbio un apostolo, e tuttavia un uomo con un temperamento, preoccupazioni e amici. Il primo paradosso da notare è che alcune lettere sono state scritte senz’altro prima dei Vangeli e costituiscono i primi scritti cristiani. Sono sette lettere paoline, ritenute dalla tradizione critica di mano propria di Paolo di Tarso (Romani, Galati, Filippesi, 1 e 2 Corinzi, 1 Tessalonicesi e Filemone). Si nota qui un parallelo sorprendente con l’Antico Testamento, la Bibbia ebraica: anche in quel caso, i testi che si trovano per primi nel libro non furono i primi a essere stati scritti. Anche in quel caso, ci si potrebbe aspettare di trovare solo la Legge di Mosè, e invece si incontrano racconti, canti, proverbi ecc. Evidentemente, anche se il Vangelo sarebbe dovuto bastare, le prime comunità cristiane hanno riconosciuto molto presto che la parola di Dio si manifestava anche quando parlavano alcuni dei loro capi.
Un solo Vangelo, ma molti interpreti
In effetti, ciò che viene prima è proprio il Vangelo, nel senso di una notizia, di un annuncio che non si può ridurre a un libro. Tanto le lettere quanto i quattro Vangeli vogliono rimandare all’unico Vangelo: in Gesù di Nazaret, il Messia crocifisso, è in gioco il disegno stesso di Dio per Israele e per il mondo. Per questo, nel Nuovo Testamento non troviamo la vita di Gesù raccontata dagli apostoli, ma quella raccontata dai discepoli della terza generazione, mentre abbiamo un gran numero di lettere di un certo Paolo, un uomo che non aveva conosciuto Gesù «secondo la carne» (2 Cor 5,16). Paolo di Tarso ha avuto l’audacia di scrivere per primo, lui che non era uno dei Dodici, uno degli apostoli scelti da Gesù, e che, inoltre, era stato un accanito persecutore del movimento cristiano alle sue origini, motivo per cui è stato difficilmente accettato da molti dei primi cristiani.
Per comprendere la diversità delle sue lettere, e dei nomi sotto i quali esse sono state poste, occorre ricordare che i primi cristiani si distribuivano su una vasta gamma di comunità differenziate. Per semplificare – ed è una distinzione che potrebbe essere discussa –, è possibile identificare almeno quattro grandi «famiglie»: i giacobiti (che rivendicavano di essere di Giacomo, «il fratello del Signore»); i petrini (che rivendicavano di essere di Simon Pietro); i paolini (che rivendicavano di essere di Paolo); e i giovannei (che rivendicavano di essere di un certo Giovanni, che oggi si tende a distinguere dal galileo Giovanni, figlio di Zebedeo)[1]. Resterà nella storia il privilegio unico di Paolo, che è stato il primo a scrivere un messaggio fondato su una parola libera, leggera come il vento. A quale titolo? Egli crede di essere stato chiamato direttamente da Gesù risorto e arriva a dire: «Non sono forse un apostolo? Non ho veduto Gesù, Signore nostro?» (1 Cor 9,1), e afferma di non avere meno carismi degli altri: «Credo infatti di avere anch’io lo Spirito di Dio» (1 Cor 7,40b).
In questo paradosso sorprendente – sul quale Joseph Ratzinger ha riflettuto nel suo secondo volume su Gesù[2] – lo strano messaggio di quegli ebrei messianici che sono i primi cristiani ha trovato le sue prime parole greche per mezzo di un cristiano che non aveva conosciuto Gesù secondo la carne e che non era stato uno dei Dodici. Tutti concordano sul fatto che Paolo fu il primo a scrivere delle lettere; dopo di lui, anche altri membri di altre «famiglie» cristiane hanno iniziato a imitarlo. Mettendosi egli stesso a scrivere, Paolo permetteva implicitamente ad altri di scrivere a loro volta, aprendo così il periodo della rivelazione cristiana non solo agli apostoli, ma anche a quelli che sarebbero venuti dopo di loro. In realtà, nessun apostolo di Gesù ha scritto personalmente, ma lo hanno fatto i loro compagni e collaboratori: Paolo è quindi emblematico del gruppo che ha permesso la trasmissione della fede di questo gruppo di ebrei ardenti.
Gli uomini di quel gruppo della seconda generazione cristiana hanno scritto tra il 49 (data abitualmente fissata per il primo scritto cristiano, la prima lettera ai Tessalonicesi) e il 115 (data in cui si pensa sia stata scritta la seconda lettera di Pietro). Paolo è quindi come un anello di congiunzione tra i cristiani di oggi e gli apostoli; come questi ultimi, infatti, egli è apostolo, e non cederà mai su questo punto: «Ultimo fra tutti [Cristo risorto] apparve anche a me come a un aborto» (1 Cor 15,8). Tuttavia, come i cristiani dei secoli successivi fino a oggi, Paolo non ha conosciuto Cristo secondo la carne e deve fondarsi sulla trasmissione orale dei primi discepoli, ad esempio per quanto riguarda l’Eucaristia o la risurrezione di Gesù: «A voi infatti ho trasmesso, anzitutto, quello che anch’io ho ricevuto» (1 Cor 15,3).
Bisogna forse ricordare che le grandi questioni della teologia cristiana dei secoli successivi hanno trovato nel linguaggio di Paolo i loro maggiori luoghi di espressione e di controversie? Una frase dell’autore della seconda lettera di Pietro ci mostra che gli accesi dibattiti scatenati sul senso di alcune formule paoline non risalgono certo alla Riforma: «Così vi ha scritto anche il nostro carissimo fratello Paolo, secondo la sapienza che gli è stata data, come in tutte le lettere, nelle quali egli parla di queste cose. In esse vi sono alcuni punti difficili da comprendere, che gli ignoranti e gli incerti travisano, al pari delle altre Scritture, per loro propria rovina» (2 Pt 3,15-16).
È impossibile comprendere lo sviluppo storico del cristianesimo senza tener conto del pensiero di Paolo, così come viene espresso, da una parte, nelle lettere di sua mano e, dall’altra, in quelle dei suoi collaboratori che ne hanno raccolto l’eredità (Efesini, Colossesi, le due lettere a Timoteo, la lettera a Tito e la seconda lettera ai Tessalonicesi). Secondo molti storici, i pensatori che hanno avuto la maggiore influenza sul pensiero teologico cristiano sono due interpreti di Paolo: Agostino di Ippona e Martin Lutero[3]. Se Efesini e Colossesi sono le lettere paoline più citate nell’epoca patristica e, in generale, durante il primo millennio dell’era cristiana, Romani e Galati sono state al centro dei dibattitti teologici fra protestanti e cattolici degli ultimi cinque secoli.
Discutere i problemi concreti delle comunità
Ma, oltre a testimoniare il Vangelo, di che cosa parlano queste lettere? Quasi mai della vita di Gesù di Nazaret, bensì riflettono l’insegnamento dei maestri cristiani del I secolo. In che modo distinguersi dalle comunità ebraiche e dalle loro regole cultuali così profondamente radicate e così attraenti per i pagani convertiti, che spesso provenivano dagli ambienti proseliti e che frequentano da tempo le sinagoghe? In che modo continuare a partecipare alla vita ordinaria delle città greche, caratterizzate dal paganesimo? Si può comprare la carne dei sacrifici venduta nelle macellerie annesse ai templi pagani? Quali regole seguire per il ripudio, se uno dei coniugi rifiuta la conversione dell’altro (cfr 1 Cor 7,12-16)? Come retribuire i predicatori itineranti? Tutte le questioni concrete che agitano le comunità vengono affrontate in queste lettere, che quindi ci consentono di gettare uno sguardo sulla sociologia del cristianesimo primitivo.
Certo, a seconda delle lettere, ossia a seconda della «famiglia» cristiana che si incontra, gli accenti sono differenti, le risposte non sempre totalmente armoniche tra loro. Leggere queste lettere in maniera continua permette di toccare con mano le differenze non solo di stile, ma anche teologiche tra le diverse comunità cristiane. È inoltre possibile, e anche probabile, che alcuni ambienti siano sottorappresentati, poiché non tutti hanno scritto nella stessa misura. È chiaro, per esempio, che la corrente paolina, che molto probabilmente fu minoritaria fino all’anno 70 e che venne violentemente contestata (come testimoniano alcuni passi della lettera ai Galati o della lettera ai Romani), alla fine sia risultata sovrarappresentata nel Nuovo Testamento. In effetti, gli scritti di tale corrente costituiscono circa la metà di tutto il Nuovo Testamento[4]: alle lettere del corpus paolino, infatti, occorre aggiungere l’opera di Luca (il Vangelo e gli Atti, ossia un quarto del Nuovo Testamento), che è scritta in una prospettiva paolina. Si potrebbe anche pensare che uno dei principali obiettivi di Luca sia la difesa della memoria di Paolo, che viene messo in forte continuità con Pietro.
Paolo e il mistero della lettera ai Romani
È senza dubbio nella contestazione fatta a Paolo durante la sua vita che si può trovare una pista per chiarire il mistero della lettera ai Romani. Infatti, Paolo ha scritto a comunità che aveva fondato personalmente in Asia Minore e in Grecia. Eccezionalmente c’è un biglietto indirizzato a un individuo di quelle stesse regioni, Filemone. E nella lettera ai Romani Paolo spiega che non vuole interferire nelle regioni evangelizzate da altri apostoli: «Ma mi sono fatto un punto di onore di non annunciare il Vangelo dove era già conosciuto il nome di Cristo, per non costruire su un fondamento altrui» (Rm 15,20). Sorge quindi necessariamente la domanda: perché allora Paolo scrive ai cristiani di Roma, sebbene non abbia fondato tale comunità?
Nella lettera, Paolo spiega che vorrebbe fermarsi qualche giorno a Roma, prima di proseguire il suo viaggio verso la Spagna, il Far West delle terre abitate dell’Impero romano. Ma scrivere 16 capitoli – l’esposizione più lunga della somma delle sue convinzioni teologiche – solo per beneficiare di un punto di appoggio durante un breve passaggio appare sproporzionato. Lo stupore si accresce quando Paolo afferma che intende recarsi a Gerusalemme per portare la colletta per i cristiani di quella città: una colletta che egli sta organizzando da diversi anni (cfr 1 Cor 16,1-4; 2 Cor 8; Rm 15,25-28). Alcuni esegeti hanno quindi avanzato l’ipotesi che la lettera ai Romani sia in qualche modo il testamento teologico di Paolo, in cui egli mette interamente per iscritto le sue idee[5]. Prima di rischiare la vita a Gerusalemme, egli vuole che lo si giudichi non in base a delle voci, ma alla sostanza. Questa lettera sarebbe allora in qualche modo l’ambasciata scritta che Paolo manda avanti a sé, perché la si legga anche a Gerusalemme e alcuni dei suoi critici rivedano il loro giudizio su di lui.
La comunità di Roma ha la specificità di non essere stata fondata, a quanto pare, da qualche apostolo in particolare, pur essendo molto antica. Gli storici ipotizzano che alcuni cristiani vi siano giunti molto presto, dopo la risurrezione di Gesù, come schiavi, liberti o mercanti, e che i cristiani vi abbiano in qualche modo preceduto gli apostoli. In ogni caso, in Rm 16,7 Paolo saluta Andronico e Giunia, che sono stati cristiani prima di lui. Ovviamente essi possono essere stati battezzati in Asia prima di recarsi a Roma, ma in ogni caso a Roma si trovano alcuni cristiani della prima generazione. Capitale dell’Impero e centro delle comunicazioni, Roma è la destinazione ideale affinché una lettera circoli molto rapidamente e largamente, soprattutto se Paolo scrive in autunno, prima della tradizionale «chiusura del Mediterraneo» alla navigazione commerciale ordinaria e quando circolano solo le navi della posta imperiale e i convogli tra Roma e Alessandria. Così la sua lettera sarebbe potuta arrivare a Gerusalemme per la primavera. Questa ipotesi spiegherebbe bene perché la lettera ai Romani è in qualche modo il testamento teologico e spirituale di Paolo. In essa, infatti, si offre l’esposizione più completa del suo Vangelo, del suo insegnamento.
Podcast | SUD SUDAN. «UN CONFLITTO CHE NON È MAI FINITO»
Quattro milioni di sfollati, oltre 350mila morti, fame e povertà. Il Sud Sudan è il paese più giovane del mondo, con una storia già segnata dalle violenze. Oggi lo spettro della guerra torna a far paura, come racconta mons. Christian Carlassare, vescovo della diocesi di Bentiu. Ascolta il podcast
Paolo sa di essere molto criticato e che molte voci l’accusano. Lo si giudica lassista sul piano morale, e Rm 3,8 vi fa chiaramente allusione: «E non è come alcuni ci fanno dire: “Facciamo il male perché ne venga il bene”; essi ci calunniano ed è giusto che siano condannati». La ragione principale è di dichiarare il suo amore per il suo popolo e di comunicare che una rivelazione divina gli ha fatto anticipare la salvezza di «tutto Israele» (cfr Rm 9-11). Paolo non vuole che delle voci determinino la sua accoglienza a Gerusalemme, o piuttosto vuol fare di tutto per placare quelle che egli considera delle calunnie.
Un altro fattore spiega – e giustifica – il fatto che Paolo scriva ai romani: egli conosce molti di quella comunità. Quando, nel 49, l’imperatore Claudio aveva espulso da Roma i capi ebrei divenuti cristiani (e certamente anche qualcuno dei loro oppositori ebrei delle sinagoghe)[6], alcuni di quei cristiani espulsi si erano ritrovati in Grecia, in particolare a Corinto, dove Paolo li avrebbe incontrati, come riferisce Luca in At 18. Egli diventa dunque amico di una coppia missionaria formata da Prisca e Aquila. Alla morte di Claudio e dopo l’avvento di Nerone, alcuni degli espulsi erano certamente tornati a Roma; e sono questi cristiani conosciuti in Asia che Paolo può salutare alla fine della lettera ai Romani.
Sebbene fossero attraversate da correnti e teologie diverse, le comunità cristiane erano animate anche da un forte desiderio di comunione reciproca e di solidarietà concreta tra loro, senza dimenticare il potente fermento di unione costituito dai sacramenti fondamentali del battesimo e dell’Eucaristia che avevano in comune. Le lettere ne testimoniano sia la diversità sia la comunione. L’ultimo viaggio di Paolo a Gerusalemme e la lettera che scrive ai Romani testimoniano il suo desiderio ardente che le sue comunità ellenistiche, a maggioranza pagano-cristiana, siano in vera comunione con le «Chiese madri» della Giudea, che per la maggior parte erano di origine ebraica.
Paolo ha esitato a lungo prima di fare questo viaggio a Gerusalemme. Ne conosce i rischi. Del resto, all’inizio, non pensava di farlo personalmente, ma di inviare dei messaggeri: «Quando arriverò, quelli che avrete scelto li manderò io con una mia lettera per portare il dono della vostra generosità a Gerusalemme. E se converrà che vada anch’io, essi verranno con me» (1 Cor 16,3-4). Ma quella in gioco è una posta di importanza capitale. Da alcuni anni Paolo faceva raccogliere denaro per «i santi che sono a Gerusalemme». Ai Galati aveva detto che era una promessa fatta durante il suo passaggio a Gerusalemme: «Ci pregarono soltanto di ricordarci dei poveri, ed è quello che mi sono preoccupato di fare» (Gal 2,10).
Per Paolo, la colletta sarà il segno della comunione profonda tra le Chiese pagano-cristiane dell’Asia minore e della Grecia con quella di Gerusalemme. Per lui, la comunione spirituale non si può separare da quella materiale, e gli scambi finanziari fanno parte della natura della Chiesa. L’universalità della Chiesa si traduce nella condivisione dei beni: Gesù è morto per tutti. Non è possibile ricordarsi di Cristo senza ricordarsi dei poveri, dei santi che sono a Gerusalemme, dei cristiani che vivono nelle comunità meno ricche rispetto a Corinto o a Tessalonica. E, per quanto si sia poveri, occorre in ogni caso essere generosi. Scrive infatti Paolo ai Corinzi: «Riguardo poi alla colletta in favore dei santi, fate anche voi come ho ordinato alle Chiese della Galazia. Ogni primo giorno della settimana ciascuno di voi metta da parte ciò che è riuscito a risparmiare, perché le collette non si facciano quando verrò» (1 Cor 16,1-2).
Paolo fonda questa colletta sul fatto che le comunità paoline hanno beneficiato della fede e che partecipano alle promesse di Israele: per questo devono essere riconoscenti. Così tutta la teologia che Paolo espone nella lettera ai Romani ha la sua corrispondenza nello scambio dei beni materiali. Sarà questa missione a mostrare, con una bella somma di moneta sonante, che i cristiani di origine pagana sono in piena comunione con quelli di origine ebraica. Paolo è fiero di questa iniziativa. La colletta è la garanzia finanziaria della sua ambizione religiosa e comunitaria: i pagano-cristiani sono cristiani a pieno diritto, e non cristiani di seconda classe[7]. Tutti partecipano dello stesso Cristo nel quale sono stati battezzati. Tutti sono associati alle stesse promesse, avendo ricevuto lo stesso Spirito.
Dalla fine del primo secolo, le lettere di Paolo, come quelle di Pietro e di Giacomo, saranno lette in tutte le Chiese. Non sappiamo se storicamente la colletta di Paolo sia stata accettata, ma certamente il messaggio che essa trasmetteva ha avuto successo. Luca ha scelto di non parlarne, per sottolineare che è stato proprio lo Spirito a spingere Paolo a recarsi a Gerusalemme. Luca va direttamente al motivo spirituale di quel viaggio e sottolinea la corrispondenza tra la salita di Gesù a Gerusalemme, per dare la vita per Israele e per la moltitudine, e quella di Paolo, che sale anche lui per dare la vita per la comunione di tutti i cristiani.
Le lettere: un fatto teologico
Il fatto che alcuni cristiani abbiano potuto prendere la parola a nome proprio per discutere questioni concrete delle loro comunità e che quanto hanno detto sia stato molto presto considerato ispirato da Dio non è evidentemente insignificante: è un fatto di un’importanza teologica capitale. Alcuni uomini hanno scritto con spontaneità e rigore per condividere le loro convinzioni, e proprio queste espressioni sono state giudicate degne di appartenere al Nuovo Testamento, alla rivelazione di Dio. Così questo fatto è in qualche modo una sorta di prolungamento della logica più grande del cristianesimo, quella dell’incarnazione. Dio può comunicare sé stesso in un uomo e attraverso delle parole umane. La natura varia dei testi del Nuovo Testamento è una sorta di corrispettivo letterario a una convinzione teologica, quella cioè che Dio parla mediante gli uomini, e lo Spirito Santo continua ad agire nelle parole dei primi apostoli e dei loro successori. Un esegeta ha fatto notare che, a ben guardare, è tutta la Bibbia che riflette una struttura dialogica, come uno scambio continuo tra Dio e gli uomini[8]. Dio agisce, prende in qualche modo la parola, e poi l’uomo risponde, si mette a sua volta a parlare, e questa parola viene riconosciuta come proveniente anch’essa da Dio. Uno dei criteri della canonicità degli scritti era che potessero essere letti nella liturgia[9].
Conclusioni
Quando Dio prende la parola, si fa carne in un uomo che non ha scritto nulla e fa in modo che altri uomini prendano la parola: parole umane e parole divine sono inseparabili. Le lettere del Nuovo Testamento sono una testimonianza insostituibile dell’incredibile libertà donata dallo Spirito di Dio: sono un’eco preziosa delle gioie e delle speranze, delle sofferenze e dei drammi di un gruppo di uomini del I secolo, senza i quali il nostro mondo non sarebbe quello che è. Leggere queste lettere significa entrare nell’intimità di quelle piccolissime comunità che erano ospitate talora in casa di qualche notabile (Febe, Erasto ecc.), erano esposte all’ostilità degli ambienti in cui vivevano, e spesso delle proprie famiglie, celebravano un culto domestico sobrio e vivevano una forte solidarietà.
Certo, tra loro vi erano molti schiavi e persone senza istruzione. Ma vi è stato anche un fariseo di Tarso (un’informazione sulle sue origini è fornita da Luca in At 9,11), un uomo formato al meglio della retorica greca e della sapienza ermeneutica degli ebrei, un figlio della tribù di Beniamino, un cittadino romano. È stato con questo «strumento scelto», con questo stupendo «vaso di elezione» (At 9,15), che la parola del Vangelo ha preso vita con tutta la sua forza. Paolo è stato il primo a scrivere delle lettere, e questa iniziativa è stata imitata da alcuni cristiani delle altre Chiese. Grazie a loro, il modo in cui il messaggio di Gesù ha potuto essere compreso e messo in pratica dalle prime generazioni cristiane diviene, per così dire, tangibile. Ormai è impossibile separare i Vangeli dalle lettere che li declinano. Una lezione da meditare sempre.
Copyright © La Civiltà Cattolica 2024
Riproduzione riservata
***
[1]. Gli studiosi ritengono che la tradizione giovannea provenga da un discepolo della prima ora, un certo «Giovanni l’anziano (o il presbitero)», che abitava a Gerusalemme, e non in Galilea, ed era vicino agli ambienti sacerdotali.
[2]. Cfr J. Ratzinger, Gesù di Nazaret. Seconda Parte. Dall’ingresso in Gerusalemme fino alla risurrezione, Città del Vaticano, Libreria Editrice Vaticana, 2011, in particolare il capitolo 8, dedicato alla risurrezione.
[3]. Si veda, per una dimostrazione succinta, ma brillante, di questa tesi, E. Przywara, Agostino inForma l’Occidente, Milano, Jaca Book, 2007.
[4]. E anche di più, se con molti esegeti recenti si considera il Vangelo di Marco come fortemente paolino.
[5]. Cfr G. Bornkamm, «The Letter to the Romans as Paul’s Last Will and Testament», in K. P. Donfried (ed.), The Romans Debate, Edinburgh, T. & T. Clark, 1991, 16-28.
[6]. Questo decreto di espulsione, di cui parla lo storico romano Svetonio, viene datato al 41 o al 49, l’anno attualmente più favorito dagli studiosi.
[7]. Cfr le pagine incisive del pensatore ebreo J. Taubes, La théologie politique de Paul, Paris, Seuil, 1999, 38-40 (in it. La teologia politica di san Paolo. Lezioni tenute dal 23 al 27 febbraio 1987 alla Forschungsstätte della Evangelische Studiengemeinschaft di Heidelberg, Milano, Adelphi, 1997, 43-49).
[8]. Cfr W. Vogels, «La structure symétrique de la Bible chrétienne», in J.-M. Auwers – J. H. de Jonge (edd.), The Biblical Canons, Leuven, Peeters, 2003, 295-304.
[9]. Cfr B. Sesboüé, «Essai de théologie systématique sur le canon des Écritures», in AA.VV., Le canon des Écritures, Paris, Cerf, 1990, 523-539.