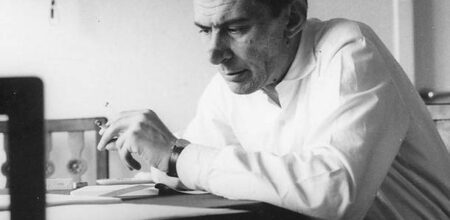|
|
Quando papa Francesco parla della sinodalità, sottolinea spesso l’importanza dello Spirito Santo. Per esempio, descrive lo Spirito come il «grande protagonista della Chiesa»[1], esorta ripetutamente ad ascoltare «ciò che lo Spirito dice alle Chiese» (Ap 2,7)[2] e afferma che dobbiamo accogliere la novità che lo Spirito può portarci[3]. I teologi si sono messi in questa disposizione. Durante un recente convegno teologico sulla sinodalità, svoltosi all’Università Gregoriana dal 27 al 29 aprile 2023, è stata evidenziata l’azione dello Spirito nei battezzati, nella Chiesa e nel mondo.
È bene soffermarsi sul ruolo di protagonista dello Spirito Santo anche per un motivo più specifico. Secondo Austen Ivereigh, biografo del Papa, la fede nell’azione dello Spirito è uno dei due elementi che si devono riconoscere per «cogliere» l’idea di sinodalità di Francesco[4].
Ci proponiamo qui di esporre alcune esitazioni a parlare dello Spirito Santo che a volte hanno caratterizzato la Chiesa occidentale. In quella luce, le affermazioni di papa Francesco sullo Spirito Santo in relazione alla sinodalità risaltano e delineano quella che si potrebbe chiamare una «riconfigurazione pneumatologica della Chiesa».
Proprio come la sinodalità comporta cambiamenti (o riconfigurazioni) nel trovare il bilanciamento fra l’autorità gerarchica e il popolo di Dio nel suo insieme[5], così è anche riguardo a Cristo e allo Spirito. L’attenzione allo Spirito che è insita nella sinodalità integra l’abituale stima che la Chiesa occidentale ha di Cristo con una rivalutazione dello Spirito[6].
Esitazioni a parlare dello Spirito
La Chiesa occidentale viene talvolta accusata di Geistvergessenheit, ossia di una «tendenza a dimenticare lo Spirito Santo». In effetti, gli antichi mosaici absidali nelle chiese di Roma e altrove s’incentrano su Cristo piuttosto che sullo Spirito. Tale consuetudine è ancora viva.
I teologi talvolta parlano dello Spirito come della «Cenerentola della teologia»: come nella fiaba Cenerentola non veniva invitata alla festa, la stessa sorte tocca allo Spirito Santo. Accade pure che lo Spirito venga sostituito da altri soggetti. Nella sua celebre trilogia Credo nello Spirito Santo, il domenicano francese Yves Congar fornisce un elenco di «sostituzioni e alibi dello Spirito Santo», che comprendono l’Eucaristia, Maria e il Papa[7].
L’esitazione a parlare dello Spirito Santo può assumere anche una forma più sottile. In questi casi si parla dello Spirito Santo, ma in modo tale che la sua importanza sia chiaramente secondaria rispetto a quella di Cristo o dell’autorità ecclesiale. Affermazioni di questo tipo sottolineano caratteristicamente che lo Spirito è inviato da Cristo; che ci aiuta a capire ciò che Cristo ha rivelato; o che la gerarchia è stata dotata dello Spirito.
Tutte queste affermazioni sono vere, ma incomplete. Infatti, come lo Spirito dipende da Cristo, così pure Cristo dipende dallo Spirito, come si vede specialmente nel Vangelo di Luca. E come lo Spirito serve la rivelazione di Cristo, così pure rinnova tale rivelazione, perché «guiderà a tutta la verità», come dice il Vangelo di Giovanni (Gv 16,13).
L’esempio più forte dello Spirito che conduce al rinnovamento lo troviamo nel drastico cambiamento di rotta della Chiesa primitiva che viene descritto nei capitoli 10 e 15 degli Atti degli Apostoli. Infine, sebbene lo Spirito sia donato in modo speciale alla gerarchia, si deve anche riconoscerne l’azione in tutti i fedeli, nonché evitare di «addomesticarlo» nelle strutture e nelle istituzioni ecclesiali[8].
Papa Francesco sullo Spirito Santo
In questo contesto, le affermazioni di papa Francesco sullo Spirito Santo come protagonista della vita ecclesiale risaltano chiaramente. Non c’è traccia di Geistvergessenheit, in nessuna forma. Il Papa crede fermamente nello Spirito, «che è Signore e dà la vita», come affermiamo nel Credo[9]. Per esempio, alla vigilia dell’inizio del Sinodo 2021-24, Francesco ha avviato la sua riflessione con un atto di fede nello Spirito Santo: «Sono certo che lo Spirito ci guiderà e ci darà la grazia di andare avanti insieme, di ascoltarci reciprocamente e di avviare un discernimento nel nostro tempo, diventando solidali con le fatiche e i desideri dell’umanità»[10].
Inoltre, il Papa crede che lo Spirito operi in tutti i battezzati. Ricorda spesso che, secondo Lumen gentium, n. 12, lo Spirito Santo «suscita e sorregge» in tutti i fedeli la comprensione intuitiva della verità, o sensus fidei. Nel discorso pronunciato nel 2015 per commemorare l’istituzione del Sinodo dei vescovi, Francesco concludeva che «il sensus fidei impedisce di fare una rigida separazione tra Ecclesia docens ed Ecclesia discens, giacché anche il Gregge possiede un proprio “fiuto” per discernere le nuove strade che il Signore dischiude alla Chiesa»[11].
Pertanto, l’implicazione pratica della dottrina del sensus fidelium è che dovremmo accogliere la conversazione e il dialogo come atteggiamenti fondamentali che facilitano l’apertura allo Spirito. È importante sottolineare che coloro che prendono parte al dialogo dovrebbero essere disposti a imparare gli uni dagli altri e, in ultima analisi, dallo Spirito. Il Papa ha parlato di «un ascolto reciproco in cui ciascuno ha qualcosa da imparare. Popolo fedele, collegio episcopale, vescovo di Roma: l’uno in ascolto degli altri; e tutti in ascolto dello Spirito Santo, lo “Spirito della verità” (Gv 14,17), per conoscere ciò che Egli “dice alle Chiese” (Ap 2,7)». Inoltre, in questo dialogo dovremmo essere attenti anche ai nostri fratelli e sorelle bisognosi, ai segni dei tempi e alle grida della Terra.
Credere nella guida e nell’autorità dello Spirito Santo implica l’apertura a nuove prospettive. Se la guida dello Spirito è reale, Egli può condurci in una direzione nuova. Durante la Messa di apertura del Sinodo, nell’ottobre 2021, il Papa ha ricordato che «lo Spirito Santo soffia in modo sempre sorprendente, per suggerire percorsi e linguaggi nuovi». Il Sinodo è come un pellegrinaggio durante il quale dobbiamo amare il Vangelo ed essere «aperti alle sorprese dello Spirito Santo»[12].
L’aspetto caratteristico di queste sorprese non è il fatto che siano nuove e quindi migliori, ma che nuove prospettive aiutino ad affrontare nuove situazioni o nuove domande. Nel libro-intervista curato da Ivereigh, il Papa ha portato l’esempio del Sinodo sulla Famiglia: «Eppure lo Spirito ci ha salvati alla fine, con una svolta […]. Questo è stato il grande progresso a cui lo Spirito ci ha portato: una migliore sintesi di verità e misericordia in una rinnovata comprensione tratta dalla nostra tradizione»[13].
Francesco afferma che «uno dei doni dello Spirito nel processo sinodale è rivelare ideologie e intenti nascosti»[14]. Tuttavia, una conversazione pacata, con la disponibilità ad apprendere, porterà senza dubbio a un processo di raffinamento che implica anche la conversione e che alla fine condurrà a quell’armonia che è il segno distintivo dello Spirito. «A determinare quell’armonia è lo Spirito Santo», dice il Papa[15].
Lo Spirito agisce
Un elemento importante è che Francesco evidenzia innanzitutto l’azione dello Spirito. Lo Spirito Santo non viene soltanto menzionato, ma opera cose concrete. Nei testi fin qui citati lo abbiamo visto agire da protagonista, guidare, donare la grazia, parlare alle Chiese, soffiare in modi sorprendenti, suggerire nuovi percorsi e nuovi linguaggi, salvare, smascherare intenzioni, portare pace e armonia. Il Papa usa di rado espressioni indefinite come «nello Spirito Santo», mentre preferisce usare verbi assertivi: lo Spirito agisce, prende l’iniziativa. Come fa notare Ivereigh, «per Bergoglio non c’è sinodalità se manca non solo la presenza, ma anche l’azione dello Spirito»[16].
La preghiera Adsumus, che è stata proposta per sostenere spiritualmente il cammino sinodale[17], considera lo Spirito Santo una guida che «ci assiste», e confessa che Egli «agisce in tutti i tempi e in tutti i luoghi». Nella preghiera chiediamo allo Spirito: «Scendi nei nostri cuori», «insegnaci tu ciò che dobbiamo fare, mostraci tu il cammino da seguire tutti insieme» e non lasciare che ci sviamo. Questa preghiera riecheggia la pneumatologia attiva del Papa; e il liturgista Martin Klöckener fa osservare che il destinatario della preghiera Adsumus è lo Spirito Santo, fatto insolito nelle preghiere liturgiche latine, così come in diverse liturgie orientali[18].
Questo è un primo aspetto di quella che si potrebbe definire la «riconfigurazione pneumatologica di papa Francesco». La parola «riconfigurazione» indica che le cose stanno cambiando. In questo caso, il cambiamento riguarda le interpretazioni del mistero trinitario.
La teologia e la spiritualità occidentali, per difendere l’unità di Dio, spesso sono state piuttosto discrete nello specificare il ruolo delle Persone divine. La teologia trinitaria spiega che tutto ciò che Dio fa per la nostra salvezza va visto come opera dell’unico Dio, piuttosto che come l’azione individuale di una delle tre Persone divine, ossia che opera ad extra indivisa sunt.
Anche se ci possono essere buone ragioni per riferire la creazione al Padre, in definitiva è il Dio unico – o la Trinità nel suo insieme – che crea. E così accade pure per la redenzione e la santificazione. Per ragioni che qui non possiamo approfondire, in alcuni periodi della storia la teologia di fatto ha portato a concentrare l’attenzione su Cristo, a spese dello Spirito Santo.
L’interesse di Francesco per l’azione dello Spirito aiuta a delineare un ritratto trinitario più equilibrato. In effetti, per vivere una vita pienamente cristiana, abbiamo bisogno sia della certa rivelazione di Cristo sia dell’attualizzazione che ne compie lo Spirito qui e ora. In occasione della Pentecoste dello scorso anno, il Papa ha spiegato: «Lo Spirito Santo, infatti, quando insegna, attualizza. […] Porta nell’oggi l’attualità di Gesù, risorto e vivo»[19].
Il benedettino americano Kilian McDonnell riassume egregiamente la complementarità dello Spirito e del Figlio con queste parole: «Senza la missione dello Spirito, la Chiesa rimane nella fissità, in una splendida stasi, congelata nel tempo, senza movimento, senza fine. […] [Per contro,] senza la missione del Figlio, lo Spirito è una scala che non porta da nessuna parte, e la storia non arriva mai al Padre»[20].
Lo Spirito e la Chiesa
Una seconda riconfigurazione riguarda la Chiesa. Alla luce della priorità del battesimo e del popolo di Dio nel suo insieme, tutti i fedeli hanno un ruolo significativo da svolgere, ma occorre anche aggiungere che in questo lo Spirito Santo è di un’importanza decisiva. All’inizio del cammino sinodale Francesco ha giustamente ricordato ai fedeli di Roma che «tutti sono protagonisti».
Ha sviluppato il concetto spiegando che, in questo processo, i fedeli sono fondamentalmente uguali: «Non è più protagonista il Papa, il cardinale vicario, i vescovi ausiliari». Ma c’è un’eccezione: lo Spirito Santo. Ha affermato Francesco: «Sempre c’è lo Spirito come grande protagonista della Chiesa»[21]. Così l’importanza del battesimo e del popolo di Dio nel suo insieme è controbilanciata da quella fondamentale dello Spirito.
Una Chiesa di questo tipo è costruita sul sacramento del battesimo e promuove la partecipazione. Come ha ricordato Francesco, «il punto di partenza, nel corpo ecclesiale, è questo e nessun altro: il battesimo. Da esso, nostra sorgente di vita, deriva l’uguale dignità dei figli di Dio, pur nella differenza di ministeri e carismi. Per questo tutti sono chiamati a partecipare alla vita della Chiesa e alla sua missione»[22]. Il Papa ha aggiunto che in questa direzione sono stati compiuti dei progressi, ma che si può fare ancora di più. Questa riconfigurazione battesimale non esclude il sacramento dell’Ordine e il ministero gerarchico, ma suggerisce un equilibrio diverso[23].
Per uno sviluppo ulteriore di questo concetto, è utile l’insegnamento di Lumen gentium, n. 12, secondo cui lo Spirito guida la Chiesa attraverso i doni gerarchici e carismatici. Afferma il testo: «Inoltre lo Spirito Santo non si limita a santificare e a guidare il popolo di Dio per mezzo dei sacramenti e dei ministeri, e ad adornarlo di virtù, ma “distribuendo a ciascuno i propri doni come piace a lui” (1 Cor 12,11), dispensa pure tra i fedeli di ogni ordine grazie speciali, con le quali li rende adatti e pronti ad assumersi vari incarichi e uffici utili al rinnovamento e alla maggiore espansione della Chiesa». In altre parole, lo Spirito è la guida effettiva della Chiesa e, per svolgere la sua missione, si avvale sia del ministero gerarchico sia dei carismi.
Ciò equivale a una riconfigurazione pneumatologica della Chiesa. La visione gerarchica della Chiesa viene completata da quella della Chiesa come corpo carismatico. Pensiamo alla metafora biblica del corpo nella Prima lettera di Paolo ai Corinzi. L’Apostolo ricordava ai cristiani dell’epoca che non era il caso di gloriarsi dei propri doni, ma piuttosto di condividere i doni spirituali che erano stati loro dati (cfr 1 Cor 12) in spirito di servizio (cfr 1 Cor 14) e di amore (cfr 1 Cor 13). Qui la metafora cristologica del corpo e l’approccio pneumatologico dei carismi si intrecciano mirabilmente.
Una riconfigurazione pneumatologica della Chiesa in questa direzione può contribuire anche a proteggerci dal pericolo di quella che si potrebbe chiamare una «gerarchia carismatica». In effetti, le spiacevoli esperienze che si sono avute con personaggi carismatici che rivendicavano lo Spirito Santo, mentre le loro azioni suggerivano tutt’altro, sono tra le ragioni principali delle tradizionali esitazioni a parlare dello Spirito. Abbiamo esempi recenti di persone ritenute esemplari, ma che hanno rivelato l’abuso scandaloso del loro comportamento e l’indole manipolatoria del loro insegnamento.
«IN MARE APERTO». Papa Francesco e La Civiltà Cattolica
A 10 anni dalla prima udienza di papa Francesco a La Civiltà Cattolica, la rivista internazionale dei gesuiti raccoglie e pubblica in un volume gli interventi che il Pontefice le ha dedicato in questo tempo. Scaricalo gratuitamente!
La visione dello Spirito che ha papa Francesco suggerisce che la via da seguire non è quella di eliminare lo Spirito, ma di adottare piuttosto una diversa visione della pneumatologia, secondo la quale qualsiasi autorità nella Chiesa, compresa quella carismatica, è sottoposta a un’autorità superiore, lo Spirito Santo, e pertanto dovrebbe essere umile. Inoltre, qualsiasi autorità nella Chiesa, compresa quella carismatica, dovrebbe promuovere l’inclusione e la partecipazione, perché lo Spirito non è mai dato a una sola persona, ma a tutti.
Lo Spirito, la verità e l’apertura
Una terza riconfigurazione pneumatologica riguarda la verità e l’apertura. Ovviamente una Chiesa sinodale apprezza con tutto il cuore la dottrina e la pratica cattolica tradizionali, ma, grazie allo Spirito Santo, la Chiesa è anche aperta alla domanda su come il Vangelo vada meglio proclamato e vissuto qui e ora.
Come affermava il Papa, «lo Spirito Santo […], quando insegna, attualizza: mantiene la fede sempre giovane. Noi rischiamo di fare della fede una cosa da museo: è il rischio! Lui invece la mette al passo coi tempi, sempre al giorno, la fede al giorno: è questo il suo lavoro»[24]. La scelta delle parole ricorda il discorso Gaudet Mater Ecclesia pronunciato da papa Giovanni XXIII nell’apertura del Concilio Vaticano II. Usando la metafora dell’antiquitas che la fede non dovrebbe essere, egli mostrava di desiderare piuttosto che la Chiesa parlasse delle stesse verità in modo diverso, più accessibile[25].
Pertanto, l’azione dello Spirito Santo è fondamentale per comprendere l’apertura che deve caratterizzare i processi sinodali. Francesco, infatti, all’inizio del Sinodo nella diocesi di Roma, ha invocato uno spirito così aperto da chiamarlo «ermeneutica pellegrina, cioè che è in cammino». Ha spiegato che la Chiesa è sempre stata pellegrina, dagli Atti degli Apostoli al Vaticano II e fino ai giorni nostri, e che così deve essere. «Quando la Chiesa si ferma, non è più Chiesa, ma una bella associazione pia perché ingabbia lo Spirito Santo»[26]. Dunque, Francesco promuove un tipo specifico di «docilità e apertura allo Spirito» che lascia che Egli ci parli in un ampio processo di ascolto che accoglie voci che non ci sono familiari.
È importante riconoscere che questa apertura richiede umiltà, nel senso di essere profondamente convinti che nessuno di noi ha tutte le risposte certe. Già nella sua intervista del 2013 a p. Spadaro, il Papa si riferiva alla virtù del saper dubitare: «Se una persona dice che ha incontrato Dio con certezza totale e non è sfiorata da un margine di incertezza, allora non va bene. Per me questa è una chiave importante. […] Le grandi guide del popolo di Dio, come Mosè, hanno sempre lasciato spazio al dubbio. Si deve lasciare spazio al Signore, non alle nostre certezze; bisogna essere umili»[27].
È anche importante sottolineare che la via per superare il dubbio e giungere a una conclusione non è il dibattito intellettuale, ma il discernimento spirituale. Parlando con Ivereigh, Francesco ha spiegato che i momenti di silenzio tra i discorsi durante le sessioni sinodali avevano lo scopo di permettere ai partecipanti di «percepire meglio le mozioni dello Spirito»[28].
Simili mozioni richiamano un tipico elemento ignaziano: quello del discernimento. In sostanza, esso cerca di comprendere affettivamente se in una data idea o azione sia all’opera lo Spirito di Dio oppure lo spirito cattivo. Di solito, un certo sentimento di pace tranquilla, di sapienza umile, di pazienza fiduciosa e di spirito di misericordia e di servizio sono segnali che si è sulla strada giusta[29].
Da un punto di vista psicologico, una simile apertura è ardua. La natura umana ha bisogno di sicurezze, e questa è un’altra importante ragione delle tradizionali esitazioni a parlare dello Spirito Santo: alla natura sfuggente dello Spirito preferiamo le certezze del passato e la chiarezza della guida gerarchica. Perciò il Papa, nel citato discorso del 2015, ha sottolineato che chi partecipa a un Sinodo ha bisogno di ricevere dallo Spirito Santo il dono dell’ascolto: «Dallo Spirito Santo per i Padri sinodali chiediamo, innanzitutto, il dono dell’ascolto: ascolto di Dio, fino a sentire con Lui il grido del Popolo; ascolto del Popolo, fino a respirarvi la volontà a cui Dio ci chiama»[30]. Ovviamente, l’autorità gerarchica è riconosciuta, ma viene reimmaginata come parte di un processo di ascolto spirituale inclusivo e ricettivo il cui fine è ascoltare ciò che lo Spirito sta dicendo.
Conclusione
Pur rispettando l’autorità gerarchica, una visione pneumatologica della Chiesa promuove la varietà dei doni carismatici e delle intuizioni di fede che sussistono al suo interno. Inoltre, tale visione pneumatologica mostra che la Chiesa è pellegrina, e sottolinea la natura dinamica e viva della tradizione della Chiesa. Queste immagini teologiche hanno conseguenze pratiche. Uno stile di vita sinodale verrà arricchito da pratiche e virtù come la complementarità, il dialogo, l’ascolto, l’apprendimento, la reciprocità e l’apertura.
Una prospettiva pneumatologica indica il fondamento più profondo dell’impegno sinodale e della Chiesa in generale: lo Spirito Santo, che non solo ha parlato nel passato, ma parla anche nel presente, e può parlare attraverso tutti i nostri fratelli e sorelle, oltre che attraverso l’autorità ecclesiale. La prospettiva pneumatologica consente così di reinterpretare il percorso sinodale come un cammino spirituale condiviso, piuttosto che come un processo guidato da interessi di parte.
Copyright © La Civiltà Cattolica 2023
Riproduzione riservata
***
-
. Francesco, Discorso ai fedeli della diocesi di Roma, 18 settembre 2021. ↑
-
. Cfr ivi. ↑
-
. Cfr Id., «Accogliere la novità che lo Spirito desidera rivelarci», in Id., Ritorniamo a sognare. La strada verso un futuro migliore, Milano, Piemme, 2020, 107. ↑
-
. Cfr A. Ivereigh, «Hearing the Spirit in the Assembly of the People: Pope Francis’s Vision of Synodality», in Studium 117 (2021/3) 359. ↑
-
. Cfr M. Wijlens, «Reforming the Church by Hitting the Reset Button: Reconfiguring Collegiality within Synodality because of “sensus fidei fidelium”», in The Canonist 8 (2017) 235-261. ↑
-
. I contenuti di questo articolo vengono approfonditi in J. Moons, The Holy Spirit, the Church, and Pneumatological Renewal: “Mystici Corporis”, “Lumen Gentium” and Beyond, Leiden, Brill, 2022; Id., «The Holy Spirit as the Protagonist of the Synod. Pope Francis’s Creative Reception of the Second Vatican Council», in Theological Studies 84 (2023) 61-78. ↑
-
. Cfr Y. Congar, Credo nello Spirito Santo, vol. 1, Brescia, Queriniana, 1981, 181-186. ↑
-
. Cfr W. Kasper, «La Chiesa sacramento dello Spirito», in W. Kasper – G. Sauter, La Chiesa luogo dello Spirito, Brescia, Queriniana, 1980, 71-98. ↑
-
. Per una presentazione della pneumatologia di Francesco diversa da quella indicata qui, cfr V. Codina, «El Espíritu Santo en Francisco», in Revista Latinoamericana de Teología 35 (2018) 153-167. ↑
-
. Francesco, Discorso in occasione del momento di riflessione per l’inizio del Percorso sinodale, 9 ottobre 2021. ↑
-
. Id., Discorso nella commemorazione del 50° anniversario dell’istituzione del Sinodo dei vescovi, 17 ottobre 2015. ↑
-
. Id., Omelia nella celebrazione dell’Eucaristia per l’apertura del Sinodo sulla sinodalità, 10 ottobre 2021. ↑
-
. Id., Ritorniamo a sognare…, cit., 101. ↑
-
. Ivi, 99. ↑
-
. Ivi, 93. ↑
-
. A. Ivereigh, «Hearing the Spirit in the Assembly of the People», cit., 359. ↑
-
. La preghiera è presente in varie traduzioni nel sito del Sinodo (www.synod.va/en/resources/the-adsumus-prayer.html). ↑
-
. Cfr M. Klöckener, «La prière d’ouverture des conciles “Adsumus”: de l’Espagne wisigothique à la liturgie Romaine d’après Vatican II», in A. M. Triacca – A. Pistoia (edd.), La prière liturgique. 47e Semaine d’études liturgiques, Roma, Centro Liturgico Vincenziano, 2001, 179. ↑
-
. Francesco, Regina Coeli nella Solennità di Pentecoste, 5 giugno 2022. ↑
-
. K. McDonnell, The Other Hand of God: The Holy Spirit as the Universal Touch and Goal, Collegeville, MN, Liturgical Press, 2003, 228 s. ↑
-
. Francesco, Discorso ai fedeli della diocesi di Roma, cit. ↑
-
. Id., Discorso in occasione del momento di riflessione per l’inizio del Percorso sinodale, cit. ↑
-
. Per approfondire il tema, cfr O. Rush, «Inverting the Pyramid: The “Sensus Fidelium” in a Synodal Church», in Theological Studies 78 (2017) 299-325. ↑
-
. Francesco, Regina Coeli nella Solennità di Pentecoste, cit. ↑
-
. Cfr Giovanni XXIII, s., Discorso nella solenne apertura del Concilio Ecumenico Vaticano II, 11 ottobre 1962. ↑
-
. Francesco, Discorso ai fedeli della diocesi di Roma, cit. ↑
-
. A. Spadaro, «Intervista a papa Francesco», in Civ. Catt. 2013 III 449-477. ↑
-
. Francesco, Ritorniamo a sognare, cit., 98. ↑
-
. Per ulteriori approfondimenti sul tema, cfr J. Moons, «Synodality and Discernment. The Affective Reconfiguration of the Church», in Studia Canonica 56 (2022) 379-393. ↑
-
. Francesco, Discorso nella commemorazione del 50° anniversario dell’istituzione del Sinodo dei vescovi, cit. ↑