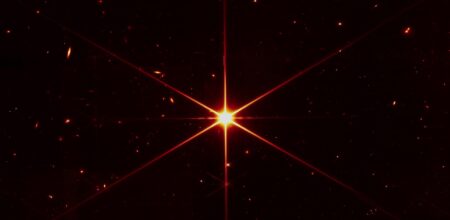Malgrado i loro poteri sovrani, gli Stati avranno grandi difficoltà a mantenere le promesse del primo Summit della Terra, tenutosi a Rio de Janeiro nel 1992. Si trattava di associare, in nome dello sviluppo sostenibile, l’economia all’ecologia. Si cercava allora la pietra filosofale: una crescita economica senza crescita del consumo di energia fossile né aumento del consumo di risorse non rinnovabili.
Nel quadro delle risorse naturali – per non parlare dei problemi del riscaldamento climatico –, questa difficoltà di far convergere le esigenze economiche, sociali, di governo ed ecologiche è illustrata da un problema oggi fondamentale: la gestione – pubblica o privata – dell’acqua. Nel dicembre 2021 la rivista Promotio Iustitiae (organo della Compagnia di Gesù per la giustizia sociale) ha avvertito i suoi lettori con il titolo: «Il grido dell’acqua e il grido dei poveri». Bisognerebbe dire piuttosto: il grido dell’acqua «è» il grido dei poveri, degli esclusi e degli emarginati.
Il nostro Pianeta è ricoperto d’acqua per tre quarti della sua superficie. Il 97,2% è l’acqua salata dei mari, alla quale si aggiunge l’acqua salata di alcune falde sotterranee. L’acqua dolce (2,8% del totale) si trova essenzialmente (2,1% del totale dell’acqua del globo) nei ghiacci dei poli Nord e Sud. Rimane pertanto come acqua utilizzabile sulla terraferma solo uno 0,7% del totale, valutato tra 900.000 e 1.800.000 chilometri cubi, con cui rifornire tutti gli abitanti della Terra, le loro colture agricole (70% dell’acqua dolce consumata), l’industria (20%) e gli usi domestici (10%).
Sfortunatamente, l’acqua utilizzabile è distribuita molto male. Inoltre, la ricarica annuale delle falde acquifere è limitata a 12.000 chilometri cubi ogni anno, con una domanda che cresce dell’1% l’anno[1]. Il che, a seconda della regione e degli scenari climatici, porterà entro il 2100 a un calo – tra i 50 centimetri e i 10 metri – del livello delle falde acquifere. La tendenza generale non è buona, a causa della crescita dell’urbanizzazione, dell’industrializzazione, dei modelli di consumo alimentare che determinano le colture e il loro fabbisogno idrico, per non parlare della siccità cronica in alcune regioni. Cina, Brasile, Canada, Marocco, Tunisia, diverse regioni francesi e anche il Portogallo ne sono gravemente colpiti. Da vari mesi le dighe idroelettriche sono ferme in Portogallo. In Australia come in Cile, e nella stessa California, la siccità ha portato all’abbandono di aziende agricole a causa del prosciugamento delle falde acquifere.
Questo è il motivo per cui, contrariamente alla teoria secondo la quale l’acqua potabile sarebbe presente in quantità sufficiente per il Pianeta, in realtà più di un miliardo di persone già non hanno accesso all’acqua potabile. Al problema dell’approvvigionamento dell’acqua si aggiunge quello della qualità dell’acqua disponibile. Qui si intrecciano questioni di clima, di geologia, di stoccaggio, di distanza e di tempo per accedere all’acqua: problemi che non devono farci dimenticare il dramma dell’erosione del suolo, del degrado ambientale e dell’inquinamento. Nelle regioni ad alta intensità agricola c’è il problema dei fertilizzanti – in particolare quelli azotati –, che possono rendere l’acqua non potabile[2]. Inoltre, i nitrati favoriscono la proliferazione delle alghe verdi sulle coste e non risparmiano nemmeno l’atmosfera, perché il protossido di azoto è un gas a effetto serra molto potente. Per non parlare dell’ammoniaca, che favorisce la produzione di microparticelle.
Gli effetti della deforestazione
Per questo la Conferenza degli Stati parte alla Convenzione delle Nazioni Unite per il clima, nella sua riunione annuale del novembre 2021 (Cop26) a Glasgow, ha affrontato ancora una volta il problema della deforestazione (già incluso nell’agenda del 2020). Un centinaio di Paesi si sono impegnati a fermare la deforestazione, che svolge un ruolo fondamentale nel ciclo dell’acqua. Questo impegno riguarda quasi l’85% della superficie boschiva mondiale. Non stiamo parlando dello sfruttamento delle foreste – i cui alberi ricrescono dopo un abbattimento ragionato –, ma della sterilizzazione delle aree boschive a causa della scomparsa di specie arboree necessarie per la rigenerazione delle foreste, anche a motivo delle strade, delle miniere, delle ferrovie, dei siti industriali o amministrativi, dell’urbanizzazione e, non da ultimo, delle aree occupate dalle colture. Alcuni Paesi – in particolare Brasile e Congo – avranno sicuramente difficoltà a mantenere tali promesse.
Vogliamo sottolineare questo impegno per le foreste, perché esso mette concretamente in evidenza ciò che è richiesto dall’ecologia integrale, tanto cara a papa Francesco. La riduzione della superficie boschiva del Pianeta risale ai tempi del Neolitico: è iniziata con la messa a coltura dei cereali quasi 13.000 anni fa. La coltivazione dei cereali ha plasmato i paesaggi del Pianeta, facendo arretrare le foreste e consentendo una crescita demografica in osmosi con lo sviluppo ambivalente delle civiltà.
Dalla Mezzaluna Fertile di cereali del Vicino Oriente alle distese d’America dove trionfa la coltivazione del mais, dalla quinoa latinoamericana all’orzo tibetano, dal riso africano al farro, dall’amaranto al frumento, i cereali hanno permesso gli scambi commerciali, l’emergere delle città, lo sviluppo di imperi, il tutto immerso in una ritualità al tempo stesso simbolica e tecnica, e nel fiorire di riti della fertilità. In questa dialettica, l’uomo forgiava la natura, e al contempo veniva plasmato da essa nelle sue pratiche, nelle sue istituzioni e nelle sue rappresentazioni simboliche e religiose.
Contro questa narrazione, che cancella la separazione troppo intellettuale fra natura e cultura, sottolineiamo il fatto che i simboli non hanno la neutralità ecologica che alcuni attribuiscono a essi. L’acqua dolce non solo è geograficamente mal distribuita, ma viene anche mal utilizzata. Facciamo solo due esempi. Il consumo della carne dipende sia da una differente condizione sociale sia dalla dieta. Ebbene, esso monopolizza una parte importante della superficie coltivata (pensiamo alla produzione di sorgo, soia o mais, coltivati per nutrire gli animali). Allo stesso modo, facciamo cenno alla passione per lo sport automobilistico della Formula 1. I responsabili, tenendosi alla larga dall’energia elettrica, che ha comunque dimostrato il suo potenziale, annunciano che si stanno orientando verso il bioetanolo e altri biocarburanti; si compiacciono di questa energia «ecologica al 100%» (sic!), che hanno inserito nei regolamenti della F1. Non si rendono conto che la coltivazione necessaria per i biocarburanti, come l’allevamento del bestiame per il consumo di carne, rafforza potentemente l’espansione dei terreni agricoli e delle colture vegetali per il consumo umano, a discapito della foresta, e quindi contribuisce al riscaldamento globale.
Più urgente oggi è il problema della gestione delle acque. La gestione privata dell’acqua è preferibile? Dovrebbe essere affidata a un’autorità pubblica, a un organismo intercomunale? In ogni caso, c’è il rischio della burocrazia, della negligenza, e talvolta anche della corruzione. Questo è un interessante argomento di discernimento politico.
La responsabilità degli Stati
L’acqua potabile, necessaria per la vita, fa parte – come l’aria non inquinata, l’energia pulita e lo spazio vitale – dei beni comuni che appartengono a tutti. Il bene pubblico dell’acqua è quello che già il Congresso di Vienna, nel 1815, aveva proclamato riguardo ai fiumi europei (Reno, Rodano, Danubio ecc.): a nessun Paese era permesso di appropriarsi, per mezzo di dighe o di altro, dell’acqua di tali fiumi. Si è trattato di un ritorno agli antichi «metodi di produzione asiatici», dove l’amministrazione locale, dirigendo una rete di piccoli canali, gestiva la distribuzione dell’acqua. Il principio dell’acqua fluviale in quanto bene comune per tutti i Paesi irrigati è stato applicato in alcune parti dell’Asia. Ma ovviamente non in Medio Oriente.
Così, il 20 febbraio 2022, le prime due turbine elettriche della Grande diga del rinascimento etiope (Gerd) sono state collegate alla rete elettrica. Questa enorme diga, la più grande dell’Africa – lunga 1,8 chilometri e alta 145 metri, che contiene 13,5 miliardi di metri cubi di acqua, ed è costata 4,2 miliardi di dollari –, programmata fin dal 2011, costruita dall’Etiopia sul Nilo Azzurro, vicino al confine con il Sudan, è il motivo di un conflitto diplomatico irrisolto fra tre Paesi bagnati dal Nilo. In effetti, milioni di persone in Sudan e in Egitto dipendono dalle acque del Nilo. Le controversie sono state sottoposte in prima istanza all’arbitrato del Consiglio di Sicurezza dell’Onu, che le ha scaricate sull’Unione africana. Non c’è stato nessun risultato concreto. Certo, nel 1929 l’Egitto aveva firmato un protocollo con il Sudan che vietava a quest’ultimo di costruire una diga sul fiume. Nel 1959, un accordo concedeva all’Egitto i due terzi del flusso annuale del Nilo. Ma l’Etiopia, non essendo parte dell’accordo, non si è mai sentita vincolata da esso. Inoltre, un nuovo accordo firmato dai Paesi del bacino del Nilo contro il parere di Egitto e Sudan, ha rimosso il veto dell’Egitto e ha permesso progetti di dighe e di irrigazione.
L’acqua è considerata «bene pubblico», perché la sua fornitura è di competenza dello Stato. È stata riconosciuta come «diritto umano fondamentale» nel luglio 2010 dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite, seguendo le Blue Communities[3]. Due mesi dopo, le ha fatto eco la Risoluzione del Consiglio dei diritti umani, che ha chiarito gli obblighi degli Stati relativi all’accesso all’acqua e ai servizi igienico-sanitari. Già un certo numero di Paesi – tra cui Etiopia, Uruguay, Colombia, Francia, Regno dei Paesi Bassi, Ecuador e Belgio – hanno sancito nelle loro costituzioni il diritto all’acqua potabile. In definitiva, nessuno dovrebbe esserne privato. Da qui l’indignazione per la privatizzazione dell’acqua.
L’acqua è vitale per le popolazioni e per le relazioni fra regioni e Paesi. Sotto l’effetto del riscaldamento globale, il livello del mare si sta innalzando, al punto di allagare intere regioni, mentre quello dei laghi e delle falde acquifere si sta abbassando. L’innalzamento del livello del mare, causato non solo dallo scioglimento dei ghiacciai e dei poli, ma anche dall’aumento della temperatura dell’acqua del mare, accresce la pressione dell’acqua salata su quella dolce nelle zone costiere. Così le isole di Tuvalu, dove vivono quasi 12.000 abitanti a circa 500 chilometri dalle Figi, non hanno più acqua potabile. Le Kiribati, che oggi si trovano tre metri sopra il livello del mare, sono minacciate. Se la tendenza attuale continuerà, tra 25 anni il Vietnam avrà perso il 10% della sua superficie.
Altrove, l’acqua è carente per ragioni politiche, come in Medio Oriente, ma talvolta anche per ragioni economiche di incuria. Ricordiamo il lago d’Aral, difficile da rigenerare, tra il Kazakistan e l’Uzbekistan.
Il problema dell’acqua non può che peggiorare, perché, anche tenendo conto dell’evoluzione degli standard di vita e delle esigenze dell’agricoltura e dell’industria, le risorse sfruttabili del Pianeta non potranno bastare per gli 11 miliardi di abitanti del Pianeta previsti per l’anno 2100. Sommando tutti gli usi dell’acqua, il consumo oggi raggiunge i 4.000 litri al giorno pro capite. I circa 12.000 chilometri cubi di ricarica naturale delle falde acquifere non saranno sufficienti, tanto più che la distribuzione molto disuguale dei prelievi e delle ricariche dalle falde acquifere fa aumentare drammaticamente la desertificazione.
Frenare la deriva
Ci sono senza dubbio alcune tecniche per ricaricare le falde acquifere: bacini di infiltrazione, pozzi di iniezione, deviazione dei corsi d’acqua per convogliare parte della corrente, stoccaggio dell’acqua piovana, per non parlare delle nuove tecniche di produzione dell’acqua potabile: oltre alla desalinizzazione dell’acqua di mare (che consuma però molta energia), il miglioramento dei processi igienico-sanitari, lo sfruttamento degli iceberg e l’utilizzazione del vapore acqueo dall’atmosfera e dalle nuvole. Ma le condizioni geologiche e climatiche di tali tecniche rispondono in maniera solo marginale al problema della rigenerazione dell’acqua.
In questo settore vitale, come in molti altri, notiamo innanzitutto le carenze dell’autorità pubblica: nessun obiettivo preciso – in mancanza di una quantificazione –, né mezzi proporzionati per affrontare questa sfida strutturale. Finora, i controlli sembrano insufficienti. Inoltre, vengono concesse sempre più autorizzazioni – a volte attraverso la corruzione –, per permettere a determinate colture di superare le dosi consentite di fertilizzante azotato (170 chilogrammi per ettaro l’anno).
Certamente si possono dare molti consigli per bilanciare meglio i fertilizzanti, ma manca un chiaro impegno da parte degli Stati. Bisognerebbe modificare le tecniche agricole e le pratiche abituali dei contadini, due terzi dei quali, secondo le stime dei consulenti agricoli, tendono – è umano – a spargere più fertilizzanti azotati del necessario.
Sul Pianeta c’è sempre la stessa quantità di acqua, ma non della stessa qualità. In passato, bastava la natura per rendere sicura l’acqua. Gli strati superficiali del suolo filtravano le acque reflue; le piante e le radici neutralizzavano quasi tutti gli elementi inquinanti. Oggi non è più così. L’agricoltura intensiva scarica nel terreno nitrati, fosfati e pesticidi; l’industria sversa policlorobifenili e altri coloranti; gli esseri umani immettono in circolo residui chimici di farmaci e detergenti: ognuno agisce come se fosse il proprietario dell’acqua, potendola usare, sprecare e maltrattare.
Oggi senza dubbio l’inquinamento è meglio controllato. Contrariamente a una credenza diffusa, gli agricoltori occidentali hanno compiuto con successo sforzi enormi per promuovere sistemi naturali basati su una modalità di produzione che limiti la necessità di fertilizzanti azotati e di diserbanti chimici. Vi sono stati spinti dalla regolamentazione, ma vi hanno anche trovato il loro tornaconto. Su consiglio di agronomi specializzati, le acque reflue attualmente possono essere rigenerate attraverso un sistema di stagni piantumati con erbe selezionate, il che è anche alla portata di alcune industrie agroalimentari che operano nelle zone rurali.
Nonostante ciò, soprattutto nelle aree urbanizzate, le acque reflue devono essere depurate per mezzo di stagni di decantazione e, per eliminare gli agenti patogeni, occorre utilizzare o prodotti chimici – una volta l’ipoclorito di sodio (meglio noto come candeggina), in seguito il cloro o l’ozono –, o meccanismi fisici, raggi ultravioletti, membrane di ultrafiltrazione. Queste operazioni di disinquinamento pesano in bolletta più del costo di raccolta e trasporto dell’acqua, almeno se escludiamo la distribuzione tramite cisterne o tramite rivenditori ambulanti nelle aree del Terzo e Quarto Mondo.
L’appropriazione delle fonti
Dietro le questioni della gestione e della distribuzione dell’acqua c’è lo spinoso problema della proprietà privata delle fonti e delle risorse idriche. Come classificare gli innumerevoli contadini del Pianeta che si appropriano dell’acqua dei loro pozzi o delle sorgenti che sgorgano sulla loro terra, o addirittura installano pompe che attingono acqua dalle falde acquifere per innaffiare campi e giardini? Comuni e circoscrizioni[4] si stanno organizzando ovunque per raccogliere l’acqua e distribuirla tra loro a un prezzo inferiore a quello offerto dai servizi idrici gestiti dal settore privato o da un ente comunale, cercando di distribuire le risorse idriche e i relativi costi in modo più equo su un territorio più ampio. Qui si manifesta crudelmente l’ambivalenza dei fenomeni di rete: da una parte, l’aiuto per coloro che ne fanno parte (che in questo caso sono, letteralmente, «connessi» alla rete); dall’altra, l’estromissione delle popolazioni escluse, con grave danno della solidarietà, che dovrebbe imporsi in una questione così vitale.
Che si tratti di fiumi, laghi, falde acquifere (acque sotterranee), vapore acqueo nell’atmosfera o nuvole, sorgono delle domande – rese obbligatorie dalla destinazione universale dei beni – non appena l’appropriazione da parte di alcuni limiti quella di altri. L’acqua che sgorga da un terreno appartiene al proprietario di esso in maniera simile alla maggior parte delle sorgenti di acqua minerale vendute in bottiglia? L’acqua sanificata appartiene all’ente pubblico o all’azienda sanitaria? L’acqua di una diga appartiene al costruttore della diga, al comune o alle popolazioni dei bacini idrografici? Chi deve pagare per l’acqua potabile sprecata nei tubi che perdono? Si stima che, a seconda del Paese, tra il 30% e il 50% dell’acqua potabile venga sprecata a causa di perdite del sistema idrico.
Tenuti nascosti, questi problemi di appropriazione delle risorse idriche sono la causa di molti insuccessi nelle privatizzazioni, incoraggiate dal Fmi e dalla Banca Mondiale in nome del rigore economico, e previste da comuni o da Stati – ad esempio, dalla Colombia –, avendo bisogno di razionalizzare e universalizzare la loro rete di distribuzione dell’acqua. All’impresa privata o all’ente pubblico viene concesso di accedere a fonti di cui in precedenza si era appropriata una comunità locale, con conseguenti conflitti a volte di grande violenza, come è avvenuto a Cochabamba, in Bolivia, dove una sanguinosa rivolta popolare è riuscita a rimuovere una società concessionaria privata, senza però che la distribuzione di acqua sicura fosse garantita a tutti. Nel migliore dei casi, come in Svizzera, le norme statali antepongono il bene più universale all’interesse di un determinato gruppo, anche comunale.
Poiché l’acqua ha un costo, gli economisti si allontanano dal concetto di diritto universale per prendere in esame ciò che conoscono meglio, il concetto di merce. Di lì a favorire una gestione privata c’è solo un passo da fare, che richiede però un discernimento. Acquisita da un individuo, da una piccola comunità o da un’azienda privata, l’acqua potabile diventa una merce in balìa dei capricci della speculazione finanziaria, con grande danno per i più poveri.
La privatizzazione della distribuzione
Oltre all’appropriazione delle riserve idriche, la distribuzione dell’acqua consente vari tipi di privatizzazione. Se le regole non sono buone, se la negoziazione del contratto è stata viziata o, peggio ancora, condizionata da qualche forma di corruzione, il risultato della privatizzazione è disastroso. Il punto più delicato – generalmente trascurato da chi si oppone alla privatizzazione – è lo stato di degrado dei sistemi idrici messi a disposizione delle aziende private, che devono poi ripristinarli. Per questo è fuorviante sostenere che nella maggior parte dei casi il prezzo dell’acqua aumenta, o che la qualità del servizio peggiora quando la gestione diventa privata. Perché, nel migliore dei casi – cioè, a prescindere dalla corruzione –, questo aumento non fa che reintegrare nel prezzo la manutenzione e gli investimenti che non erano stati fatti in precedenza.
Poiché l’acqua non è più gratuita, sorgono subito delle domande concrete. Chi dovrebbe pagare per il trasporto dell’acqua e per la sua depurazione: il consumatore, dal momento che l’acqua ha un valore di mercato, o il contribuente, dal momento che l’acqua – come in passato quella della fontana comunale al centro del paese – è un bene pubblico? Chi dovrebbe gestire le reti di approvvigionamento idrico e igienico-sanitario: un’autorità pubblica o un’azienda privata? In Svizzera, la gestione dell’acqua è in gran parte effettuata da autorità pubbliche o da società con capitale prevalentemente pubblico. In Francia, quasi il 75% dell’acqua potabile nelle città è gestito da tre grandi aziende private: Veolia, Suez Environnement e Saur.
Si deve anche parlare dell’acqua in bottiglia, dove la francese Danone e la svizzera Nestlé – due aziende private – fanno la parte del leone nel mercato mondiale, con vari marchi (Evian, Contrex, San Pellegrino, Volvic, Perrier ecc.). Attualmente, si vendono nel mondo quasi 470 miliardi di bottiglie d’acqua ogni anno – rispetto ad appena un miliardo di mezzo secolo fa –, con grande danno per le falde acquifere (Contrex nei Vosgi, Volvic nel Massiccio Centrale), oltre alle conseguenze negative provocate dalla distribuzione di acqua in bottiglia, come l’inquinamento degli oceani causato da materie plastiche, per non parlare dell’ecologia dei trasporti.
La gestione e il controllo
Pro o contro la privatizzazione dell’acqua? Gli esempi abbondano in un senso o nell’altro. Occorre esaminare di volta in volta ciò che è stato oggetto di negoziazione: l’acquisto di una rete esistente, con o senza un’adeguata regolamentazione? Il suo noleggio? La sua manutenzione? Una concessione con obiettivi e sanzioni specificati dal contratto? La creazione di un serbatoio d’acqua? La fornitura di infrastrutture o attrezzature? La bonifica dell’acqua rientra negli obblighi negoziati? Occorre tener conto di tutti questi elementi, quando si vogliono confrontare le varie modalità di gestione, pubbliche, private o miste.
È vero che i servizi di pubblica utilità beneficiano generalmente di un tasso di indebitamento finanziario inferiore rispetto a quello del settore privato, il che normalmente consente loro di investire a un costo inferiore; ma questo riflette solo il fatto che la collettività – cioè i contribuenti – si assume i rischi di fallimento del gestore pubblico. C’è solo un trasferimento di costi. «In diverse città – afferma un attivista contrario alla privatizzazione – la privatizzazione ha significato tagli ai servizi, peggioramento della qualità dell’acqua, fino al punto di condizioni antigieniche, deterioramento delle infrastrutture e negligenza». Questo è vero soprattutto quando le autorità pubbliche firmano contratti unilaterali, per incompetenza o sotto la pressione della corruzione. Spesso i funzionari pubblici si lasciano semplicemente trascinare sulla via più facile, scommettendo ingenuamente sull’esperienza delle società concessionarie, senza mettere in atto un vero e proprio sistema di controlli o sanzioni.
«Non c’è alcuna concorrenza nei servizi idrici che possa ridurre i prezzi»: questa frase, che spesso si sente dire, deve essere sfumata. Una dozzina di aziende internazionali si spartiscono il gigantesco mercato potenziale delle principali città del mondo. Inoltre, esse sono ancora sotto minaccia di nazionalizzazione o di acquisizione da parte di un ente pubblico. Così, nel 2010 la città di Parigi ha rilevato la concessione del servizio idrico affidata alle società che in precedenza la gestivano: Veolia per il nord – riva destra della Senna; Suez per il sud – riva sinistra. Certamente il buon senso afferma: «C’è solo un condotto dell’acqua collegato a ogni casa, il che a volte è falso, e l’acqua è essenziale e non ha sostituti». Ma nulla vieta, come già avviene per la distribuzione del gas e dell’energia elettrica, di affidare a una società privata o a un ente pubblico la manutenzione delle reti, e ad altro ente, pubblico o privato in concorrenza con altri, la fornitura dell’acqua o la sua fatturazione.
Chi si oppone alla privatizzazione sottolinea giustamente che «nella gestione pubblica non c’è la necessità di realizzare un profitto». L’argomento può essere ribaltato, sottolineando che, se diminuisce il profitto, allo stesso modo scompare la spinta a migliorare e a cercare nuovi modi di procedere. Ciò compensa in parte la mancanza di trasparenza attribuita al settore privato. Per quanto riguarda la corruzione – che è onnipresente nel settore idrico –, purtroppo essa non è monopolio del settore privato.
Il ritorno dei tecnocrati
Rimane un’ultima domanda: perché alcuni funzionari comunali o nazionali di provata onestà propendono per la gestione privata del servizio idrico, o addirittura per la privatizzazione delle fonti? Il motivo è finanziario. Alla stregua dei governi che danno concessioni autostradali, o vendono aeroporti o frequenze radio, tali funzionari considerano la privatizzazione come un modo per sanare temporaneamente le finanze o ridurre il debito pubblico. Questo è solo un modo per posticipare le spese essenziali per il buon funzionamento della rete. Nel complesso, l’economia trionfa sempre; perché, in un modo o nell’altro, sono i cittadini che pagano gli investimenti necessari, o con una tassa, o con una bolletta dell’acqua o, in mancanza di queste, con il degrado della rete. In una società urbana come la nostra, dove l’acqua, anche quando è abbondante, genera un costo di trasporto e, ancor più, di sanificazione, non c’è più acqua potabile gratuita, come non ci sono pasti gratuiti: No free lunch, dicono gli economisti.
Di conseguenza, vediamo come le leggi relative alla gestione dell’acqua suscitino solo controversie. Alcuni accusano la legge di aprire la porta alla privatizzazione, i leader politici lo negano. Ogni elettore si può informare, prima di tutto, sui pro e i contro delle normative contestate, ma anche sulla complessità tecnico-economica di questo tipo di problema. Tuttavia l’informazione, per quanto seria possa essere, non dispenserà gli elettori dall’assumersi il rischio del discernimento personale, secondo i valori che li animano, tra cui l’attenzione ai più deboli (e non alla maggioranza), che normalmente caratterizza la tradizione cristiana, secondo la dottrina sociale della Chiesa.
L’atteggiamento civico in questo settore si oppone alla cultura capitalista. Consiste nell’ammettere che i dati e le analisi tecnico-economiche condizionano le opzioni politiche, ma non dovrebbero mai determinarle completamente. Non solo perché ciò che è legale non è sempre l’espressione di ciò che è legittimo – questo è il criterio fondamentale della vita politica –, ma anche perché i valori sostenuti da ciascuno degli elettori inducono analisi e opzioni tecnico-economiche diverse. L’opposto si chiama «tecnocrazia», che fa passare opzioni morali e politiche con il pretesto di vincoli tecnici o prestazioni economiche. In un altro ambito, vicino per le sue implicazioni biologiche, l’episodio del Covid-19 è stato l’esempio di come i vincoli tecnico-sanitari, che cambiavano a seconda dello stato della ricerca e della disponibilità di attrezzature sanitarie, abbiano determinato le politiche, fino al punto in cui l’economia ha ricordato duramente i suoi imperativi.
Il clericalismo di oggi
Assieme a quello della tecnocrazia, incombe anche un altro pericolo. Non è nuovo, ma assume un nuovo volto nel capitalismo contemporaneo. È il pericolo del clericalismo moralistico. Esso consiste nel far passare delle opzioni morali e politiche in nome di un’autorità economica che non ha la competenza per farlo. L’economia non ha di diritto il primato sulla tecnologia, e tanto meno sulla moralità, così come un campione di calcio non ha più competenza di chiunque di noi per stabilire se privatizzare o meno la distribuzione dell’acqua in una città. Tutto dipende, infatti, dall’obiettivo perseguito, un obiettivo che condiziona i vincoli resi noti dalla scienza e dalla tecnologia. Tale obiettivo è determinato soprattutto dall’orizzonte temporale che ciascuno si assume e, in definitiva, dal senso della propria vita: senso a sua volta influenzato dal cammino personale di ciascuno e dalle circostanze politico-culturali che ha attraversato. Anche qui si presenta la dialettica tra le prestazioni economiche e gli obiettivi ecologici e sociali, che è la scommessa dello sviluppo integrale.
In passato, il clericalismo si concentrava sui «chierici», cioè su quegli intellettuali il cui archetipo, a partire dal Concilio di Trento nel XVI secolo, era il sacerdote cattolico romano. Ignorando – o fingendo di ignorare – le nuove forme di clericalismo al servizio della tecnocrazia capitalista, alcuni ancora concentrano i loro attacchi sui sacerdoti; senza voler essere contrari alla religione, essi sostengono semplicemente di «ricordare alle Chiese i loro doveri». Insomma, come dicevano gli anticlericali durante la Terza Repubblica, «i preti in sacrestia!». Il che significa dimenticare che i sacerdoti sono anche cittadini che, come in ogni Stato di diritto, godono della libertà di coscienza e della capacità di esprimere pubblicamente le loro opinioni religiose e morali. Significa anche dimenticare – con buona pace dei tecnocrati – ciò che Max Weber aveva scoperto: la compenetrazione degli elementi economico, sociale e religioso. Qualunque sia il modello utilizzato per affrontare il problema vitale della gestione delle acque – sia esso privato, comunale o pubblico –, la soluzione non può prescindere da un organismo di gestione collettiva, normativo e vincolante, che possa articolare, come richiede la dottrina sociale della Chiesa, la necessaria solidarietà – limitando, per quanto possibile, il massimo prelievo dalle falde acquifere – con l’auspicabile autonomia di chi ne sostiene direttamente il costo.
Copyright © La Civiltà Cattolica 2022
Riproduzione riservata
***
[1]. Le falde acquifere una volta erano indicate con l’espressione «falde freatiche», che non sono laghi sotterranei, ma rocce imbevute d’acqua.
[2]. Sappiamo che i nitrati, derivanti da un’ossidazione dell’azoto che entra nella maggior parte dei fertilizzanti, a una certa concentrazione (50 mg/l secondo gli standard dell’Organizzazione mondiale della sanità [Oms]) rendono l’acqua non potabile.
[3]. Le Blue Communities sono unioni di comunità pubbliche che lavorano per il controllo e la distribuzione equa dell’acqua potabile. Il movimento è nato in Canada all’inizio di questo millennio e si è diffuso in tutto il mondo.
[4]. Le circoscrizioni sono una parte del territorio del comune, ad esempio una frazione in un’area rurale quando il comune raggruppa più frazioni. In alcuni Paesi – ad esempio in Francia – essi hanno una personalità giuridica riconosciuta a livello amministrativo.