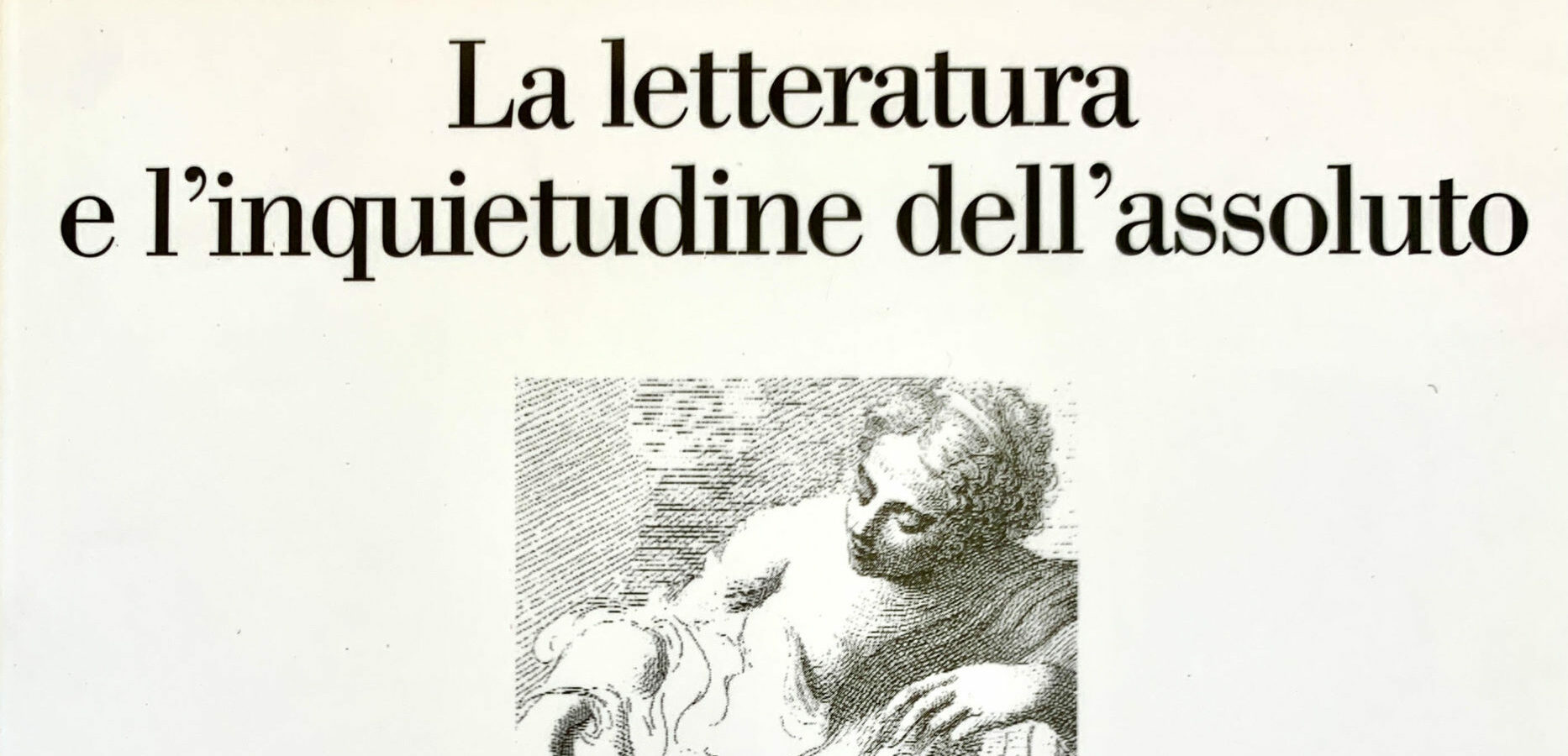
|
|
«Vivevo una completa schizoidia, una giustapposizione tra il lettore appassionato che sono sempre stato, l’uomo che aveva tratto dalla letteratura una parte della sua sostanza viva e della sua riflessione sull’esistenza, e lo specialista di una teologia cristiana che pure volevo accordare alla modernità»[1]: da questo contrasto tutto interiore tra il teologo e l’appassionato lettore di romanzi e poesia, Jean-Pierre Jossua, domenicano francese, già professore e rettore della Facoltà di Teologia di Le Saulchoir, avvia la propria riflessione di teologia letteraria. Nella sua fondamentale Pour une histoire religieuse de l’expérience littéraire[2] egli si definisce «dogmatico insoddisfatto»[3]. Il dissidio è soltanto il sintomo di un problema più vasto. A suo giudizio, in generale, dopo «il fuoco di paglia del romanticismo “cristiano” alla Chateaubriand»[4], la situazione di separazione tra teologia e cultura si è evoluta negativamente fino ad oggi[5]. Uno degli autori di riferimento assunti da Jossua è Henri Bremond (1865-1933), il quale all’inizio del secolo scorso certamente ha colto bene questa separazione, che in certi momenti è divenuta vera e propria ostilità. Bremond ne ha sofferto e ha cercato una mediazione, proponendosi di «mostrare a un pubblico colto il potere letterario del pensiero o della sensibilità religiosa e il loro interesse universale» e di «fare scoprire ai suoi lettori cattolici il valore religioso della letteratura “profana”»[6].
Jossua, richiamandosi al pensiero di Bremond, tematizza l’attuale divorzio tra cristianesimo e cultura consumatosi con l’Illuminismo e ne prospetta un superamento. Un dato risulta chiaro e incontrovertibile: il problema è, in buona parte, linguistico. Quale linguaggio oggi è chiamato a esprimere il mistero e l’esperienza cristiani? A giudizio di Jossua, la separazione tra cultura e fede potrà essere superata solamente quando il linguaggio teologico e quello letterario potranno integrarsi in maniera naturale e spontanea. Con la sua Histoire littéraire du sentiment religieux, Bremond aveva cercato di percorrere questo sentiero attraverso la riscoperta degli autori religiosi del Sei-Settecento, cercando l’unità tra mistica e letteratura, tra l’esperienza di Dio e la parola poetica. Oggi la domanda di Jossua è simile e, dopo le riflessioni successive alla seconda guerra mondiale di Ch. Moeller[7], H. U. von Balthasar, Blanchet, si chiede: «Cosa può dire la letteratura, meglio di una teologia puramente concettuale, del mistero della fede e dell’esistenza cristiana con la quale l’una e l’altra si confrontano?»[8]. Il teologo domenicano però prende subito le distanze da tutte quelle impostazioni — che sembrano imperanti nel mondo teologico attuale — che cercano corrispondenze esplicite o implicite tra la letteratura moderna e le questioni teologiche, tra poesia e dogmatica: per Jossua il contributo che la letteratura ha da offrire alla teologia non va ricercato innanzitutto nell’ordine delle concordanze tematiche, ma in quello della creatività linguistica, del vigore espressivo e dell’efficacia rappresentativa.
Allora ciò che caratterizza la ricerca intellettuale del teologo di Le Saulchoir è l’attenzione al problema del linguaggio, inteso non solo come strumento di comunicazione e di espressione, ma soprattutto come luogo privilegiato della presa di coscienza di sé e del mondo, e della testimonianza di fede[9]. Avvia dunque un itinerario alla scoperta «di ciò che rappresenta la creazione letteraria come avventura spirituale e come cammino per lo scrittore»[10].
Teologia ancorata all’esperienza e linguaggio
Jossua avanza l’esigenza che la teologia sappia ancorarsi all’esperienza e ritrovare, a partire da essa, il contatto con le forme quotidiane di confronto tra gli uomini, a costo che il mistero non appaia se non attraverso le tracce lasciate nell’esperienza stessa[11]. Il nucleo di partenza del proprio discorso circa il linguaggio letterario è una necessità teologica: la fede deve esprimersi. Senza questa espressione ne andrebbe compromessa la propria universalità[12]. D’altra parte lo stesso linguaggio del kèrygma sembra un linguaggio da iniziati, cosa che non accadeva nel mondo giudaico e nemmeno del tutto nel mondo greco[13]. Il fatto è, afferma Jossua, che le persone che i cristiani incontrano e alle quali vogliono dare la propria testimonianza cristiana sono spesso non credenti, ma non «pagani»: essi sono dei post-cristiani, e la loro mentalità è segnata dal fatto di pensare di aver superato il cristianesimo; essi si pongono al di là di esso per criticarlo, rifiutarlo o reinterpretarlo. Le vie di accesso e i segni di credibilità dei praeambula fidei in questo contesto diventano fallimentari.
Scrive Jossua: «Mi sembra che, nella maggioranza dei casi, la verifica reale, la ragione di credere che garantisce alla fede la sua validità intellettuale, sia interna a questa stessa fede. È la multiforme ricchezza dell’esperienza cristiana che, con la sua stessa fecondità, garantisce al soggetto, quando ne prende coscienza, che non è nell’illusione, anche se rimane, nella sua scelta, al di fuori di ogni sicurezza che gli venga attraverso delle prove. È questa ricchezza che, superando la prova accettata, gli dimostra, continuando il cammino, che può resistere allo scontro con la critica. È questa ricchezza che i cristiani si comunicano a modo di simbolo…»[14]. La domanda allora è: se un uomo non si trova nel cerchio di questa esperienza originale e di questo linguaggio cifrato, come vi entra?
Jossua si concentra sull’espressione «esperienza cristiana» e afferma che esiste esperienza quando accade qualcosa percepita come significativa da chi ne è coinvolto ed è accompagnata sempre da un’interpretazione, da una lettura intelligente di ciò che è còlto e percepito. «Parlare di esperienza cristiana equivale, dunque, a esprimere un insieme coordinato di esperienze particolari, vissute, riflesse e interpretate da credenti»[15].
Il contenuto della confessione di fede è il Cristo: non Dio rivestito di umanità, ma Dio come uomo. In Cristo l’aspetto più trascendente si manifesta in quello più umano. Allora bisogna dire che il luogo in cui normalmente si realizza l’incontro personale con Dio dev’essere l’esistenza, l’esperienza umana del cristiano, e non il sovraumano, l’insolito, ciò che è fuori del comune[16]. Come dire questa esperienza cristiana? Se essa è completamente umana, perché non sarebbe umanamente esprimibile? «E ciò a costo che il simbolo — ma non quello che presuppone l’iniziazione — si sostituisca spesso alla descrizione, che il mistero che la configura non appaia se non attraverso le tracce che lo stesso mistero vi lascia, e che a volte il silenzio localizzi questi presentimenti che non potrebbero essere detti da nessuna parola. Non potremmo dire ai nostri amici in un linguaggio universale, senza avere davanti altro che lo scambio, ciò che ci rende l’esperienza cristiana così preziosa?»[17].
Jossua ha risposto a questa domanda con un volume, scritto a più mani con altri due confratelli domenicani, dal titolo Une foi exposée[18]. Ma ha sviluppato pure, attraverso brevi saggi, un più ampio progetto di riesame, paziente e sistematico, dell’esperienza del teologo, attraverso l’esperienza propria dello scrittore. Egli si è misurato, prima, col proprio mondo intellettuale e culturale, il mondo delle proprie letture con il volume Lecture en écho[19], poi col proprio mondo interiore, psicologico e spirituale nel suo L’écoute et l’attente[20]. L’attenzione si concentra sulla ricerca di un linguaggio che sappia essere parola teologica tesa a unire contenuto e forma della rivelazione, sul modello, mai raggiungibile, ma sempre esemplare e normativo, della Scrittura.
La domanda di una «teologia letteraria»
L’approfondirsi della ricerca di Jossua, nella direzione di una parola sempre più personale e sempre più creativa, lo conduce singolarmente non a perdersi nella soggettività, bensì alla riscoperta del rigore del linguaggio, del suo potere simbolico e della stessa forza espressiva assunta dal silenzio quando si fa pausa nel discorso e spazio bianco nel libro. Egli si chiede che cosa sia possibile fare per richiamare l’attenzione della riflessione cristiana sul potere religioso della letteratura e dell’arte in genere. La letteratura non può forse dire, in maniera diversa da una teologia puramente concettuale, il mistero della fede e dell’esperienza cristiana? Non è forse giunto il tempo di riscoprire la forza creatrice, anche nel campo del linguaggio religioso, della letteratura e la sua autentica capacità teologica? La riflessione teologica, infatti, riconosce oggi non solo la legittimità dell’espressione poetica e narrativa della fede, ma va prendendo coscienza che il linguaggio simbolico e letterario ha anch’esso la sua grammatica e la sua dialettica, il suo rigore espressivo e le sue regole interpretative.
Il problema che orienta, infatti, l’individuazione dei temi e delle tecniche che hanno significato per l’espressione di fede e il collegamento tra essi e le sorgenti dell’esperienza cristiana non esigono minore formazione e competenza teologica da parte di chi si dedica a questo tipo di critica di quanto è richiesta a chi si occupa di lavori più classici. A questi ultimi, del resto, non pretende di sostituirsi, ma cerca piuttosto di essere un nuovo e necessario sviluppo della disciplina teologica. Jossua accetta la sfida del diretto confronto tra teologia e letteratura sul terreno letterario. Nell’indicare il tipo di lettura che egli opera e propone appare chiaro che una vera teologia poetica non è mai una dottrina che si fa poema. Essa invece è una creazione che, per le sue stesse esigenze espressive, permette di accostare il divino in modo insieme rigoroso e potentemente suggestivo, grazie a immagini e a forme linguistiche. Allora Jossua pone alcune condizioni perché la letteratura sia una forma di lavoro teologico.
La prima esigenza è che la scrittura sia veramente «mediatrice» del pensiero. Se scrivere fosse soltanto il mettere per iscritto pensieri previ alla scrittura stessa, in questo caso la scrittura non sarebbe veramente «mediatrice»: sarebbe soltanto una forma di trascrizione. La scrittura letteraria è una ben diversa apertura e possiede un valore più stringente: «Viene alla penna ciò che non sarebbe mai venuto all’idea»[21]. Ciò significa che lo scrittore pensa solamente se scrive, cioè, potremmo dire, pensa in scrittura. Paradossalmente, dunque, si potrebbe dire che il vero scrittore non pensa se non scrive. Raramente, infatti, un romanzo di valore nasce come la trascrizione in parole di un testo tutto pensato in precedenza. Si può avere un’idea generale di ciò che si intende fare, ma l’opera si sviluppa all’interno del lavoro di scrittura.
La seconda condizione è quella del rigore. Non si tratta di «prolungare i tentativi di teologia “poetica” presenti in ogni epoca e caratterizzati dal vago e dall’arbitrario. Si tratta invece di trovare nella scrittura un nuovo rigore che permetta alla teologia di continuare il suo lavoro specifico in un’età che non sembra essere caratterizzata né dall’astrazione né dalla sistematicità»[22]. Non è dunque solamente una questione di stile, ma di cambiare lo stesso modo di pensare. Scrivere può rappresentare un dono, un «mistero», ma è anche un «mestiere»: non si mette a scrivere letterariamente soltanto chi decide di farlo. C’è una purezza e una proprietà di linguaggio che si deve acquisire; c’è l’uso delle risorse del vocabolario che non è scontato; c’è l’ascesi dell’espressione che sacrifica parte di ciò che si scrive in vista dell’essenzialità; c’è la capacità di non fermarsi nei momenti in cui si è alla ricerca di espressione.
La terza esigenza è di raccogliere le intuizioni e le esperienze che si vogliono «tradurre»[23], cercando espressioni belle, forti, precise, che abbiano capacità evocativa e spingano il lettore non semplicemente a «capire», ma a fare esperienza. La precisione del dettaglio, eliminando ogni approssimazione, rende reali le emozioni, evitando la rarefazione di una situazione astratta o sentimentalista. Maupassant affermava, del resto, che non c’è ferro che possa trafiggere il cuore con più forza di un punto messo al punto giusto. L’attenzione di Jossua, sebbene espressa sinteticamente, fa venire in mente un’efficace confessione di poetica che lo scrittore Raymond Carver espresse dopo aver letto la frase di Maupassant: «Era proprio quello che volevo fare con i miei racconti: mettere in fila le parole giuste, le immagini precise, ma anche la punteggiatura più efficace e corretta, in modo che il lettore venisse trascinato dentro e coinvolto nella storia, e non potesse distogliere lo sguardo dal testo a meno che non gli andasse a fuoco la casa»[24].
La quarta esigenza espressa da Jossua è infine l’indispensabile chiara distinzione dei generi letterari, che deve spingere a praticare quello del quale si è più capaci. Infatti, una cosa è la scrittura saggistica e la sua apertura di pensiero; altra quella autobiografica, che mette in gioco chi scrive personalmente; altra la scrittura narrativa, che amplia gli spazi della creazione immaginativa; altra la poesia, che presuppone una grande libertà nel far sgorgare le parole dalla fonte del linguaggio[25]. Sembra evidente, dai suoi scritti, che la preferenza di Jossua vada verso la poesia, dono raro che custodisce una sovrabbondanza di senso, il quale deve però essere custodito da una eccessiva e forzata enigmaticità.
Qual è, dunque, la funzione di una «teologia letteraria»? Il rischio sempre in agguato è quello di vedere nell’opera letteraria soltanto una felice illustrazione di ciò che potrebbe essere detto più brevemente e con più precisione e restare fissato nell’ordine del concetto[26]. Qui si tratta di cercare il potere proprio della letteratura nel dire, attraverso il simbolo, il racconto, ciò che nessun altro tipo di costruzione speculativa potrebbe giungere a esprimere[27].
Una grammatica teologica e il linguaggio del limite
Jossua richiama l’attenzione sul fatto che alcuni temi della letteratura contemporanea si presentano come residui del preesistente mondo religioso. Tuttavia «non è lecito tentare operazioni di recupero apologetico, come se dal frammento dell’eco si potesse ricostruire la parola originaria. Il frammento resta frammento e la parola che lo ha generato non è più conosciuta. Così l’attesa di Godot, nel noto dramma di Beckett, non rappresenta l’attesa di Dio: è l’attesa in sé, l’attesa per l’attesa, essenziale dimensione della vita, svuotata, però, di ogni riferimento religioso, eco di un suono perduto, il cui senso ultimo nessuno conosce e che, a dire il vero, potrebbe anche non essere mai esistito né come suono né come senso»[28].
Ciò, d’altra parte, implica lo studio del movimento di auto-trascendenza, non necessariamente connotato cristianamente: l’amore, l’arte, la scienza, il saper-vivere e la saggezza del quotidiano non si danno senza questo trascendersi[29]. A questo punto egli può proseguire nel suo lavoro mettendo in luce affinità e distanze tra le opere e una teologia cristiana, compiendo un décryptage, reso possibile da una competenza teologica e storica, dei miti o dei riferimenti culturali cristiani che rimangono in molte opere della nostra epoca. Vengono enucleate tre possibili alternative nell’interpretazione letteraria della trascendenza, «l’alternativa tra accettazione e rifiuto della realtà (sogno o epifania), l’alternativa tra avventura verso l’ignoto estraneo e avventura verso l’ignoto interiore, l’alternativa tra l’incontro col nulla e l’incontro con la pienezza»[30].
Occorre superare l’atteggiamento apologetico, evitando non solo di annettersi gli artisti, ma anche di collocarli e giudicarli secondo il loro rapporto con la fede e la Chiesa con espressioni come «vicini» o «lontani» in questo o in quell’aspetto. Soltanto in un ascolto attento della loro opera e con un’interrogazione sulla possibilità di creare un linguaggio per l’esperienza credente si può tentare di discernere affinità e differenze. Infatti «l’atteggiamento spirituale è spesso ben più decisivo dei contenuti in cui si crede»[31]. Si tratta di leggere, ascoltare, comprendere, analizzare i mezzi messi in opera in vista della creazione di un mondo o della comunicazione di una visione[32].
La teologia, a confronto con la letteratura e l’espressione poetica, ha trovato congeniale la pienezza del linguaggio, suggerendo poi però la necessità di forme apofatiche, di espressioni negative e di inviti al silenzio, tutte correzioni dovute all’indicibilità di Dio. Jossua sembra suggerire una strada differente, che egli chiama «liminare», concentrata proprio sulla capacità evocativa delle immagini, delle metafore e del linguaggio poetico, capaci di indicare insieme la prossimità e l’inaccessibilità dell’assoluto: la metafora, ad esempio, scrive Jossua, muove dalla pienezza del linguaggio e lancia le sue belle parole all’assalto dell’ineffabile. Così procede all’individuazione di alcune figure tipiche del linguaggio del limite o liminare: la porta chiusa, la città interdetta, la frontiera, il deserto, la vertigine del vuoto, l’indeterminatezza dell’attesa. Ciò a cui egli è attento sono le implicazioni teologiche della poetica stessa dello scrittore, che consiste nel suo lessico, nella sua retorica, nelle sue peculiarità espressive, stilistiche e grammaticali.
Nella prospettiva di una teologia letteraria, dunque, Jossua resta particolarmente colpito dall’orientamento che si richiama a un desiderio, a un’esperienza o a un movimento di trascendenza: quel «trascendere» che si ritrova in molte opere e che si riconosce sotto forme molto differenti, quali la frontiera (spaziale) e l’attesa (temporale), in un certo numero di poeti e romanzieri contemporanei. Si tratta di autori come M. de Unamuno e P. Handke, ma anche D. Buzzati, S. Beckett, M. Blanchot, F. Kafka, A. Gide, H. James e molti altri. Questi saggi critici si trasformano spesso in vere e proprie scommesse. Alcuni dei suoi autori, pur essendo non cristiani, hanno una particolare predilezione per il tema religioso della trascendenza, espresso mediante il ricco vocabolario del limite e del trascendere. Del resto, lo stesso credente, scrive Jossua, «deve essere visto come un uomo, una donna, fermo davanti a una soglia — porta, finestra, muretto, siepe, parapetto — o su una frontiera — un limite, un colle, un confine, il margine d’un deserto o la riva del mare —; come uno che veglia, che attende, in un agguato senza fine»[33].
Le immagini «liminari», avverte il teologo domenicano, sono ben familiari ai profeti della Bibbia e ai salmisti. Nella passione per i Profeti (ma non solo) si avverte una convergenza tra Jossua e il grande critico Giacomo Debenedetti. Le immagini dei profeti sono più prudenti delle metafore e più positive degli ossimori, «non fanno altro che evocare la direzione cui tendono, e contengono dunque in se stesse il gioco intero del sapere e dell’ignoranza, senza richiedere alcuna correzione negativa. Il soggetto che esse descrivono attende, vigila, osserva; è collocato su una soglia, su una frontiera, su dei confini, su una riva, su un molo. E quando ciò che partecipa della trascendenza è intravisto, la sua bellezza folgorante è di natura talmente particolare che può apparire in altri momenti come appannato, banale»[34]. Così il castello di Kafka, il forte di Buzzati…
Ecco ciò che, sopra ogni cosa, interessa e colpisce Jossua: le parole dell’ignoto, le figure dell’infinito, la grammatica della trascendenza. Siamo dunque al di là di una teologia puramente negativa: nella «poetica liminare» il simbolo e la metafora del limite attestano l’irraggiungibilità dell’infinito attraverso la manifestazione della finitezza del reale[35]. Si tratta però di concetti che andrebbero meglio chiarificati per verificarne la capacità di veicolare il contenuto della Rivelazione.
Verso una teologia letteraria
Jossua, percorrendo con passione inesausta le pagine della letteratura, intende consegnare alla teologia una poetica e una grammatica della trascendenza. Essa costituisce un invito a rinnovare il metodo teologico, e a non rifiutare per principio la strada della creatività letteraria, già percorsa dagli scrittori biblici e da alcuni Padri della Chiesa. Ritornano dunque imperiose le domande forse dimenticate e, per certi aspetti, provocatorie, formulate dal grande teologo Karl Rahner: «Forse la teologia viva di domani sarà meno “scientifica” (cioè non penserà di essere se stessa — l’arte per l’arte — solo quando tratta argomenti, dal punto di vista storico o speculativo, i quali interessano solo gli specialisti di teologia), e la letteratura religiosa sarà molto teologica (cioè si porranno di nuovo onestamente e radicalmente le questioni ultime). Sarebbe un male se il libro teologico e quello religioso non fossero quasi più distinguibili? […]. Ma nel campo teologico forse la distanza dovrebbe diminuire e questa riduzione potrebbe assolutamente essere presa come criterio per la purezza sia dell’aspetto scientifico sia di quello religioso: nella misura che l’espressione non tocca l’intimo centro dell’esistenza essa è anche, valutata teologicamente, non scientifica (tutto questo cum grano salis)»[36].
E sempre K. Rahner ha lamentato: «Ahimè, non dovremmo domandarci una buona volta: dove sono mai i bei tempi nei quali i grandi teologi erano anche poeti e componevano inni? Quando potevano scrivere come un Ignazio di Antiochia o poetare come Metodio d’Olimpo o aprire il loro animo in inni come Adamo di San Vittore, Bonaventura e Tommaso D’Aquino? Dove sono finiti quei tempi? E la teologia è forse divenuta più sublime, perché oggi i teologi scrivono in prosa?»[37]. Se von Balthasar diceva che alla teologia moderna manca il saper stare in ginocchio, K. Rahner aggiunge che «manca la teologia capace di fare poesia»[38].
Jossua, da parte sua, rimane persuaso che lo sforzo della teologia letteraria possa giovare molto non solo a lettori credenti che cercano di riflettere sulla loro fede senza entrare in un lavoro tecnico, ma anche alla mutua comprensione tra persone aventi convinzioni differenti, e al compito propriamente teologico in una cultura profondamente rinnovata. Dobbiamo dunque essere grati a chi in Italia si sta prodigando per far conoscere gli scritti del teologo francese. In particolare le edizioni Diabasis di Reggio Emilia, che hanno appena tradotto la vivace raccolta di saggi La letteratura e l’inquietudine dell’assoluto, preceduta di poco nella pubblicazione, da parte dell’editrice Argo di Ragusa, del volume La passione dell’Infinito nella letteratura.
Tra scrivere e vivere c’è un rapporto stretto, per il fatto che la scrittura risveglia un’attenzione che accresce l’intensità del vivere. Proprio per questo allora la letteratura (per lo scrittore e per il lettore) può diventare un luogo estremamente significativo del proprio rapporto con Dio[39].
***
[1] J.-P. Jossua, Pour une histoire religieuse de l’expérience littéraire, vol. III, Paris, Beauchesne, 1994, 7.
[2] L’opera principale di Jossua è Pour une histoire religieuse de l’expérience littéraire, 4 voll., Paris, Beauchesne, 1985-2000. Il nostro testo è una parziale rielaborazione dell’introduzione all’edizione italiana di La littérature et l’inquiétude de l’absolu, ivi, 2000, che è una sintesi efficace e accessibile delle ricerche pubblicate in quei quattro volumi. Il volume italiano ha per titolo La letteratura e l’inquietudine dell’assoluto ed è stato pubblicato nel 2005 a Reggio Emilia da Diabasis. A questo editore va il merito di aver contribuito a far conoscere nel nostro Paese un autore per troppo tempo trascurato.
[3] Id., Pour une histoire…, cit., 8 s.
[4] Ivi, vol. I, 9.
[5] Cfr anche Id., «L’apport de la littérature à la réflexion chrétienne», in J. Doré, Sur l’identité chrétienne, Paris, Desclée, 1990, 77 s.
[6] J.-P. Jossua, Pour une histoire…, vol. I, cit., 9.
[7] Cfr Ch. Moeller, Letteratura moderna e cristianesimo, 5 voll., Milano, Vita e Pensiero, 1967-77. È stato parzialmente riedito da Rizzoli nel 1995 in unico volume.
[8] Ivi, 17.
[9] Cfr J.-P. Jossua, Pour une histoire…, vol. I, cit., 17.
[10] Ivi, 18.
[11] Cfr Id., «Esperienza cristiana e comunicazione della fede», in Concilium 9 (1973) n. 5, 99-113.
[12] Cfr ivi, 100.
[13] Ivi, 101.
[14] Ivi, 102 s.
[15] Ivi, 105.
[16] Cfr ivi, 108 s.
[17] Ivi, 112.
[18] Cfr P. Jacquemont – J.-P. Jossua – B. Quelquejeu, Esperienza di fede, Assisi (PG), Cittadella, 1974.
[19] Cfr J.-P. Jossua, Lecture en écho. Journal théologique, vol. I, Paris, Cerf, 1976.
[20] Cfr Id., L’écoute et l’attente. Journal théologique, vol. II, ivi, 1978.
[21] Id., Pour une histoire…, vol. III, cit., 11.
[22] J.-P. Jossua – J. B. Metz, «Teologia e letteratura. Con una lettera di Marie-Dominique Chenu», in Concilium 12 (1976) n. 5, 16.
[23] J.-P. Jossua, Pour une histoire…, vol. III, cit., 12.
[24] R. Carver, «Prefazione dell’autore», in Id., Da dove sto chiamando, Roma, Minimum fax, 1999, 10.
[25] Ogni forma espressiva ha anche i propri limiti e, infatti, in ordine: la scrittura saggistica non deve far «esporre» troppo biograficamente l’autore; quella autobiografica deve stare attenta a non cadere nell’aneddoto e nel pathos, da una parte, e a limitare l’immaginazione, perché non sconfini in libera creazione di personaggi e situazioni, dall’altra; quella narrativa, in genere, non ha la stessa libertà sorgiva della poesia.
[26] Cfr J.-P. Jossua, «L’apport de la littérature…», cit., 79.
[27] Cfr ivi.
[28] A. Bodrato, «Della ragion simbolica: Jean-Pierre Jossua, itinerario di un teologo», in Humanitas 41 (1986) 593.
[29] Cfr J.-P. Jossua, «L’apport de la littérature…», cit., 81.
[30] A. Bodrato, «Dalla ragion dialettica…», cit., 594.
[31] J.-P. Jossua, Pour une histoire…, vol. II, cit., 14.
[32] Cfr Id., «L’apport de la littérature…», cit., 81.
[33] Id., La condition du témoin, Paris, Cerf, 1984, 34.
[34] J. -P. Jossua, La letteratura e l’inquietudine…, cit., 67.
[35] Cfr A. Bodrato, «Dalla ragion dialettica…», cit., 593.
[36] K. Rahner, «Il futuro del libro religioso», in Id., Nuovi saggi, vol. II, Roma, Ed. Paoline, 1968, 650.
[37] Id., «Sacerdote e poeta», in Id., La Fede in mezzo al mondo, Alba (CN), Ed. Paoline, 1963, 170 s.
[38] Id., «L’arte nell’orizzonte della teologia e della pietà», in Id., Società umana e Chiesa di domani. Nuovi saggi, vol. X, Cinisello Balsamo (MI), Ed. Paoline, 1986, 482.
[39] Cfr J.-P. Jossua, Pour une histoire…, vol. III, cit., 13.







