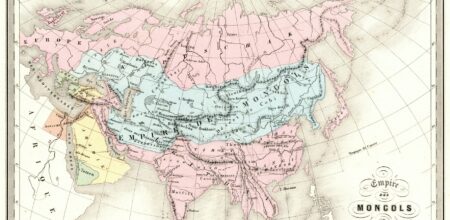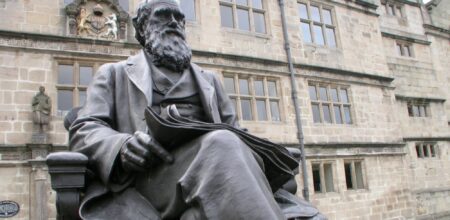|
|
Dopo aver portato a termine la «non piccola fatica» di dare forma unitaria, con questo volume, a una serie di saggi pubblicati negli ultimi vent’anni, nell’Introduzione Carlo Galli ne anticipa le tesi portanti e la struttura fondamentale. In un’ulteriore sintesi, si può notare come l’autore si soffermi su due grandi temi, che sono poi quelli indicati nel titolo e nel sottotitolo del libro. Il primo è eminentemente filosofico e, anzi, inerisce all’essenza stessa della filosofia. Questa, per l’autore, consiste nell’«esercizio della critica», ma con la decisiva precisazione che la critica deve scontare un’«opacità originaria», così che nasce l’«esigenza di chiarire quali siano le forme della critica, quale sia la loro struttura e la loro finalità» (p. 7). L’approfondimento di questa tesi conduce Galli – questo è il secondo tema – a riscontrare un’analoga «opacità» nella struttura della politica e del pensiero che la indaga, la quale orienta a pensare la politica nella prospettiva di un «realismo critico» consistente nel mostrare le relazioni, gli eventi e i processi che costituiscono la trama effettiva del reale.
Un tale «esercizio genealogico» non intende essere un’«adesione all’immanenza», né, ancor meno, un «abbandono all’effimero». Il suo scopo, invece, è quello di «fare emergere sia la mediazione di tutte le presunte immediatezze» – e in questo l’autore si differenzia da una tesi tipica del Post-moderno –, sia «l’immediatezza della mediazione stessa», prendendo egli questa volta le distanze da una tesi tipica del Moderno. Più precisamente, rispetto al disegno moderno, il realismo critico rivela «l’origine particolare dei discorsi ordinativi e legittimanti», insomma mostra come invalida la tesi che al fondo delle cose vi sia la «ragione» come loro fondamento (cfr p. 8). In tal modo l’autore ci conduce nel territorio, per noi oggi abituale, del «pensiero negativo», il quale però non dev’essere confuso con l’irrazionalismo, dal momento che non si contrappone alla ragione, ma ne mostra le «contraddizioni originarie» (p. 130).
Questo nucleo teoretico costituisce l’assunto fondamentale del volume ed è approfondito nel primo capitolo, quello che dà il titolo al volume, e nell’ultimo, intitolato significativamente «Opere del Nulla», come a ribadire l’assenza del fondamento. Il lettore che volesse approfondire ulteriormente, potrebbe leggere la prima parte di un’opera precedente dell’autore, intitolata Genealogia della politica. Carl Schmitt e la crisi del pensiero politico (il Mulino, 1996). Nelle pagine 3-175 di tale volume, infatti, Galli affrontava tematicamente il problema della mediazione, ossia il tema di un fondamento o meno dell’esperienza (o della «vita»), svolgendolo storicamente nella sua intera parabola moderna di mediazione razionalista (Cartesio e Hobbes), mediazione dialettica (Hegel e Marx), crisi della mediazione (Kierkegaard e Weber) e, infine, di dissoluzione della mediazione (Nietzsche, in primis).
Qui non è possibile offrire un’analisi di tutti i temi svolti nei sette capitoli di Forma della critica. Preferiamo, perciò, soffermarci sull’importanza che l’autore attribuisce alla critica operata dalla «teologia politica» in relazione alla tesi di un’assoluta autonomia e autotrasparenza della ragione moderna: «L’interpretazione teologico-politica fa della contingenza moderna un campo generato da un’origine non razionalizzabile», con il risultato che si può contestare la pulsione della modernità «a concludersi nell’immanenza compiuta» (p. 61).
Gli autori coinvolti da Galli per giustificare la tesi del ruolo attivo svolto dalla religione come un primum rispetto alla politica e il rilievo del «nodo irrisolto» inerente a tale legame ripresentano le linee di pensiero prima elencate in ordine alla parabola del Moderno. A partire dal pensiero negativo di Nietzsche si originano le successive riflessioni – sempre nella prospettiva di una «teologia politica» – svolte da Schmitt, Benjamin e, più recentemente, da Tronti e Cacciari. Tra l’altro, un capitolo (cfr pp. 119-145) è dedicato dall’autore a un fitto confronto, molto ben articolato, tra Nietzsche e Schmitt, dal quale emergono punti di contatto ed elementi di differenza tra due autori accomunati dalla critica alla «mediazione moderna».
Concludiamo la breve analisi di questo libro con un’ultima citazione, che riassume il senso di fondo del «realismo critico» che in esso viene teorizzato: «La critica si impone […] per orientare il modo di pensare i problemi, e per scovarli dove si pretende esista la “normalità”» (p. 53).
CARLO GALLI
Forme della critica. Saggi di filosofia politica
Bologna, il Mulino, 2020, 288, € 25,00.