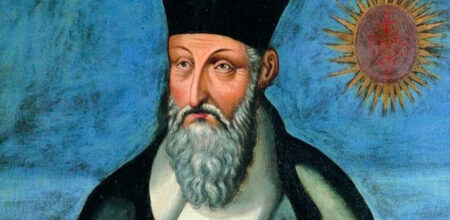|
|
Mistica davvero? La santa più celebre nel XX secolo, senza dubbio. Ma mistica? Tra le rappresentazioni tradizionali dell’esperienza mistica c’è innanzitutto ciò che più colpisce i comuni mortali: lo straordinario, lo spettacolare, il «soprannaturale». Il soprannaturale si manifesta attraverso l’estasi, il rapimento, la levitazione, le stimmate. A questo linguaggio del corpo fa eco il linguaggio articolato, a volte oscuro, che proviene anch’esso da un altro mondo: il linguaggio della profezia, dell’oracolo, della glossolalia. Per non parlare, ovviamente, dei «miracoli»: guarigioni, bilocazioni ecc.
In Teresa di Lisieux non si trova nulla di tutto questo. Nessun soprannaturale osservabile, ma quella che lei chiama la sua «piccola via», la sua «piccola dottrina»: quella che le sue consorelle hanno chiamato «la via dell’infanzia», sebbene Teresa stessa non abbia mai usato questa espressione. La «piccola via», questa consacrazione del banale, del quotidiano, del semplice, di ciò che non va oltre le norme, insomma dell’insignificante, può essere considerata come il cammino di un’autentica forma di esperienza mistica, un’esperienza in sintonia con il nostro tempo.
Una santa di successo
Se c’è qualcosa di straordinario e di «miracoloso» nell’avventura di Teresa, lo si trova innanzitutto nel successo nelle librerie di Storia di un’anima. Un anno dopo la morte di Teresa, il libro viene stampato in 2.000 copie. È destinato principalmente agli altri Carmeli e agli amici del Carmelo. Dopo la morte di una monaca carmelitana, era in effetti consuetudine distribuire agli altri Carmeli e agli amici una «circolare», una sorta di necrologio, spesso contenente appunti e scritti della defunta. È con questo spirito che Teresa, tre mesi prima della sua morte, aveva redatto, su richiesta della priora, il suo ultimo scritto autobiografico, il Manoscritto «C». Teresa era pienamente consapevole che il racconto della sua vita sarebbe stato utilizzato per la redazione di questa specie di necrologio. Non c’è quindi alcun miracolo o profezia nelle parole che Teresa dice, nei suoi ultimi giorni, riguardo alla pubblicazione di ciò che sta scrivendo e agli effetti che esso potrebbe avere sulle anime. Quando afferma con molta calma che questa lettura «farà molto bene alle anime», Teresa pensa ovviamente ai carmelitani e alla rete dei loro amici e benefattori che avrebbero ricevuto il suo necrologio. E aggiunge, sul suo letto di agonia: «Ce ne sarà per tutti i gusti, fuorché per le vie straordinarie» (9 agosto 1897).
Chi poteva allora sospettare che questi scritti sarebbero andati oltre la ristretta cerchia degli amici del Carmelo, che avrebbero avuto una tale eco e che un intero secolo si sarebbe riconosciuto in essi? In pochi mesi, le 2.000 copie vengono esaurite. A fine anno, le vendite raggiungono le 4.000 copie. Venticinque anni dopo, quando si decide di pubblicare i Novissima Verba («Ultime parole»), che a loro volta hanno un enorme successo, Storia di un’anima ha venduto 200.000 copie, fatto straordinario per l’epoca. Due anni dopo la morte di Teresa, i pellegrini vengono già a pregare sulla sua tomba, la gente comincia a parlare di guarigioni miracolose e Storia di un’anima viene tradotta in inglese. Potenza della parola scritta! Il vero miracolo, se così si può dire, sta nella straordinaria velocità di diffusione della figura di Teresa. Durante la guerra del 1914-18 la sua foto appare nel portafoglio dei soldati di entrambi gli eserciti, francese e tedesco.
Come spiegare un tale successo, per un percorso di vita così breve e poco spettacolare come quello di Thérèse Martin, morta a 24 anni? A volte si è detto che era giunto il momento di reagire al giansenismo, che per troppo tempo aveva limitato la pietà cattolica. La «via della carità» (cfr 1 Cor 12–13) rispondeva alle aspettative inconsce della pietà popolare. L’affettività religiosa poteva essere investita in una figura femminile e infantile allo stesso tempo, vergine e bambina, corrispondente molto bene al sentimentalismo che caratterizza una certa estetica della Belle Époque, illustrata in particolare nella pittura e nella letteratura dal preraffaellismo e dal simbolismo che volgono al termine.
Probabilmente c’è del vero in questo tipo di spiegazione. Ma il successo di Teresa è sopravvissuto ampiamente alla sensibilità fin de siècle, alla reazione al giansenismo e allo spirito vittoriano che aveva avvelenato la borghesia. Cinquant’anni dopo la sua morte, e ancora oggi, sensibilità cristiane non particolarmente sdolcinate o decadenti continuano a trovare nei suoi scritti ragioni per vivere e per credere. Per esempio, la Missione di Francia, che ha subito posto la sua esistenza e la sua spiritualità sotto il segno di Teresa, a Lisieux nel 1941. Ebbene, la Missione non rappresenta certo una forma particolarmente mielosa di sensibilità cristiana. Teresa – già patrona delle missioni, insieme a san Francesco Saverio – è stata proclamata Dottore della Chiesa da Giovanni Paolo II nel 1997. Insomma, tutto il XX secolo sembra riconoscere in questo «fiorellino»[1] la linfa forte che può nutrirlo.
Troviamo la sua esperienza innanzitutto nei suoi scritti. Li leggiamo nel loro testo autentico solo da circa cinquant’anni[2]. La Storia di un’anima non rappresenta il testo originale, ma una raccolta e una sistemazione dei tre scritti di Teresa (Manoscritti «A», «B» e «C»). Se si sommano tutti i suoi scritti, il risultato è notevole, soprattutto per una persona scomparsa a 24 anni, che aveva lasciato la scuola a 13 e che non era né un’intellettuale né una grande lettrice, e a cui la vita nel Carmelo lasciava poco tempo per scrivere (circa un’ora al giorno). Di cosa ci parlano questi scritti? Soprattutto di un Dio che si cela nel quotidiano, nel banale, nell’insignificante, nel piccolo, a volte nell’irrisorio. Molte persone, quando hanno affrontato senza preparazione né commento ciò che Teresa aveva scritto, si videro cadere il libro dalle mani. Per cinquant’anni gli storici hanno dovuto lavorare sodo per far emergere da questi testi apparentemente melensi la straordinaria esperienza spirituale che in essi viene espressa, ma tra le righe. Per cinquant’anni Teresa è stata ammirata per ragioni che non sempre erano quelle giuste[3]. E i teologi non hanno preso sul serio Teresa fino a quando Urs von Balthasar non ha scritto su di lei nel 1950[4]. Ricordiamo ora i fatti principali della vita di Teresa.
Scegliere tutto
Due espressioni famose di Teresa possono servire da esergo per evocare la sua breve esistenza e la sua personalità. La prima è stata suscitata, nella sua prima infanzia, da una situazione che, lei afferma, è «il riassunto di tutta la sua vita». Un giorno, sua sorella Leonia le dice che vuole farle un regalo; le chiede di scegliere un oggetto tra i piccoli tesori contenuti in un cestino che le presenta. Teresa esclama: «Io scelgo tutto!» e prende il cestino. La Santa commenta: «Questo piccolo fatto della mia infanzia è il riassunto di tutta la mia vita: più avanti, quando mi è apparsa la perfezione, ho capito che per diventare una santa bisognava soffrire molto, cercare sempre il più perfetto e dimenticare sé stessi, ho capito che c’erano molti gradi nella perfezione e che ogni anima era libera di rispondere agli inviti di Nostro Signore, di fare poco o molto per Lui, in una parola di scegliere tra i sacrifici che Egli chiede. Allora come ai giorni della mia prima infanzia ho esclamato: “Mio Dio, scelgo tutto. Non voglio essere una santa a metà”»[5].
L’altra espressione di Teresa si trova nel passo non meno famoso in cui lei evoca la sua scoperta della via dell’Amore. Sente la vocazione di tutte le vocazioni: guerriero, sacerdote, apostolo, dottore, martire. Scopre allora che la sua vocazione contiene tutte le altre: «Sì, ho trovato il mio posto nella Chiesa e questo posto, o mio Dio, sei tu che me lo hai dato: nel Cuore della Chiesa, mia Madre, sarò l’Amore!… Così sarò tutto… così il mio sogno sarà realizzato!!!»[6]. «Scelgo tutto!». «Sarò tutto!». Per lo psicologo, ciò che qui viene espresso è più della classica megalomania infantile: è una formidabile voglia di vivere, un’affermazione di sé! L’esistenza di Teresa è stata un trionfo sul desiderio di morte.
Desideri di morte
Jean-François Six, nel suo libro sull’infanzia di Teresa, e Jacques Maître hanno mostrato chiaramente il peso spaventoso della morte nei desideri dei genitori di Teresa, in particolare di sua madre (una carica di morte inconscia, ovviamente). Va ricordato che Louis e Zélie Martin – che si sposarono relativamente tardi e che si consideravano entrambi un caso di vocazione religiosa incompiuta – iniziano col trascorrere i primi sei mesi di vita coniugale in assoluta continenza (per volontà dell’uno e per ingenuità dell’altra, a quanto sembra). Su consiglio di un confessore, pongono fine a questo stato di cose, perché in 13 anni Zélie dà alla luce nove figli, di cui solo cinque sopravvivono. Teresa è l’ultima. Porta il nome di un’altra piccola Teresa, nata e morta tre anni prima di lei. Anche altri tre bambini – due maschi e una femmina – muoiono in tenera età. Quattro «piccoli angeli» la attendono in cielo. Questa attesa segna profondamente la sua infanzia. In famiglia, si sente molto presto nostalgia del cielo.
Quando nasce Teresa (1873), suo padre ha 50 anni, sua madre 41. Zélie è stremata dalle maternità e soprattutto dalla sua attività lavorativa: dirige una squadra di merlettaie. Si tratta di un’attività totalizzante e redditizia: in pochi anni – secondo i calcoli dei biografi –, grazie a Zélie, il marito diventa un agiato possidente; ma lei si è letteralmente ammazzata di lavoro: muore di cancro a 45 anni. Attorno alla culla della piccola Teresa si affollano quattro sorelle, che diventeranno tutte suore:
- Maria (del Sacro Cuore): 13 anni. È la seconda a entrare nel Carmelo, quando Teresa ha 13 anni;
- Paolina (Madre Agnese): 12 anni. Viene scelta da Teresa come figura materna. Paolina è la prima a entrare nel Carmelo, quando Teresa ha nove anni. Questo evento segna l’inizio della vocazione di Teresa;
- Leonia, 10 anni. È l’ultima a diventare religiosa, ma non carmelitana, bensì suora della Visitazione, due anni dopo la morte di Teresa, dopo un’infanzia difficile e molte esitazioni sul suo orientamento;
- Celina (suor Genoveffa), 4 anni. Entra al Carmelo dopo Teresa, che sarà la sua maestra delle novizie.
Se ci sono state tante morti prima di Teresa, è perché il grembo di sua madre distillava la morte. La maggior parte dei suoi bambini soffriva di enterite, una grave infiammazione intestinale. Teresa ne è quasi morta. È una sopravvissuta. Quando l’ha concepita, sua madre sapeva già di avere da diversi anni un tumore al seno di cui presto sarebbe morta. L’infanzia di Teresa è una serie di vittorie sulla morte. Tre soprattutto, come vedremo. Prima di ogni altra cosa, Teresa è un formidabile desiderio di vita.
Desiderio di vita
Come Teresa è sfuggita alla morte? La prima volta, rifiutando il seno avvelenato della madre. A 15 giorni di vita, lei presenta i sintomi dell’enterite. A un mese, sta «molto male». A 40 giorni, rifiuta il seno e rischia di morire di fame. Sua madre, lei stessa esausta e folle di dolore, ricorre all’aiuto di una nutrice, Rose Taillé, che trascina a casa quasi con la forza. Teresa si getta sul seno di Rose, si nutre avidamente. È salva. Vive con Rose fino a 15 mesi. È una bambina fantastica. Questa quasi-risurrezione è la seconda nascita di Teresa. Ne sperimenterà altre due: altre due vittorie sulla morte, sul cammino della vera vita.
Teresa, infatti, non è fuori pericolo. Questa bambina, già indebolita psicologicamente, ma i cui primi anni di infanzia mostrano una vitalità fisica e morale sorprendente, a quattro anni perde la madre a causa di un cancro. Una prova terribile! Ma è più tardi che, per ben due volte, compaiono inquietanti somatizzazioni e sorprendenti guarigioni. La seconda crisi si scatena – come per caso! – quando Paolina entra nel Carmelo nell’autunno del 1882: Teresa ha nove anni. Durante l’inverno soffre di mal di testa, insonnia, eruzioni cutanee. Poi una malattia nervosa: convulsioni, delirio. Il medico è molto pessimista. Nella Pentecoste del 1883, Teresa viene guarita dalla statua della «Vergine del Sorriso», posta sopra il suo letto. Guarigione spettacolare, ma passiva; si potrebbe definire una vittoria passiva. La terza crisi invece è diversa, interamente psicologica e spirituale.
Questa crisi è più lunga e progressiva. Tutto comincia con una crisi di scrupoli, nel maggio 1885, provocata dal ritiro preparatorio alla rinnovazione della Comunione predicato da don Domin nella scuola dove Teresa è allieva da tre anni. La predicazione poteva essere definita «terroristica»: «Il peccato è ovunque!». Teresa ha 12 anni. È preda di scrupoli tormentosi che ruotano intorno a questa domanda: «La mia malattia nervosa dell’inverno 1882 era reale? Non ho finto di essere malata? La Vergine mi ha davvero guarita?». La crisi comincia nell’inverno 1885-86 con mal di testa insopportabili. Teresa deve lasciare la scuola, dove non tornerà mai più. Nell’estate del 1886 subisce un altro shock, quando viene a sapere della partenza di Maria, che per lei è stata la sua seconda figura materna.
Nel mese di ottobre, grazie alle suppliche ai suoi «piccoli angeli», viene liberata dai suoi scrupoli. È un primo passo. «Ero veramente insopportabile – racconta – per la mia sensibilità eccessiva». Per un sì o per un no, la «reginetta» piangeva, poi, «piangeva per aver pianto»[7]. Nel Natale del 1886 avviene il «miracolo». Il Buon Dio la fece «crescere in un momento […]. Egli mi rese forte e coraggiosa, mi rivestì della sua armatura […]. La sorgente delle mie lacrime fu prosciugata […]. Fu il 25 dicembre 1886 che ricevetti la grazia di uscire dall’infanzia, in una parola la grazia della mia completa conversione»[8]. Come è accaduto questo?
Al ritorno dalla Messa di mezzanotte. È il momento del rito delle scarpe nel camino (le calze di Natale). Teresa sente il suo vecchio padre dire (credendo che lei non lo senta): «Bene, meno male che è l’ultimo anno!…» (ha 13 anni). Lei non crolla. «Reprimendo le lacrime, scesi rapidamente la scala e, comprimendo i battiti del cuore, presi le mie scarpe […]. La piccola Teresa aveva ritrovato la forza d’animo che aveva perduto a 4 anni e mezzo, e l’avrebbe conservata per sempre!…»[9]. Teresa insiste sul carattere definitivo della sua conversione: «In quella notte di luce cominciò il terzo periodo della mia vita, il più bello di tutti»[10]. Lo stesso giorno, poche ore dopo, Paul Claudel, vicino al secondo pilastro rispetto all’ingresso del coro della cattedrale di Notre Dame di Parigi, ascoltando il Magnificat dei Vespri di Natale cantato dai bambini, riceve la fede in Dio: la fede in quella che egli chiama «l’eterna infanzia di Dio». Teresa esce dall’infanzia. O meglio, esce dall’infantilismo per entrare nella vera infanzia spirituale.
Il resto è noto. Innanzitutto, l’ingresso nel Carmelo dopo il celebre viaggio a Roma. Quando prende l’abito, suo padre viene internato per demenza. Teresa fa la professione di fede all’età di 17 anni. Nel 1895 scrive il Manoscritto «A»: la sua infanzia, la sua giovinezza, il suo ingresso nel Carmelo. Nella Pasqua del 1896, all’età di 23 anni, subisce la sua prima emottisi. Entra nella notte spirituale da cui non uscirà più, quella che chiamerà la sua «prova di fede e di speranza». A settembre, durante il suo ritiro, scrive il Manoscritto «B» (la sua dottrina, la sua «piccola via»: quella dell’amore) per la sorella Maria. Nell’aprile 1897 inizia la sua vita da malata. Paolina comincia a prendere nota delle sue parole. A giugno, è in infermeria, dove scrive a matita il Manoscritto «C», due pagine al giorno[11]. Infine, il 30 settembre 1897, muore soffocata dopo atroci sofferenze.
Desideri di santità
«Ho sempre desiderato d’essere una santa»[12]. In Teresa, sorprendentemente, il desiderio di vita prende molto presto la forma del desiderio di santità, e della santità nella sua versione più «militante»: quella di Giovanna d’Arco. Ma Giovanna non era ancora stata canonizzata. Da quando lo storico Michelet l’aveva fatta uscire dal purgatorio, era diventata una figura di notevole importanza per l’epoca, in un contesto di secolarizzazione, tra i cattolici e i non cattolici. Teresa stessa racconta la nascita di questo desiderio nelle sue prime letture, da bambina: «Leggendo i racconti delle gesta patriottiche delle eroine francesi, in particolare quelle della Venerabile GIOVANNA D’ARCO, avevo un gran desiderio di imitarle. Mi sembrava di sentire in me lo stesso ardore da cui erano animate […]. Pensai che ero nata per la gloria»[13]. Dice al padre nel 1888: «Cercherò di essere la tua gloria diventando una grande santa»[14]. L’anno seguente, in un biglietto a una carmelitana, scrive: «Chieda a Gesù che io diventi una grande santa»[15]. Potremmo moltiplicare le citazioni[16]. Sempre: «una grande santa». Veemenza e persistenza del desiderio, affermato tranquillamente e in modo chiaro.
Non è irrilevante che la figura di santa che le si impone costantemente sia la figura di Giovanna d’Arco: donna-bambina e valorosa soldatessa. Teresa è affascinata da Giovanna. Le dedica due scritti teatrali in cui interpreta il ruolo di Giovanna. C’è in lei una vena guerriera e cavalleresca. Ricordiamo il celebre passo in cui, riflettendo sulla sua vocazione ed evocando i suoi «grandi desideri», scrive: «Mi sento la vocazione di Guerriero, di Sacerdote, di Apostolo, di Dottore, di Martire; insomma, sento il bisogno, il desiderio di compiere per te, Gesù, tutte le opere più eroiche… Sento nella mia anima il coraggio di un Crociato, di uno Zuavo Pontificio: vorrei morire su un campo di battaglia per la difesa della Chiesa…»[17].
Questo deve essere preso alla lettera. La bambina viziata e capricciosa, il seme di una neuropatica, trova nelle sue convinzioni religiose l’energia indomabile e serena che le permette di diventare una vera adulta, di affrontare in modo insolito le prove della vita monastica (prove poco spettacolari, ma faticose). Ecco il ritratto tracciato da una delle sue consorelle, in una lettera a una carmelitana di un altro monastero (Teresa allora aveva 20 anni): «Suor Teresa del Bambin Gesù. Novizia e gioiello del Carmelo, la sua beniamina […]. Alta e forte con un’aria infantile, un suono di voce, e anche un’espressione, nascondendo in questo una saggezza, una perfezione, una perspicacia che si addicono ai 50 anni. Anima sempre calma e sempre perfettamente padrona di sé, in tutto e con tutti. Una santarellina a cui si darebbe il Buon Dio senza confessione, ma birichina tanto da farne quante ne vuole. Mistica, comica, tutto le si addice. […] Saprà farvi piangere di devozione e altrettanto facilmente vi farà ridere a crepapelle durante le nostre ricreazioni»[18]. In questo bellissimo ritratto di suora ciò che colpisce è il perfetto autocontrollo. Ancora più spettacolare è l’energia che permette a Teresa di affrontare, oltre alla vita comunitaria poco indulgente, la sofferenza fisica e la morte per soffocamento senza morfina.
Podcast | SIRIA. «LA SITUAZIONE ECONOMICA È CATASTROFICA»
Le incognite sul futuro di milioni di rifugiati, le città devastate da anni di guerra e una pace ancora fragile. A raccontarci da Damasco come sta vivendo questo momento di incertezza la popolazione siriana è p. Vincent de Beaucoudrey S.I., direttore del Jesuit Refugee Service in Siria.
È lei stessa a descrivere il suo coraggio negli ultimi giorni di vita. Bisogna apprezzarne la modestia e l’umorismo: «Mi hanno tanto ripetuto che ho coraggio, ed è così poco vero, che mi sono detta: Ma, insomma, non bisogna far mentire la gente! E mi sono messa, con l’aiuto della grazia, ad acquistare questo coraggio. Ho fatto come un guerriero che, sentendosi lodare per la sua prodezza, pur sapendo benissimo di non essere che un vile, finirebbe col vergognarsi dei complimenti e vorrebbe meritarseli»[19]. Questa forza della vita di fronte alle pulsioni di morte è al centro di quella che Teresa chiamava la sua «piccola dottrina», la sua «piccola via».
La «piccola dottrina»
È ormai chiaro che la «piccola dottrina» di Teresa, la sua «piccola via» non è il prolungamento e la consacrazione di un’esperienza infantile. Al contrario, passa attraverso una rottura con l’infanzia, con i sogni di gloria, di eroismo, di santità eroica che erano quelli dell’infanzia. Questi sogni di eroismo e di santità sono stati riconosciuti da Teresa come un modo per cercare di sfuggire all’angoscia della morte, della finitezza. L’angoscia della morte e della finitezza, e l’«umiliazione» che essa comporta, sono affrontate, accettate, sopportate con Gesù, che ha attraversato l’angoscia della morte e della finitezza. La «piccola via» è l’abbandono al Padre, la fiducia in lui. La rinuncia alla fiducia in sé stessi. La rinuncia a considerarsi come origine. Accettare di ricevere sé stessi.
La «piccola via» inizia il giorno in cui l’anima può riconoscere, come Teresa, con semplicità e giubilo: «Non ho opere». Vale a dire: Non ho opere da portare davanti a Dio, non ho opere di cui vantarmi, sto davanti a Dio a mani vuote, come un bambino. Questa è l’esperienza fondamentale, nella sua formulazione «teologica»: «Non ho opere». Troviamo questa formulazione esattamente all’inizio e alla fine degli scritti di Teresa.
All’inizio, fin dalla prima pagina del Manoscritto «A», Teresa si interroga «sul mistero della sua vocazione, di tutta intera la sua vita, e soprattutto sul mistero dei privilegi di Gesù per la sua anima…»[20]: non si potrebbe essere più concisi, più riepilogativi. Teresa come esprime questo mistero? Prende in prestito la sua formula da san Paolo, in Rm 9,15-16, che nella traduzione a sua disposizione risulta così: «Dio usa misericordia con chi vuole, e ha pietà con chi vuole averla. Quindi non è opera della volontà né degli sforzi dell’uomo, ma di Dio che ha misericordia»[21]. Niente di ciò che sono è opera mia, ma di Dio. All’altro capo degli scritti di Teresa si trova la stessa affermazione teologica: «Non ho opere». «Sono molto contenta di andarmene presto in Cielo, ma quando penso a questa parola del Buon Dio: “Ecco, porterò con me il mio salario, per rendere a ciascuno secondo le sue opere” [Ap 22,12], mi dico che nei miei riguardi sarà molto imbarazzato. Non ho opere! Non potrà dunque rendermi “secondo le mie opere”… Ebbene! mi renderà “secondo le Sue proprie opere…”»[22].
Sorprendente esegesi del versetto dell’Apocalisse! Teresa contraddice tranquillamente la parola di Dio. O meglio, ne fa un’esegesi molto libera che, in altri tempi, avrebbe potuto essere tacciata di luteranesimo. Dio non ha bisogno delle nostre opere, non saremo giudicati dalle nostre opere. Questa convinzione è profondamente radicata in Teresa. La ritroviamo ad esempio nel Manoscritto «B». Lei legge nel Sal 49: «Non ho alcun bisogno dei capri dei vostri greggi […]. Offri a Dio sacrifici di lode e di azioni di grazie». E lei commenta: «Ecco quindi tutto ciò che Gesù esige da noi. Egli non ha affatto bisogno delle nostre opere, ma solamente del nostro amore»[23]; «Infatti Gesù non chiede grandi azioni, ma soltanto l’abbandono e la riconoscenza»[24].
San Paolo aveva scritto: «Essere trovato in lui, avendo come mia giustizia non quella derivante dalla Legge, ma quella che viene dalla fede in Cristo, la giustizia che viene da Dio, basata sulla fede» (Fil 3,9). Ciò che Teresa riscopre, con un’audacia e una certezza di senso teologico che rischia di sfuggirci, è in fondo la dottrina paolina della giustificazione per fede. Il trionfo dell’amore sulla giustizia. È così che dobbiamo intendere la sua famosa offerta del 9 giugno 1895, la sua «Offerta di me stessa come Vittima d’Olocausto all’Amore Misericordioso del Buon Dio»[25]. Prendendo in considerazione solo le parole «vittima» e «olocausto», si può provare un disappunto per la teologia sacrificale e vittimistica, la spiritualità doloristica «tipica dell’epoca», che ne sarebbe alla base. In realtà, è una preghiera dalla teologia molto sicura: l’uomo non può ottenere la sua giustizia da sé stesso, ma da Dio.
Teresa esordisce esprimendo il suo desiderio di servire Dio, di fare la sua volontà: «In una parola, desidero essere Santa, ma sento la mia impotenza e ti domando, o mio Dio, di essere tu stesso la mia Santità»[26]. E, al centro dell’atto di offerta, c’è questa affermazione: «Alla sera di questa vita, comparirò davanti a te a mani vuote, perché non ti chiedo, Signore, di contare le mie opere. Ogni nostra giustizia è imperfetta ai tuoi occhi. Voglio perciò rivestirmi della tua propria Giustizia e ricevere dal tuo Amore il possesso eterno di Te stesso»[27]. Questa è l’essenza della «piccola dottrina» di Teresa.
Sconfiggere l’Angelo del Giudizio
Questa «piccola dottrina» dell’Amore sconfigge il giansenismo ancora diffuso nella coscienza e nella sensibilità cattolica all’inizio del XX secolo. Teresa ne era, a quanto pare, consapevole. Si sa che il giansenismo vedeva Dio soprattutto come un giustiziere. Lei spiega perché si è sentita portata a fare questa offerta all’amore: «Pensavo alle anime che si offrono come vittime alla Giustizia di Dio, allo scopo di stornare e attirare su di sé i castighi riservati ai colpevoli; questa offerta mi sembrava grande e generosa, ma io ero lontana dal sentirmi portata a farla»[28]. Ammirevole eufemismo! In realtà, Teresa rifiuta assolutamente questa figura di un Dio giustiziere, di un Moloch che esige il suo tributo dai colpevoli! Questa immagine era molto diffusa all’epoca. Non è detto che questa immagine di un Dio perverso e sadico sia del tutto scomparsa dalle nostre coscienze… E c’erano anime, come dice Teresa, pronte a offrirsi come vittime in sostituzione. Molto poco adatta a me, dice; se altri vogliono offrirsi, non io!
Non c’era bisogno di guardare lontano. Gli storici del Carmelo hanno scoperto che, il giorno prima che Teresa facesse la sua «Offerta come vittima d’olocausto all’Amore misericordioso» – e non alla Giustizia! –, era arrivato al monastero un particolare necrologio che senza dubbio era stato letto nel refettorio. Quello di suor Maria di Gesù, carmelitana di Luçon che, come si legge nella nota dell’«Atto di offerta all’Amore misericordioso», «si è spessissimo offerta come vittima alla Giustizia divina». La stessa nota rivela che la sua agonia, il Venerdì Santo del 1895, era stata terribile. La morente lascia sfuggire il suo grido di angoscia: «Porto i rigori della Giustizia divina!… La Giustizia divina!… La Giustizia divina!…». E ancora: «Non ho sufficienti meriti, bisogna acquistarne»[29]. Questo è forse edificante, ma lontano dalla spiritualità di Teresa.
È questa spiritualità della fiducia nella povertà spirituale, questa spiritualità dell’abbandono che in fondo spiega la seduzione esercitata dalla figura di Teresa. Ma questa fiducia – che è l’altro nome della fede – non è stata così semplice come si potrebbe pensare. Affinché questa bozza del ritratto di Teresa non sia troppo incompleta, bisogna evocare il lato notturno della sua esperienza di Dio. Dio era stato il sole della vita di Teresa; ma gli ultimi 18 mesi della sua vita sono trascorsi in una fitta notte spirituale di cui non ha mai conosciuto la fine. Bisogna comprenderne la portata.
La prova delle tenebre: il Dio nascosto
Alla fine della sua vita, Teresa sperimenta quella che poi diventerà, nel secolo della Shoah e dei Gulag, una prova ampiamente condivisa: il mistero di Dio che si nasconde nella storia degli uomini, più di quanto «vi si riveli». Dio è venuto a nascondersi ai suoi occhi, a sottrarsi allo sguardo della sua fede, al punto che Teresa si vede, come dice, «seduta alla tavola dei peccatori», posta nella schiera di coloro che dicono: «Non c’è Dio».
Teresa non si sofferma sul racconto di questa vicenda. Sta a noi leggere tra le righe. L’evocazione occupa quattro pagine del Manoscritto «C». All’improvviso, nei primi giorni di Pasqua del 1896, 18 mesi prima della sua morte, il pensiero del Cielo, di Dio, di Cristo, un pensiero che l’aveva sempre incantata e che era stato la fonte della sua gioia, della sua vita spirituale, non le dice più niente. Dio tace. Quando prega, si trova di fronte a un muro. Nessuna breccia. Nella sua vita ha l’impressione di trovarsi in un tunnel buio. Tenebre fitte, nebbia. Queste sono le sue parole. In precedenza, non poteva credere – citiamo testualmente – «che esistessero degli empi che non avessero la fede. Credevo che dicessero cose in contrasto col loro stesso pensiero quando negavano l’esistenza del Cielo». Ora, dice che «Gesù le ha fatto sentire che ci sono veramente delle anime che non hanno la fede»[30]. «Quando voglio far riposare il mio cuore stanco delle tenebre che lo circondano, ricordando il paese luminoso verso il quale aspiro, il mio tormento raddoppia. Mi sembra che le tenebre prendano la voce dei peccatori e mi dicano, prendendomi in giro: “Tu sogni la luce, una patria fragrante dei più soavi profumi; sogni il possesso eterno del Creatore di tutte queste meraviglie; credi di uscire un giorno dalle nebbie che ti circondano. Vai avanti, vai avanti, rallegrati della morte che ti darà non ciò che speri, ma una notte ancora più profonda, la notte del nulla!»[31].
C’è anche questa confidenza fatta oralmente a Madre Agnese, poche settimane prima della sua morte: «Se sapesse, mi disse, che terribili pensieri mi ossessionano! Preghi tanto per me, affinché io non ascolti il demonio che vuole insinuare in me tante menzogne. È il ragionamento dei peggiori materialisti che si impone al mio spirito: in futuro, facendo continuamente nuovi progressi, la scienza spiegherà tutto naturalmente, si possederà la ragione di tutto ciò che esiste e che rimane ancora un problema, perché restano molte cose da scoprire…, ecc. ecc.»[32]. Nessuno intorno a lei sospettava la profondità di questa notte della fede. Teresa rimaneva così gioiosa e serena, piena di umorismo! Sapeva e sperimentava veramente cosa fosse la fede pura. Credere quando si ha qualche motivo per credere può essere avere fede. Ma credere quando sfuggono tutte le ragioni per credere è l’inizio della fede pura, della fede mistica.
Conclusione
L’esperienza teresiana indica la vita quotidiana, nella sua banalità e nella sua stessa assenza di significato, come luogo dell’esperienza mistica. La vita monastica come vita familiare. Il mistero di Nazaret. Anche Charles de Foucauld ha vissuto questa mistica di sotterrare l’amore nella vita quotidiana e nella semplicità. Il nostro tempo si riconosce in questa modestia. Questo tipo di santità parla a tutti coloro che sono stanchi di cercare il senso nell’eccezionale e vogliono trovarlo nella vita quotidiana. E persino in ciò che sembra più trascurabile nella vita quotidiana.
C’è senza dubbio una profonda sintonia tra Teresa e il nostro tempo. Notiamo semplicemente che, nella letteratura moderna, in autori diversi come Kafka, Bernanos, Ionesco o Beckett per esempio, i personaggi rappresentati sono molto lontani dagli eroi tradizionali della letteratura. Si tratta generalmente di persone molto comuni, «antieroi», come è stato detto ad esempio di Meursault, il protagonista del romanzo Lo straniero di Albert Camus. Allo stesso modo Teresa: non ha nulla, a priori, di una santa eroica o fiammeggiante, di una Giovanna d’Arco o di una Teresa d’Avila. La letteratura moderna, d’altronde, attesta quella che rimane la grande novità del nostro tempo e il suo enigma: il silenzio di Dio, l’assenza di Dio, l’apparente assenza di Dio dalla storia degli uomini. Teresa ne sapeva qualcosa. La sua vita quotidiana ci è oggi facilmente accessibile, grazie al lavoro degli storici recenti. Essi ci rivelano una vita quotidiana infinitamente più ricca e complessa di quanto supponessero le consorelle di Teresa. Ma una quotidianità pur sempre posta sotto il segno della fiducia e dell’abbandono al Dio della misericordia. Una santità alla portata di tutti.
Copyright © La Civiltà Cattolica 2024
Riproduzione riservata
***
[1]. Teresa di Gesù Bambino, s., Opere complete, Città del Vaticano – Roma, Libreria Editrice Vaticana – OCD, 2009, 234. Questo volume comprende i Manoscritti autobiografici, le Lettere, le Poesie, le Pie Ricreazioni, le Preghiere e anche gli Ultimi Colloqui, le parole di Teresa nei suoi ultimi mesi, annotate giorno per giorno dalle sorelle, in particolare da Paolina, e poi da lei copiate nel «Quaderno giallo».
[2]. L’edizione critica delle opere di santa Teresa è conosciuta con il titolo «Nuova Edizione del Centenario», ed è stata fatta tra il centenario della nascita (1873) e quello della morte (1879) della santa carmelitana. Viene presentata nel volume citato nella nota 1.
[3]. Lo scrittore Georges Bernanos è un’eccezione. Tra le due guerre mondiali, i suoi protagonisti – il parroco d’Ambricourt, Chantal de Clergerie – si ispirano direttamente a Teresa.
[4]. Cfr H. Urs von Balthasar, Therese von Lisieux. Geschichte einer Sendung, Köln, Hegner, 1950.
[5]. Teresa di Gesù Bambino, s., Opere complete, cit., 91.
[6]. Ivi, 223.
[7] . Ivi, 144.
[8] . Ivi.
[9] . Ivi, 145.
[10]. Ivi.
[11]. Come ha dimostrato C. Langlois, Lettres à ma Mère bien-aimée, Juin 1897. Lecture du Manuscrit C de Thérèse de Lisieux, Paris, Cerf, 2007.
[12]. Teresa di Gesù Bambino, s., Opere complete, cit., 235.
[13]. Ivi, 124.
[14]. Ivi, 338 (Lettera 52).
[15]. Ivi, 367 (Lettera 80).
[16]. Cfr ivi, 1280, nota 14.
[17]. Ivi, 221.
[18]. Madre Maria degli Angeli, in una lettera a una suora della Visitazione di Le Mans, aprile-maggio 1893.
[19]. Teresa di Gesù Bambino, s., Opere complete, cit., 979 («Quaderno giallo», 21-26 maggio).
[20]. Ivi, 79.
[21]. Ivi; corsivo nostro.
[22]. Ivi, 975(Ultimi Colloqui, 15 maggio).
[23]. Ivi, 218.
[24]. Ivi.
[25]. Ivi, 941.
[26]. Ivi, 942.
[27]. Ivi, 943.
[28]. Ivi, 210.
[29]. Ivi, 1437.
[30]. Ivi, 238.
[31]. Ivi, 240.
[32]. Ivi, 1159.