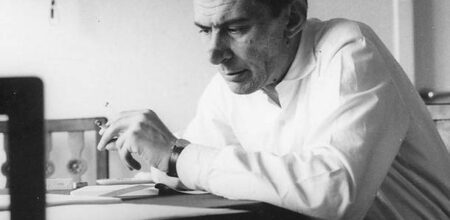Ho incontrato Sandro Calvani il 18 febbraio 2023 a Milano. Eravamo insieme relatori a un convegno. Ho ascoltato la sua relazione sulla possibile riforma delle Nazioni Unite. Prendendo spunto da quel discorso, che ho trovato estremamente interessante, ho deciso di realizzare una intervista per i lettori de La Civiltà Cattolica.
Calvani ha al suo attivo una carriera di alto dirigente delle Nazioni Unite, e per i suoi incarichi ha lavorato e vissuto in 135 Paesi del mondo. In particolare, il suo impegno è stato legato all’Organizzazione mondiale della sanità (Oms). Tra i tanti incarichi ricevuti, ricordiamo quello di direttore regionale, per il Sud-est asiatico e il Pacifico, del programma anti-droga e anti-crimine dell’Onu, con sede a Bangkok, con la responsabilità su 31 Paesi della regione; e poi quello di direttore dello stesso programma in Colombia.
Nel 2007 fu nominato dal segretario generale delle Nazioni Unite, Ban Ki-moon, direttore dell’United Nations Interregional Crime and Justice Research Institute. Da settembre 2010 a giugno 2013 è stato direttore esecutivo del Centro di eccellenza dell’Associazione delle nazioni del Sud-est asiatico (Asean) sugli Obiettivi di sviluppo del millennio. Ha scritto una trentina di libri sulle sue esperienze tra i più poveri. È docente di Diritti umani e Politiche dello sviluppo sostenibile in varie università asiatiche.
Sandro Calvani con papa Francesco (foto: Vatican Media)
Siamo qui a parlare di Onu e della sua possibile riforma. Ma prima vorrei riepilogare con Lei alcune questioni di fondo. La prima: che cosa c’è all’origine delle Nazioni Unite?
80 anni fa, alla fine della Seconda guerra mondiale, le Nazioni Unite nacquero da una visione davvero condivisa dei governi e dei popoli di riforma delle relazioni internazionali, per renderle collaborative, inclusive e pacifiche. La prima «Dichiarazione delle Nazioni Unite» fu firmata a Washington il 1° gennaio 1943.
La «Dichiarazione sulla pace e la sicurezza», firmata a Mosca il 1° novembre 1943 dai leader di Cina, Regno Unito, Stati Uniti e Unione Sovietica riconobbe la necessità di istituire al più presto un’organizzazione internazionale generale, «basata sul principio dell’uguaglianza sovrana di tutti gli Stati amanti della pace, e aperta all’adesione di tutti gli Stati, grandi e piccoli, per il mantenimento della pace e della sicurezza internazionali».
Al momento della creazione dell’Onu, durante la conferenza di San Francisco del 26 giugno 1945, il presidente statunitense Truman disse ai rappresentanti dei 51 Stati fondatori: «La carta delle Nazioni Unite che state firmando è una struttura solida sulla quale possiamo costruire un
Contenuto riservato agli abbonati
Vuoi continuare a leggere questo contenuto?
Clicca quioppure
Acquista il quaderno cartaceoAbbonati
Per leggere questo contenuto devi essere abbonato a La Civiltà Cattolica. Scegli subito tra i nostri abbonamenti quello che fa al caso tuo.
Scegli l'abbonamento