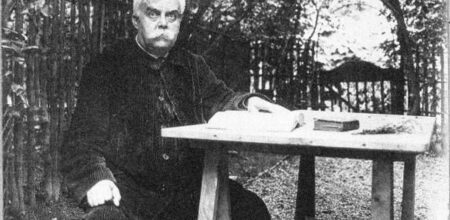|
|
L’Africa è il «continente della speranza». Una speranza che vediamo negli occhi degli uomini e delle donne, per la grande maggioranza giovani, che arrivano in Europa. Una speranza che, se trova la possibilità di essere accettata, messa a frutto e accompagnata adeguatamente, insieme alla comunità che li accoglie, può essere un grande contributo per l’Europa che va invecchiando. Tuttavia le notizie dei migranti africani che perdono la vita sulla via verso l’Europa sono ormai all’ordine del giorno. L’isola di Lampedusa evoca immagini orribili di migliaia di corpi neri senza vita, gettati a riva dalle onde inesorabili del mare. Ci si aspetterebbe che tutte quelle vittime fungessero da deterrente per chi aspira a queste migrazioni, ma migliaia e migliaia di africani continuano a intraprendere il rischioso viaggio in mare per l’Europa. Nella stessa Africa, d’altra parte, benché continui a fornire accoglienza per l’80% dei suoi migranti, oggi non sempre a chi proviene da altre zone del continente è stata accordata quell’ospitalità che rappresenta uno dei tratti distintivi dell’ethos Ubuntu (che significa «umanità», «reciproca benevolenza»). Lo dimostra, ad esempio, la recente ondata di attacchi xenofobi scoppiati in Sud Africa.
I migranti cercano una nuova casa?
La storia dell’umanità è piena di migrazioni di popoli. Di fatto, gli spostamenti hanno caratterizzato le società umane fin da prima dell’avvento della civiltà. Le persone si trasferivano da una zona all’altra in cerca di cibo, acqua e sicurezza. Anche dopo l’introduzione dell’agricoltura, le comunità hanno continuato a muoversi alla ricerca di terreni fertili e di pace. In altre parole, le migrazioni sono sempre state attivate dalla carenza di una necessità primaria, da un lato, e, dall’altro, dalla prospettiva di una vita migliore altrove. Ma ci si può chiedere: migrazione è partire da casa oppure cercare una casa? Per rispondere a questa domanda è anzitutto importante analizzare il concetto di «casa», che si presta facilmente a usi banalizzanti e superficiali.
Che cosa è «casa»?
C’è una stretta connessione tra lo spazio fisico e il concetto di casa. La casa è lo spazio che ospita i ricordi. Si dice che sia la dimora – e in particolare la dimora in cui si nasce – a offrire l’esperienza primordiale di una casa. La vita umana inizia con il benessere offerto dal calore umano dato e ricevuto in una casa. Nel calore di una casa, essere è ben-essere. «La vita comincia bene», perché «incomincia racchiusa, protetta, al calduccio nel grembo della casa»[1]. Quando si viene gettati fuori dall’abitazione in cui si è nati, nel vasto mondo crudele, si rimpiange e si sogna quel calore di cui un tempo si godeva nella dimora natale. Caratteristica essenziale della «casa» è un senso di protezione. Casa è la culla che ci protegge da ogni forma di pericolo. La perdita del calore e della protezione della «casa primordiale» può provocare disturbi della personalità.
La stretta associazione tra «casa-focolare domestico» e «casa-abitazione» è messa in evidenza dal fatto che in molte lingue africane – in particolare le lingue bantu dell’Africa sub-sahariana – i termini usati per «casa» e «abitazione» sono molto simili, quasi identici. In swahili, per esempio, «abitazione» è nyumba, mentre «casa» è nyumbani. In chewa (che si parla in Malawi, Zambia e Mozambico), «abitazione» si dice nyumba, e «casa» kunyumba. I Bemba dello Zambia chiamano l’«abitazione» ng’anda, mentre la «casa» si dice kung’anda. Si capisce quindi come nelle società tradizionali africane la vita di strada fosse sconosciuta. Nella società tradizionale, il fenomeno dei bambini di strada, che attualmente affligge molte città africane, non avrebbe senso; infatti, essere a casa propria significa necessariamente avere un’abitazione.
Inoltre, per l’africano la casa è la terra ancestrale, il luogo dove sono sepolti gli antenati. Quando si muore, ci si deve ricongiungere con i propri antenati. Infatti, «è nella terra del riposo ancestrale il luogo in cui i genitori seppelliscono i cordoni ombelicali dei loro figli, per collegarli in modo inequivocabile alla loro ascendenza»[2]. Quando le cose vanno male, gli africani tendono a tornare alla terra ancestrale, dove svolgono riti tesi a ripristinare l’armonia e il benessere. Lasciare la propria terra d’origine comporta la recisione dei legami fondamentali con i propri antenati; tale separazione può determinare uno squilibrio psicologico[3]. Ecco perché molte società africane insistono sul rimpatrio dei corpi di amici e parenti, affinché il defunto possa riposare a casa piuttosto che vagare per sempre nell’aria.
Quanto è stato detto dovrebbe portare a rafforzare la tendenza a territorializzare l’idea di casa. Poiché il focolare domestico è inestricabilmente connesso con certi spazi che evocano il calore primordiale e il benessere, il rapporto tra la casa e altri spazi sembrerebbe essere un rapporto di contraddizione più che di contrarietà[4]. Mentre la contrarietà ammette una continuità tra due realtà diverse (per esempio, nero e non-nero), la contraddizione genera una contrapposizione radicale tra opposti (per esempio, bianco e nero). Si direbbe quindi che gli africani che lasciano l’Africa per l’Europa e altre destinazioni vadano via di casa per una sorta di esilio o di diaspora: si stanno «spargendo» o «disperdendo» (tale infatti è il significato della parola greca diaspora).
Ciò implica che quanti lasciano le proprie terre ancestrali non saranno mai a casa, ovunque vadano. Potranno avere una buona abitazione, ma quell’abitazione non potrà mai diventare per loro una casa. Potranno godere della sicurezza socio-economica, ma questa non potrà mai sostituire il calore della culla ancestrale.
La realtà, tuttavia, è più complessa. «Casa» non è un concetto fisso, ma dinamico. Non è un’entità monolitica, ma una realtà ambivalente. Non è un prodotto confezionato, ma un processo. La storia umana offre ampie dimostrazioni del fatto che «casa» è un concetto relativo. L’idea di casa è il prodotto di ricordi, fantasie e aspirazioni. Gli esseri umani sono sempre alla ricerca della loro casa «ideale», che sfida ogni tentativo di localizzazione. Qualsiasi spazio abitato può potenzialmente diventare casa fintantoché offre un certo numero di beni. Per lo stesso motivo, anche la terra avita può smettere di essere casa una volta che non garantisce più i beni essenziali per la sopravvivenza e il benessere umano.
Il racconto biblico della vocazione di Abramo offre spunti interessanti. Innanzitutto, Abramo è chiamato a lasciare la sua terra natia al crepuscolo della sua vita. Chi avrebbe mai detto che all’età di 75 anni egli potesse avventurarsi nel crudele mondo esterno, alla rischiosa ricerca di una nuova casa? La sua partenza da Carran lo fa subito piombare nella crisi della liminalità: egli perde qualunque titolo o diritto di cui godeva nella terra ancestrale.
La sua chiamata è raccontata in Gen 12,1-3, ma nel versetto 10 egli è già preda dei morsi della carestia, che lo costringono a lasciare la Terra promessa per andare in Egitto, dove rischia di perdere la moglie a causa del faraone. Ciononostante, le tribolazioni del suo soggiorno non lo inducono a far ritorno a Carran, la sua terra d’origine. Sebbene in seguito vi mandi il suo servo per riportare da lì una moglie per Isacco, Abramo non tornerà mai nella terra di suo padre Terach. La casa di Abramo non è alle sue spalle: Dio ha promesso una casa a lui e ai suoi discendenti. Quando Abramo muore, le sue ossa non vengono riportate a Carran: egli viene sepolto in una terra che aveva acquistato dagli hittiti (cfr Gen 25,7-10).
Un altro racconto interessante è quello del Libro dell’Esodo. Il popolo di Israele è vissuto in Egitto per 430 anni, dopo di che la sua percezione di «casa» viene compromessa dalla nascita di un re ostile all’esistenza della comunità degli israeliti. Dal punto di vista umano, quattro secoli sarebbero stati più che sufficienti a chiunque per chiamare un luogo «casa», soprattutto quando esso offriva sicurezza e prosperità (cfr Gen 47,27), perché in Egitto «Israele non ha soggiornato: vi ha abitato, vi si è stabilito saldamente»[5].
È probabile che nelle sue conversazioni e attività quotidiane il popolo di Israele chiamasse «casa» l’Egitto. Gli Stati Uniti d’America costituiscono un buon esempio in proposito: sebbene questa nazione abbia meno di 300 anni, le comunità che vi sono migrate dall’Europa e da altri luoghi, anche meno di un secolo fa, oggi chiamano l’America «casa».
Eppure, anche dopo 400 anni il popolo di Israele fu pronto a intraprendere un viaggio verso la sconosciuta Terra promessa: una terra in cui, nella fantasia popolare, scorrevano latte e miele (cfr Es 3,8.17; 33,3). Antichi ricordi della Terra promessa vennero ridestati per sostenere l’urgente ricerca della libertà. L’esodo fu reso necessario dai disagi della schiavitù. Sebbene l’esperienza del deserto fosse una dura tappa estrema, che spesso riportava nell’immaginazione del popolo i ricordi delle pentole della carne in Egitto (cfr Es 16,3), gli israeliti continuarono a marciare verso la Terra promessa. Nella loro ricerca di una nuova casa furono sostenuti dalla manna dell’immaginazione e dalle quaglie della speranza. La casa era davanti a loro, non dietro: dopo l’attraversamento del Mar Rosso, non era più possibile il ritorno.
L’esperienza degli israeliti mostra che anche la comunità più stabilizzata si mette comunque alla ricerca di una casa alternativa, se le condizioni di vita sono diventate insopportabili nel luogo che finora essa ha chiamato «casa». Le persone che hanno lasciato l’Europa per le Americhe si sono sradicate dalle proprie terre ancestrali per cercare un luogo più meritevole del nome di «casa». Nessuna radice culturale è tanto forte da trattenere in un luogo un popolo il cui benessere sia stato compromesso.
L’avvento dell’urbanizzazione ha visto le comunità africane abbandonare le proprie case alla ricerca di opportunità nelle città. Così il movimento dei popoli – specialmente dei popoli rurali che inseguono le promesse della modernizzazione – relativizza il significato della casa come terra ancestrale[6].
Un’altra osservazione che possiamo fare è che proprio nella misura in cui le nuove abitazioni si trasformano gradualmente in «case», i nuovi arrivati alla fine cominciano a etichettare altri come stranieri. Così, nella sua prescienza, Dio ammonì il popolo di Israele: una volta che avessero ereditato la terra, non avrebbero dovuto maltrattare gli stranieri, perché essi stessi un tempo erano stati stranieri in Egitto (Es 22,20). La memoria tende a dimenticare, proprio perché ciò che viene ricordato è in parte una sua costruzione. La crescita dei movimenti politici contrari all’immigrazione in Europa e altrove è un esempio eloquente di come la questione dell’«origine» sia, nel complesso, una costruzione. È un dato di fatto che gli antenati di ogni persona sono venuti da qualche parte[7].
L’immaginazione costruisce «casa» non meno della memoria, ed entrambe sono selettive. Ciò che viene immaginato e ricordato è informato, in larga misura, dalle gioie e dai dolori del presente. Gli attacchi xenofobi in Sud Africa, per esempio, sono in parte animati da una memoria selettiva. Sebbene nei registri della storia sia rimasto a verbale il fatto che gli Ndebele dello Zimbabwe sono figli e figlie di Mzilikazi, il quale, nei primi anni del XIX secolo, sfuggì agli attacchi mortali di Shaka Zulu, oggi, appena un secolo più tardi, certi sudafricani non avrebbero remore a etichettare come «stranieri» le donne e gli uomini Ndebele, che scendono a sud in cerca di cibo e di riparo. Si direbbe che il concetto di Stato nazionale, che in Africa ha a malapena mezzo secolo di vita, venga considerato come un punto di riferimento assoluto rispetto a chi fa o non fa parte di una comunità.
L’ Africa e la memoria delle case distrutte
Le migrazioni di persone all’interno e fuori dell’Africa sono il prodotto del fallimento delle comunità africane – e soprattutto dei loro leader – nel rendere i Paesi africani una casa per la gente. Un mito africano della creazione dice che in principio Dio, gli esseri umani e gli animali vivevano insieme in pace. Ma un giorno gli esseri umani iniziarono a giocare con alcuni pezzi di legno secco, sfregandoli uno contro l’altro, finché non produssero il fuoco. Il fuoco provocò danni così grandi alla casa primordiale da costringere gli animali a fuggire nella foresta, e Dio a ritirarsi nei cieli[8]. La loro casa era distrutta.
Allo stesso modo, Adamo ed Eva hanno fatto di tutto per distruggere la «casa» quando hanno violato il patto e hanno mangiato il frutto proibito; proprio come Caino, uccidendo suo fratello, ha distrutto una casa e si è condannato ad essere un eterno vagabondo sulla terra. Quella della prima famiglia «è una storia che si sposta velocemente dalla casa verso l’assenza di un tetto, da una vocazione a occuparsi della casa alla distruzione violenta di questa, da una visione di armonia domestica a una narrazione di violenza domestica»[9].
Le condizioni politiche e socio-economiche in Africa richiamano alla mente le case distrutte. La violenza politica alimentata dal fuoco dell’avidità, il sottosviluppo della produzione e delle infrastrutture manifatturiere, l’orizzonte sempre più ristretto lasciato alla solidarietà – ben esemplificato dalla pandemia del tribalismo –, la continua diminuzione delle opportunità economiche, aggravata dalla corruzione e dalla radicata cultura dell’importazione di prodotti e servizi stranieri, che generano la perdita massiccia di posti di lavoro: ecco alcuni fattori che distruggono la casa e che mettono in moto quelle forze centrifughe chiamate «migrazioni». Migrazioni che, purtroppo, sono in primo luogo alimentate da conflitti e violenze nuovi e irrisolti, corruzione e violazione dei diritti umani, distruzione degli ecosistemi e catastrofi naturali, siccità e desertificazione, imposizioni di modelli di vita e culturali, crescita di fenomeni di integralismo, mancanza di sicurezza e molte altre cause che affliggono il continente africano e tengono i suoi figli e le sue figlie in una morsa. L’unica speranza in queste situazioni si intravede nella fuga verso luoghi ove si cerca sicurezza, protezione. Quando intere comunità s’imbarcano su natanti sovraffollati che puntano a nord, non stanno cercando nient’altro se non un luogo propizio per fare casa. Se le condizioni all’estero consentiranno loro di prosperare, un giorno i discendenti di quei migranti chiameranno «casa» le terre di oltremare.
Le migrazioni nell’era delle politiche antimmigrazione
Anche se, in linea di principio, la casa non può essere ridotta alla dimensione spaziale, la realtà politica di oggi tende a legare la «casa» al territorio in cui si è nati. Per esempio, la questione dei birther che ha coinvolto anche Barack Obama mostra chiaramente che l’essere nati nel Paese è conditio sine qua non per l’eleggibilità alla carica più alta dello Stato.
Inoltre, mentre i muri del territorialismo vengono liquefatti dal calore della globalizzazione, le comunità stanno diventando sempre più protettive nei confronti dei propri spazi. Tale protezionismo sta dando vita a movimenti politici antimmigrazione di estrema destra in Europa, in Australia, in Sud Africa, negli Stati Uniti e altrove. Sebbene la politica di Donald Trump, tesa a limitare l’immigrazione negli Stati Uniti, sembri scatenare il malcontento generale secondo i principali mass media, tuttavia è probabile che la posizione del Presidente sia in linea con i sentimenti di vasti settori sociali del mondo sviluppato. In Francia e in Italia, in Germania e nel Regno Unito, i movimenti antimmigrazione stanno guadagnando terreno in campo politico, sfruttando la crescente paura del terrorismo. Infatti, «in un mondo di caos e violenza, l’ospitalità è impossibile, perché la gente cerca di tenere a bada il caos chiudendo le porte»[10].
Man mano che la voce del coro antimmigrazione si fa più alta, diventano più rigide le procedure legali per ottenere documenti di viaggio o permessi di soggiorno. E senza documenti validi, il compito di metter su casa in una nuova terra diventa una possibilità improponibile. Di conseguenza, molti dei migranti africani privi di documenti finiscono al freddo sulle strade d’Europa. Tante donne e ragazze restano intrappolate nel buco nero della prostituzione, mentre molti uomini vengono usati come esche per i cartelli della droga, come il film spagnolo Biutiful, del 2010, ha mostrato in modo eloquente.
Podcast | SUD SUDAN. «UN CONFLITTO CHE NON È MAI FINITO»
Quattro milioni di sfollati, oltre 350mila morti, fame e povertà. Il Sud Sudan è il paese più giovane del mondo, con una storia già segnata dalle violenze. Oggi lo spettro della guerra torna a far paura, come racconta mons. Christian Carlassare, vescovo della diocesi di Bentiu. Ascolta il podcast
Rifare casa in Africa
È importante che gli africani si formino alla partecipazione politica, che vuol dire studiare e lavorare, in dialogo costruttivo ed esigente con i propri governanti. Un dialogo che, quando occorre, può anche diventare dissenso e protesta, purché sia sempre informato dal rispetto delle persone e del diritto, e orientato al bene comune. Il continente ha un estremo bisogno di governi che mettano al primo posto non propri interessi, ma le necessità dei propri popoli: il cibo, il posto di lavoro, la sicurezza, l’istruzione e così via. Ci sono stati cambiamenti di regime, a volte a costo della vita di persone innocenti, ma l’avvicendarsi dei leader non sempre produce il risultato sperato. Con grande disappunto, molte comunità africane hanno viste deluse le proprie attese e hanno perso la speranza «politica», nell’accezione più alta di questo termine. Tuttavia il continente africano è depositario di grandi risorse, immensi tesori di valori umani sinora troppo poco messi a frutto.
Uno di questi è il capitale costituito dallo spirito comunitario. Se questo rappresenta spesso uno dei gravi problemi dell’Africa quando degenera in settarismo e violenza, tuttavia, se rettamente gestito, può anche costituire una ricchezza. Per raggiungere una prosperità durevole le comunità africane possono pianificare e lavorare confidando su se stesse secondo il principio della sussidiarietà, che è bene venga maggiormente rispettato e valorizzato dai governanti e che può grandemente contribuire alla svolta di cui il continente ha bisogno.
Per ricostruire la casa africana, poi, molto si potrebbe fare, anche a prescindere dalle soluzioni politiche. Una delle risposte ai mali del continente africano è l’imprenditorialità locale, partecipativa e responsabile, orientata all’innovazione. Ci sono imprenditori stranieri che arrivano in Africa e fanno fortuna proprio nei cortili dei quartieri poveri, perché sanno come identificare e sfruttare le opportunità di investimento che sono rimaste inutilizzate. Il paradosso è che, per viaggiare via mare verso l’Europa, i migranti africani pagano migliaia di dollari ai trafficanti illegali: denaro che potrebbe essere investito in settori redditizi – come per esempio quello della produzione di energia rinnovabile e di alimenti –, restando nel continente.
In secondo luogo, le comunità africane hanno bisogno d’imparare l’arte della semina: semi per il cibo di cui nutrirsi, semi della tecnologia, semi di uno sviluppo sostenibile. L’espansione della popolazione ha bisogno di essere affiancata dall’espansione delle risorse di base. La proliferazione della libera economia di mercato sta invece rapidamente trasformando l’Africa in un grande mercato selvaggio per prodotti provenienti da tutto il mondo. Secondo un’inchiesta della Bbc, la Nigeria spende 5 milioni di dollari al giorno per farsi spedire riso. Ciò significa che, negli ultimi cinque anni, quel Paese dell’Africa occidentale ha importato circa 17 milioni di tonnellate di riso. L’1,26% del bilancio complessivo per il 2017 è dedicato all’importazione di riso, sebbene il Paese abbia terra in abbondanza per coltivarlo[11].
Le tecnologie di irrigazione ora disponibili fanno sì che la siccità non possa più essere una scusa valida per l’insufficienza di cibo che colpisce le popolazioni africane. Il secondo racconto biblico della creazione (Gen 2,4-25) dice che Dio ha piantato il giardino dell’Eden senza acqua piovana. Per irrigare la superficie della terra Dio usò l’acqua sorgiva: «Quando il Signore Dio fece la terra e il cielo, nessun cespuglio campestre era sulla terra, nessuna erba campestre era spuntata, perché il Signore Dio non aveva fatto piovere sulla terra e nessuno lavorava il suolo e faceva salire dalla terra l’acqua dei canali per irrigare tutto il suolo» (vv. 4-6). Nella sua infinita saggezza e provvidenza, Dio ha benedetto il continente africano con specchi d’acqua sufficienti a far sì che le comunità non dovessero fare affidamento sulla pioggia. Quando queste risorse verranno sfruttate per la produzione alimentare, le donne, gli uomini e i bambini africani smetteranno di vagheggiare immaginarie pentole della carne all’estero; l’Africa tornerà a essere casa.
In terzo luogo, gli africani che hanno il privilegio di andare all’estero dovrebbero riportare in patria non soltanto denaro (sotto forma di rimesse) o competenze, ma soprattutto una Weltanschauung che rinforzi e valorizzi i processi e prenda sul serio il ruolo dell’iniziativa diretta come motore per dare vita a economie innovative e a governi responsabili.
Nella vita, a parte la pioggia, non c’è niente che cada dal cielo. La costruzione di infrastrutture funzionali dipende dallo sforzo e dall’ingegno degli esseri umani. In generale, le innovazioni significative provengono dal basso. Per esempio, non è stato il governo federale degli Stati Uniti a concepire o a costruire Facebook. Non è sufficiente dunque che gli africani si assicurino posti di lavoro in Occidente, né che siano in grado di inviare denaro alle famiglie rimaste a casa: fondamentale è piuttosto la capacità, da parte di coloro che sono espatriati, di far tesoro della competenza dei Paesi sviluppati per utilizzarla nella trasformazione dell’Africa.
Infine, aiuti, contributi e donazioni dovrebbero concentrarsi meno su progetti orientati al consumo e più su infrastrutture finalizzate alla produzione. I miliardi di dollari che si dice siano stati riversati in Africa nel corso dei decenni avrebbero fatto davvero la differenza se fossero stati impiegati per la costruzione di infrastrutture a lungo termine. Un conto è donare i computer a una scuola povera in Africa, altro è insegnare ai bambini africani a costruire computer, soprattutto in considerazione del fatto che la maggior parte delle materie prime si trova proprio in Africa. Un conto è comprare pompe idriche per una comunità rurale, altro è insegnare come fabbricarle ai figli e alle figlie dell’Africa.
La storia offre molte lezioni sul fatto che l’arte della fabbricazione di utensili sta al centro di ogni civiltà e che la prosperità è determinata dall’efficienza degli strumenti di produzione. L’Africa è rimasta ferma all’invenzione degli utensili manuali, come le zappe e le asce, mentre il resto del mondo continua a sfornare nuovi strumenti sul mercato. Reimparare l’arte di fabbricare strumenti è indispensabile per la ricostruzione della casa africana.
Conclusione
Non si può negare che la migrazione sia una delle leggi inscritte nel Dna di ogni creatura capace di movimento. Da tempo immemorabile i popoli, gli uccelli del cielo e gli animali della foresta migrano da una zona all’altra in cerca di cibo, acqua e sicurezza. Ovunque trovino queste risorse, quel luogo diventa una casa. Tuttavia il fenomeno moderno dello Stato nazionale ha trasformato il concetto di «casa» in una realtà territoriale. Pertanto non ha senso neppure negare che allo stato attuale l’Africa sia la sede territoriale degli africani (laddove «africano» non è necessariamente uguale a nero).
In quanto tali, le comunità africane faranno bene a iniziare l’arduo compito di rimettere in piedi la propria casa, invece di correre all’estero in cerca di aiuto. Il progetto del «fare» casa comincia con il piantare un seme oggi, in modo che le generazioni future possano raccogliere domani covoni dorati di pace, di prosperità e di orgoglio.
Copyright © La Civiltà Cattolica 2018
Riproduzione riservata
***
AFRICAN MIGRANTS: WHERE TO REBUILD «HOME»?
The news of African migrants who lose their lives on the way to Europe is now all too commonplace. In the meantime, anti-immigration policies are on the increase and generate a widespread feeling of fear and rejection. Reflecting on the ambivalent concept of «home», it is possible, first of all, to criticize the assumptions on the basis of which communities discriminate against immigrants; and, secondly, evaluate the sustainability of migrations in the era of political movements that oppose them and possible alternatives. Could this be the time, for Africans, to sow, so that Africa may once again become «home» for their children?
***
[1]. Cfr G. Bachelard, La poetica dello spazio, Bari, Dedalo, 1957, 35.
[2]. L. Magesa, What is Not Sacred? African Spirituality, Nairobi, Acton Publishers, 2014, 59.
[3]. Cfr J. Mbiti, African Religions and Philosophy, Oxford, Heinemann, 1969, 26 s.
[4]. Prendiamo in prestito questa idea dal «quadrato semiotico», uno strumento della linguistica.
[5]. W. Brueggemann, The Land: Place as Gift, Promise, and Challenge in Biblical Faith, London, SPCK, 1978, 9. Corsivo nel testo.
[6]. Cfr R. Schreiter, The New Catholicity: Theology Between the Global and the Local, Maryknoll (NY), Orbis Books, 1997, 11.
[7]. Cfr R. Rubenstein, Home Matters: Longing and Belonging, Nostalgia and Mourning in Women’s Fiction, New York, Palgrave, 2001, 164.
[8]. Cfr M. Schoffeleers, Religion and the Dramatisation of Life: Spirit Beliefs and Rituals in Southern and Central Malawi, Blantyre, Claim, 1997, 25-28.
[9]. S. Bouma-Prediger – B. J. Walsh, Beyond Homelessness: Christian Faith in a Culture of Displacement, Grand Rapids (NY), William B. Eerdmans, 2008, 15.
[10]. Id., Beyond Homelessness…, cit., 20.
[11]. Cfr I. Ndukwe, «Why does Nigeria import so much rice?», in www.bbc.com/news/ 2 febbraio 2017.