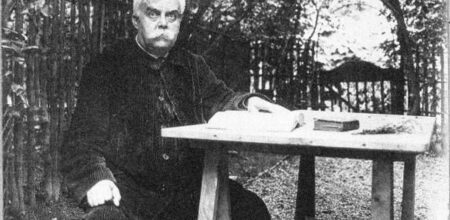|
|
Il beatus ille qui procul negotiis… di Orazio è un ironico elogio della vita rurale[1]. L’ironia sta nel fatto che la vita tranquilla di cui gode chi vive lontano dagli affari della città dipende dall’avere la possibilità, a fine mese, di andare in quella città che tanto evita, per riscuotere la sua rendita. L’elogio della vita di campagna è pertanto possibile solo se sullo sfondo c’è la città che offre un sicuro rifugio.
La tensione tra la vita rurale e quella cittadina è un tema antico[2].Però, come la descrive Orazio, è la forma che ritorna nelle «arcadie private» del nostro tempo dove, tuttavia, si ripete anche l’argomento del et in arcadia ego[3], perché in questi mondi chiusi si crea solo l’illusione che nell’«arcadia» si eviti la morte e ogni annuncio o anticipo di essa.
Ma più che la relazione tra campagna e città, qui intendiamo considerare la città in se stessa, come la si è pensata e come la si è vissuta. È la città, considerata in se stessa, dalla quale, secondo Orazio, era meglio vivere lontani, sebbene potesse offrire alcuni benefici.
Lo faremo a due livelli di riflessione. La nostra analisi prende le mosse dall’opera di Italo Calvino Le città invisibili[4]. Ma alla considerazione dell’immagine letteraria come descrizione della città realmente esistente (sia pure come fiction) dobbiamo aggiungere l’immagine essenziale della città, cioè il concetto astratto di città. La realtà della fiction e la realtà ideale sono l’universalizzazione in tensione delle città in cui viviamo. In tal modo la lettura de Le città invisibili non soltanto ci procurerà un piacere estetico, ma anche ci permetterà di ricavarne un messaggio per la città di oggi, quella che ci tocca abitare.
Questo non è arbitrario, poiché sappiamo che Calvino era un uomo fortemente impegnato nel mondo, come ci testimoniano la sua appartenenza al Partito comunista e la disillusione che provò dopo il suo viaggio in Russia. Lo stesso Calvino, in una conferenza su Le città invisibili, ha affermato: «Credo che non sia solo un’idea atemporale di città quello che il libro evoca, ma che vi si svolga, ora implicita ora esplicita, una discussione sulla città moderna»[5].
Partendo dalla considerazione della città essenziale e dalla descrizione fatta da Calvino, avremo modo di esaminare altri scrittori che arricchiranno la nostra riflessione.
Il metodo
Per rispondere alla domanda su ciò che è «città», vale a dire quali sono le caratteristiche della realtà a cui diamo il nome di «città», quali sono gli elementi che la costituiscono, quali le sue sfide e quali le sue tentazioni, è necessaria una riflessione sull’essenza della «città».
Un metodo di tipo aristotelico proporrebbe di fare un’astrazione a partire dalle città concrete per scoprire il «genoma» dal quale nascono le città visibili. Al contrario, un metodo ispirato a una prospettiva platonica tenderebbe a descrivere innanzitutto il «genoma», la «radice», la «fonte» o la «matrice», ossia la città ideale e invisibile, paradigma di quella visibile.
Nessuno di questi due metodi è del tutto fruttuoso, se si trascura la tensione dell’uno con l’altro. Erich Przywara ci presenta l’equilibrio tra questi due metodi nella tensione propria tra l’essenza e l’esistenza[6]. Da una parte, egli sta attento, con Platone, alle origini, perché in esse si plasma l’idea eterna che è alla base di una realtà concreta. E con Platone afferma che la «matrice» originaria è l’ambito intermedio della realtà nel quale ha luogo il passaggio dalla realtà ideale e paradigmatica alla realtà materiale degli individui concreti. La matrice che Przywara propone di studiare è il luogo e il momento nei quali si crea la realtà concreta, che trova il proprio modello nell’idea. Ma d’altra parte, egli propone di recuperare, con Aristotele, la realtà concreta della città così come si presenta storicamente, la città «esistente», che appare in tensione con la città ideale.
Questa duplice prospettiva non è neppure estranea alla visione di Italo Calvino. Il libro Le città invisibili si presenta come una serie di racconti di viaggio che Marco Polo fa a Kublai Khan, imperatore dei tartari[7]. Si tratta di un inventario di città nel quale Calvino descrive città sottili, città continue, città nascoste.
A un certo momento egli presenta un’immagine che – in linguaggio poetico – riassume la tensione del metodo che abbiamo visto in Przywara: racconta che Marco Polo descrive al Khan un ponte, pietra su pietra. E il Khan gli chiede: «Perché mi parli delle pietre? È solo dell’arco che mi importa». Polo risponde: «Senza pietre non c’è arco»[8]. È la tensione tra il reale concreto e l’idea. L’arco è un’idea che non esiste senza le pietre. Ma le pietre da sole non formeranno mai un arco, se non saranno state poste in tensione dalla genialità ideale e pratica che produce la realtà dell’«arco di pietra»[9].
A una tensione analoga sono sottoposte le città visibili. È la realtà che, in tensione al suo interno, oscillando tra l’uno e l’altro polo, si scontra in una lotta invisibile. Queste sono le «città invisibili» che vengono descritte da Calvino. Sono città in relazione con la memoria, con i desideri, con i segni, con gli scambi, con gli occhi, con i nomi, con i morti, con il cielo. Le città visibili vivono grazie alle relazioni invisibili, e talvolta l’invisibile potrebbe essere più reale del visibile, perché da esso proviene la relazione con l’essenza. Il visibile è solo una manifestazione.
Dalla tensione tra queste due realtà sorgerà la domanda a cui intendiamo rispondere in queste pagine.
La città ideale: città invisibile nel mito e nel linguaggio
Due espressioni transrazionali del momento creativo ci permettono di avvicinarci all’essenza, cioè a una comprensione dell’idea trascendente dalla quale ha origine la realtà creata: i miti e il linguaggio. Le riflessioni di due autori ci accompagneranno in questo cammino: quella dello stesso Platone, e quella di Martin Heidegger.
Si sa che l’origine della città occidentale si trova nel mondo greco. La polis era il sistema che garantiva sicurezza nelle relazioni con l’esterno e ordine nelle relazioni interne[10]. Ma, secondo il racconto mitico, questa città ha la sua origine in un delitto. Il mito, riferito da Platone nel Protagora[11], è quello di Prometeo ed Epimeteo[12]. Nella parte che ci interessa, esso parla della necessità di fondare delle città per la sopravvivenza dell’uomo. Questa necessità è stata causata dall’imprudenza di Epimeteo (fratello di Prometeo), il quale, quando gli dèi fecero uscire dal seno della terra i mortali (bestie e uomini), ebbe l’incarico di concedere a ogni nuova creatura i doni che le avrebbero permesso di sussistere. Ma quando l’ultimo dei mortali, cioè l’uomo, uscì dalle viscere della terra, Epimeteo, a causa di una distrazione, aveva esaurito i doni a sua disposizione. Per venire incontro a questa situazione, Prometeo rubò il fuoco di Efesto e la sapienza tecnica di Atena.
Conclude Platone: «Quando l’uomo divenne partecipe di una sorte divina, in primo luogo, a causa del suo legame con la divinità, unico tra gli esseri viventi, cominciò a credere negli dèi, e si dedicò a innalzare loro altari e sacre immagini. Successivamente iniziò ben presto a utilizzare la voce e ad articolare le parole con tecnica, e inventò abitazioni, vestiti, calzari, coperte e gli alimenti che nascono dalla terra. Attrezzati in questo modo, gli uomini dapprincipio vivevano dispersi e non vi erano città; venivano quindi uccisi dalle belve, dal momento che erano più deboli di queste sotto ogni aspetto, e la tecnica artigianale costituiva per loro un valido aiuto per il sostentamento, ma era insufficiente per la lotta contro le fiere; non possedevano ancora una tecnica politica, della quale la tecnica della guerra rappresenta una parte. Vollero allora fare il tentativo di riunirsi e di salvarsi fondando città. Ma, una volta riunitisi, continuavano a commettere ingiustizie reciproche, dal momento che non possedevano una tecnica politica, sicché, disperdendosi nuovamente, riprendevano a essere uccisi. Zeus, temendo che la nostra specie andasse completamente distrutta, inviò allora Hermes per introdurre tra gli uomini il rispetto e la giustizia, perché costituissero il fondamento dell’ordine della città e un legame unificante di amicizia»[13].
Dal mito emergono una serie di elementi che ci aiuteranno nella riflessione. In primo luogo, dobbiamo notare che l’uomo appare come indifeso. A differenza degli animali, gli esseri umani non hanno alcun dono «naturale» per difendersi. La loro sopravvivenza dipenderà pertanto dall’«artificio», dalla capacità di trasformare la natura a proprio profitto.
Un tale artificio è possibile, in secondo luogo, perché l’uomo, per la sua «parentela divina» (cioè perché possiede il fuoco di Efesto e le arti di Atena) è capace di creare. Nello stesso tempo, grazie a questa qualità, l’uomo è capace di entrare in relazione con gli dèi, con gli altri uomini attraverso il linguaggio, e con la terra, dalla quale trae il suo alimento.
Ciò tuttavia non è sufficiente per la sopravvivenza dell’uomo: appare necessaria la costruzione della città (polis). Ma si richiede l’arte adeguata – la politica –, che non è un’arte di Atena. Il mito descrive due aspetti di tale arte politica: innanzitutto, essa serve per proteggere l’uomo da ciò che non appartiene alla sua città (ciò che chiameremmo «politica estera»); ma neppure questa difesa dai pericoli esterni è sufficiente, e allora ci sarà bisogno di imparare a vivere all’interno della città (è ciò che costituirà la «politica interna»). La vita virtuosa, secondo il duplice dono del rispetto e della giustizia, è la forma di arte della politica che riguarda la vita della polis. La sopravvivenza dell’umanità dipende dalla costruzione delle città e dalla convivenza che si instaura in esse. E la convivenza si impara e si migliora vivendo secondo ragione, grazie all’artificio e all’habitus della virtù.
La seconda via per avvicinarci all’essenza della città è quella che riguarda il linguaggio e l’origine delle parole. Ci porterà a risultati simili. In un articolo intitolato «Costruire abitare pensare» Martin Heidegger offre un’analisi sulle città a partire dall’etimologia della parola «costruire». Egli giustifica questo approccio dicendo che, «sebbene si abbia la sensazione che l’uomo forgi il linguaggio, in realtà è il linguaggio che forgia l’uomo»[14]. Per questo il filosofo ritiene che l’analisi dell’origine delle parole ci porti vicino all’essenza della cosa, come Zuspruch nei diversi significati della parola, cioè come «esortazione», «consolazione» e come «verità che ci anima»[15]. Heidegger parte da qui per studiare l’etimologia della parola «costruire» che, nelle radici tedesche, significa «abitare». E «abitare» – egli dice – è «prendersi cura».
Se invece vogliamo far riferimento all’etimologia latina di «costruire», construo viene da struo, che significa «riunire mantenendo un ordine», e dal prefisso con; per cui risulta che «costruire» significa unire una cosa con un’altra, mantenendo un certo ordine. D’altra parte, la parola latina habito si ricollega ad habitus, che ha un doppio significato: abito come vestito, vale a dire «protezione», e abito come abitudine. Con questi significati, possiamo collegare l’etimologia latina di questa parola al tedesco, perché abitare è «dare protezione», ma nello stesso tempo essa si arricchisce del significato di «costruire» in quanto «mettere in ordine», e ciò non occasionalmente, ma come abitudine.
Infine, non dobbiamo dimenticare che, assieme a questo significato, abbiamo uno Zuspruch, un’esortazione, un invito del «costruire» e dell’«abitare» a rispettare la loro essenza.
In un altro passo della conferenza sul costruire e abitare, Heidegger indicava una relazione dell’uomo, della città (in quanto costruzione e abitazione) con quattro elementi: il cielo, la terra, il divino e i mortali. «Prendersi cura» non è solo non danneggiare, ma è anche qualcosa di positivo: significa «badare a», con quella libertà che cerca di condurre ogni cosa alla pienezza della sua essenza[16].
In tale contesto di relazioni, le cose non formano un quinto elemento; esse sono, piuttosto, realtà che trovano la loro essenza in una relazione «ordinata» con questi quattro elementi: salvare la terra; rispettare il cielo con i suoi tempi e i suoi climi; attendere il divino, interpretare i suoi segni e i suoi silenzi; accogliere l’umano[17]. Ma è l’uomo che pone le cose in questo ordine, oppure lo sovverte.
Pertanto, l’idea di città consiste nel prendersi cura di questa relazione dell’uomo con la quaternità[18] nella quale le cose sono il punto di incontro: sono un mezzo, non il fine della relazione. Platone aveva suggerito questi elementi: la relazione con il divino per la parentela con gli dèi; la relazione con gli uomini per il linguaggio; e la relazione con il cielo e la terra nella ricerca degli alimenti.
Le città visibili nella letteratura
Il confronto dell’idea di città con la realtà delle città pone un problema esistenziale. Questo è il luogo delle città descritte da Calvino. La constatazione dell’oscillare tra i poli in tensione tra loro lo spinge, alla fine dell’opera, a riassumere ciò che è comune a tutte le città, ed egli afferma: «L’inferno dei viventi non è qualcosa che sarà; se ce n’è uno, è quello che è già qui, l’inferno che abitiamo tutti i giorni, che formiamo stando insieme»[19]. La città, costruita per «proteggere» e per «mettere in ordine», si è trasformata in inferno. È la constatazione di un allontanamento dall’essenza della città. Che cosa è successo? Che cosa ha fatto sì che il costruire e l’abitare città pensate per custodire nell’ordine si siano trasformati in un inferno?
Un poema di Horacio Ferrer, che Astor Piazzolla ha messo in musica, affronta questo stesso problema. Inizia come una preghiera, poi descrive la città attuale, e termina parlando della città futura che rispetterà la sua essenza.
«E allora abbiamo detto: / Signore, insegnaci / a costruire città / che siano uguali agli alberi / che giungano a essere maturi / prima di seccarsi / (Genesi, primo versetto, capitolo 1972 del testamento futuro). // Città, fondate per odiare. / Città, tanto alte, perché? / Città, cadaveri in piedi. / Città, in polvere torneranno. // Se qui la stella non si vede mai, / da qui la terra, l’essere e il sole se ne andranno, / e regnerà la totale solitudine, / perché è stata scritta la distruzione finale. // Che bello sarà ricostruire! / Mia cara, ti bacio fino a generare / un figlio dal volo di un muratore in pace. // Che bello, ti nasce una città! / Perché quali strade ti sanguinano sotto i piedi! / Perché quale torre sarà il tuo cuore con la fede! // E in ogni pozzanghera ci sarà un piccolo mare / e in ogni fucina un inventore del sole / e su ogni porta un’iscrizione astrale / e in ogni persona triste un apprendista di Dio. // Città, città che saranno. / Città, ho sentito il suo annuncio. / Città, le vengo a costruire. / Città, dalla polvere torneranno»[20].
Nella prima strofa si chiede a Dio che ci insegni a «edificare città» (in un’altra versione si dice: «Dacci la grazia di costruire città»). Qui l’autore fa riferimento alla città ideale: una città che sia come gli alberi, che non muoia senza dare frutto. Una città che dia rifugio, che nutra, che dia ombra, che difenda dal vento, che protegga dalla pioggia e dal sole. La rottura dell’ordine della libertà ha come conseguenza un’erronea comprensione del comando originario di sottomettere la terra e di sottomettere gli animali[21]. Ferrer lo afferma con enfasi: «Se qui la stella non si vede mai, / da qui la terra, l’essere e il sole se ne andranno, / e regnerà la totale solitudine…». E il risultato è inevitabile: la distruzione finale.
Quando si rompe la relazione delle «cose» con la quaternità, cioè quando si frena il processo che ha cura dell’essenza delle cose, queste «si cosificano», diventano veramente «cose», perché perdono la capacità di essere il luogo dell’incontro dell’uomo con il divino, con l’umano, con la natura, togliendo loro la libertà di vivere la propria essenza. Esse diventano così oggetto di disputa. Da qui nasce la «guerra». Da un costruire e un abitare che non sono un prendersi cura, un rispetto dell’ordine essenziale, ma sono piuttosto illusioni di poter creare nuovi ordini basati su altre relazioni che non permettono che ogni cosa viva liberamente la propria essenza, nasce il desiderio di dominio su ciò che è diverso, sull’altro. Questa è la guerra.
Alessandro Baricco, nella sua opera Omero, Iliade – che ha come argomento la guerra di Troia – ci offre una riflessione sulla guerra. La prima cosa che egli fa notare è che siamo in un mondo in guerra, sebbene il termine «guerra» sia un «termine di comodo» per esprimere qualcosa che storicamente è diverso da ciò che stiamo vivendo oggi. Ma il termine è utile per esprimere ciò che sta accadendo nel mondo: «Certo sono anni in cui una certa orgogliosa barbarie, per millenni collegata all’esperienza della guerra, è ridivenuta esperienza quotidiana. Battaglie, assassini, violenze, torture, decapitazioni, tradimenti. Eroismi, armi, piani strategici, volontariati, ultimatum, proclami. Da qualche profondità che credevamo più sigillata è tornato a galla tutto l’atroce e luminoso armamento che è stato per tempo immemorabile il corredo di un’umanità combattente»[22].
Questo contesto dà tutto il significato alla lettura dell’Iliade. Analizzando l’opera, Baricco scopre due punti di vista: «Due mondi possibili stanno l’uno di fronte all’altro, e ognuno ha le sue ragioni»[23]. L’autore parla di due mondi, che potremmo qualificare come due maniere di vivere la relazione con la quaternità. Un mondo femminile, caratterizzato da una «tenace» ricerca della pace. Non sono solo le donne[24] che forniscono i loro argomenti, ma sono gli eroi stessi che, in lunghe discussioni, come Sheherazade, si servono della parola per ritardare la morte[25].
L’altro mondo ha caratteristiche maschili, guerriere. È il mondo che appare in primo piano nell’Iliade, quando si canta la bellezza di questa guerra (bellezza del dio Ares e della dea Atena, che rappresentano i due aspetti della guerra: quello di competizione e quello strategico), perché ci consente di vedere che «per millenni la guerra è stata, per gli uomini, la circostanza in cui l’intensità – la bellezza – della vita si sprigionava in tutta la sua potenza e verità. Era quasi l’unica possibilità per cambiare il proprio destino, per trovare la verità di se stessi, per assurgere a un’alta consapevolezza etica. Di contro alle anemiche emozioni della vita e alla mediocre statura morale della quotidianità, la guerra rimetteva in movimento il mondo e gettava gli individui al di là dei consueti confini, in un luogo dell’anima che doveva sembrar loro, finalmente, l’approdo di ogni ricerca e desiderio»[26].
L’Iliade parla di questo mondo, della bellezza della guerra, che è centrale nell’esperienza umana, come se non vi fosse altra esperienza possibile che potesse permettere di esistere realmente.
Il problema che i testi esaminati ci presentano può essere riassunto con la parola «guerra», che è un modo per risolvere la tensione tra i due poli, sebbene si tratti di un modo che cerca di superare la tensione distruggendo uno dei due poli.
Questa possibile soluzione ci invita a cercare un modo per mantenere l’equilibrio dei poli in questione, tra l’essenza e l’esistenza, tra l’idea e la realizzazione dell’idea, così come avviene nel vivente e nel vivente spirituale. Anche un albero e un animale sono in tensione tra l’essenza e l’esistenza, ma in questa tensione non interviene la volontà. Un uomo si trova davanti un’infinita varietà di possibilità e deve scegliere o, per dirlo con Heidegger, si trova davanti al dilemma di come accogliere le essenze, di come mettersi in relazione con la «quaternità» in modo tale da portare l’essenza di queste quattro realtà (cielo, terra, divino, mortale) alle cose[27].
A questo punto entra in gioco il terzo elemento del titolo di Heidegger, il «pensare». Pensare all’uomo, pensare al mondo, per essere capaci di abitare e giungere così a essere capaci di costruire[28].
La ricerca di un equilibrio in tensione della città futura
In questo ambito risuonano le visioni di Calvino, di Ferrer, di Baricco, dalle cui proposte nasce l’esortazione, la verità consolatrice che induce a costruire città che accolgano e rispettino la loro essenza.
Nella conferenza su Le città invisibili Calvino afferma: «Il mio libro si apre e si chiude su immagini di città felici che continuamente prendono forma e svaniscono, nascoste nelle città infelici»[29]. Ma non esistono città «chimicamente pure». Non ci sono città felici (che accolgono l’essenza) di fronte a città infelici (che vivono separate dall’essenza). Le città sono mescolate, con la felicità nascosta in mezzo all’infelicità. Per questo le parole finali de Le città invisibili descrivono due modi per superare l’inferno rappresentato dalla città reale: «Due modi ci sono per non soffrirne (di questo inferno). Il primo riesce facile a molti: accettare l’inferno e diventarne parte fino al punto di non vederlo più. Il secondo è rischioso ed esige attenzione e apprendimento continui: cercare e saper riconoscere chi e cosa, in mezzo all’inferno, non è inferno, e farlo durare, dargli spazio»[30].
Ferrer propone di ricostruire: «Che bello sarà il ricostruire!». E il frutto è una città umana: «Che bello, mi nasce una città!», una città «torre», fondata su un «cuore con la fede» (secondo un’altra versione, una città «ponte», che nasce dal «mio cuore con la fede»). L’uomo nato in questa città sarà attento alla «quadratura» di cui parla Heidegger. «In ogni pozzanghera ci sarà un piccolo mare / e in ogni fucina un inventore del sole / e in ogni porta un’iscrizione astrale / e in ogni persona triste un apprendista di Dio». C’è un «annuncio»: le città inumane, destinate a tornare in polvere, «dalla polvere torneranno». Nonostante la situazione delle città fondate sull’odio, Ferrer rafforza infine la speranza e annuncia una città futura fondata a misura d’uomo.
Ma se teniamo conto dell’analisi di Baricco sull’Iliade, non possiamo dimenticare la bellezza della guerra. «Dire e insegnare che la guerra è un inferno e nient’altro, è una menzogna che produrrà un grande danno. Anche se è atroce, dobbiamo ricordare che la guerra è un inferno, ma bello»[31].
E la proposta di Baricco risuona con forza. Senza dimenticare il significato della guerra, orribile, atroce, anche se al tempo stesso affascinante, egli afferma: «Costruire altra bellezza è forse l’unica strada verso una pace vera. […] Sarà una qualche, diversa bellezza, più accecante della sua, e infinitamente più mite»[32]. Il cammino verso la città dell’uomo è possibile solo se siamo capaci di cercare una più grande bellezza. Il pensiero di Heidegger rimane molto astratto; la bellezza di Baricco muove il desiderio verso la specie del bene.
Ma qui dobbiamo ricordare ciò che sant’Agostino insegnava già nel V secolo, usando il sinonimo di «bellezza» per descrivere questa guerra: l’amore. Ne La città di Dio egli parla di due città: una fondata sull’amore verso se stessi, l’altra fondata sull’amore verso Dio. «Due amori dunque diedero origine a due città: alla terrena l’amor di sé fino all’indifferenza per Iddio, alla celeste l’amore a Dio fino all’indifferenza per sé. Quella si gloria di sé, questa nel Signore»[33].
Non si tratta di città separate e indipendenti. Per Agostino, come per Calvino, sono due città che convivono in una tensione che abbraccia tutta la storia[34]. La volontà ferita dal peccato deve lottare, se non vuole soccombere in questo confronto[35]. In questa lotta in cui la volontà risulta decisiva, è fondamentale il bene che risveglia l’appetito e mette in movimento la volontà. Solo una più grande bellezza è capace di superare la bellezza della guerra. Solo un amore più grande è capace di far uscire la città dal recinto dell’amore per se stessa, che è un suicidio.
In questa prospettiva, può essere utile prendere brevemente in considerazione una novella di Laurent Gaudé del 2006, Eldorado, che ci pone al centro della tensione di queste città così come la vive attualmente l’Europa e la condivide il mondo. È incentrata sul problema dell’immigrazione, sul problema dei rifugiati.
Non possiamo fermarci qui a considerare tutta la novella. Basti dire che il protagonista Salvatore Piracci, per vicende esistenziali più che narrative, passa dal pattugliare le coste della Sicilia, per intercettare le barche degli immigrati e impedire loro di entrare in Europa, all’essere lui stesso un emigrante volontario in quel mondo che i suoi perseguitati cercavano di abbandonare ad ogni costo. Dobbiamo notare una caratteristica fondamentale di questo personaggio: egli ha vissuto cercando – ugualmente ad ogni costo – di «scoraggiare» qualunque processo di fuga dalla città invivibile verso la città vivibile, Eldorado (almeno nella speranza che divenga vivibile).
Una serie di incontri gli cambiano la vita. Sono incontri che gli fanno comprendere. «Di fronte a questo giovane (Soleimán) comprendeva che Eldorado esisteva per gli altri e che è nelle loro mani il fatto di non dubitare del loro destino. Essi cercavano di raggiungere paesi dove gli uomini non soffrono la fame e dove la vita è un patto con gli dèi»[36].
L’avventura di Salvatore Piracci è caratterizzata dalla sua decisione di incarnare o di lasciar credere che lui sia l’incarnazione del Dio africano degli emigranti, colui che accompagna nel cammino, colui che veglia, colui che salva. Tanto da dire: «[Soleimán] non temerebbe proprio nulla. Il Dio degli emigranti vegliava su di lui. Grazie a lui, si mostrava sicuro di sé senza vanità e coraggioso senza arroganza»[37].
Ma il Dio degli emigranti non è un salvatore solo per Soleimán, che si sentiva sicuro e coraggioso; lo è anche per Piracci. «Di città in città, di paese in paese, non sarebbe altro che un’ombra che incoraggia gli uomini. […] Solo in questo modo potrebbe continuare ad appartenere al mondo»[38]. Poiché non c’è altro modo per appartenere al mondo.
Conclusione
A questo punto possiamo riprendere, per concludere, l’intenzione di Heidegger: dalla ricerca dell’essenza delle cose proveniva una «esortazione», una «consolazione», una «verità che ci anima». È ciò che abbiamo trovato negli autori presi in considerazione. Questa dev’essere la nostra missione nella città di oggi: essere esortazione, consolazione e motivo di speranza, come il personaggio di Eldorado.
Le città invisibili sono nascoste dentro le città visibili, molte volte invivibili. Città che sono diventate inferno, perché non trovano il senso della loro esistenza, della loro trascendenza. Città dedite alla guerra, alla bellezza della guerra, che è semplicemente un’atroce competizione sportiva. Città che si dissanguano nell’amore per se stesse. Dentro queste città c’è un aspetto che non è inferno: un amore tanto grande che può far sì che le città siano non solo abitabili, ma soprattutto vivibili[39].
Copyright © La Civiltà Cattolica 2018
Riproduzione riservata
***
VISIBLE CITIES AND INVISIBLE CITIES. A reflection that commenced with Italo Calvino
The book Invisible Cities by Italo Calvino offers a starting point for a reflection on the city as an idea and its current reality. The tension between essence and existence, between the idea and the realization of that idea, gives rise to a conflict that the city must overcome in order to be livable. Starting from the reflections of Plato, Saint Augustine, and Heidegger on the ideal city, and from the image of the real city as it appears in literature (Italo Calvino and Horacio Ferrer) we arrive at being able to formulate a message for the city which has been given to us to inhabit, while listening to Alessandro Baricco’s and Laurent Gaudé’s proposals.
***
[1]. Orazio, Epodi II, 1.
[2]. Fray Luis de León ha tradotto in castigliano il poema di Orazio (cfr Fray Luis de León, «Poesías», in Obras completas, Madrid, BAC, 1944, 1447-1694). Riprende l’argomento nell’Oda a la vida retirada (ivi, 1450-1452) e nella poesia Al salir de la cárcel (ivi, 1495). Il tema riappare in A. Fernández de Andrada Epístola moral a Fabio, Madrid, Real Academia Española, 2014, 1-15; in Fray Antonio de Guevara, Menosprecio de corte y alabanza de aldea; nel poema di Luis de Góngora y Argote, «Ándeme yo caliente y ríase la gente», in Id., Obras completas, Madrid, Aguilar, 1956, 289 s.
[3]. Questo argomento appare per la prima volta in Virgilio: «[…] et tumulum facite, et tumulo superaddite carmen: / Daphnis ego in silvis hinc usque ad sidera notus / formosi pecoris custos formosior ipse» (Virgilio, Eclogae, V, 42-44). È stato poi ripreso in ambiente fiorentino dallo scritto di Jacopo Sannazaro, Arcadia. È diventato un tema pittorico con il Guercino (dipinto del 1620 ca.) e Poussin (1637 ca.). Il tema appare in W. Goethe, Viaggio in Italia, e in F. Nietzsche, Umano troppo umano. Un libro per spiriti liberi, II, 2, 295.
[4]. Cfr I. Calvino, Le città invisibili, Milano, Mondadori, 2007.
[5]. Il 29 marzo 1983 Calvino tenne una conferenza in inglese per gli studenti della Graduate Writing Division della Columbia University di New York, pubblicata con il titolo «Italo Calvino on Invisible Cities» (nella rivista Columbia 8 [1983] 37-42). Il testo italiano di quella conferenza è stato pubblicato come Presentazione del libro: I. Calvino, Le città invisibili, Milano, Mondadori, 1993, V-XI. La nostra citazione è a p. IX.
[6]. Nell’ampia opera filosofico-teologica di Erich Przywara, si può vedere lo studio «Filosofia dell’essenza e dell’esistenza», in Analogia entis. Metafisica: la struttura originaria e il ritmo cosmico, Milano, Vita e Pensiero, 1995, 600. Un’applicazione pratica la si può trovare in E. Przywara, L’ idea d’Europa. La «crisi» di ogni politica «cristiana», Trapani, Il Pozzo di Giacobbe, 2013. Cfr anche J. L. Narvaja, «La crisi di ogni politica cristiana. Erich Przywara e l’“idea di Europa”», in Civ. Catt. 2016 I 437-448, in particolare 439.
[7]. I. Calvino, Le città invisibili, cit., VI.
[8] . Ivi, 83.
[9] . Cfr J. L. Narvaja, «La crisi di ogni politica cristiana…», cit., 439.
[10]. E. Przywara, L’idea di Europa…, cit., 71.
[11]. Cfr Platone, Dialoghi, vol. 2, Milano, Mondadori, 2008, 712 ss.
[12]. Etimologicamente, Prometeo significa «colui che comprende prima, che sa prevedere»; Epimeteo, al contrario, «colui che comprende dopo, troppo tardi».
[13]. Platone, Dialoghi, cit., 714.
[14]. M. Heidegger, «Costruire abitare pensare», in Id., Saggi e discorsi, Milano, Mursia, 1976, 96-108.
[15]. Ivi.
[16]. Ivi.
[17]. Ivi.
[18]. Cfr la definizione di Jung: «L’antica filosofia greca pensava secondo formule quaternarie. […] La quaternità è un archetipo, che appare, per così dire, universalmente. Essa è la premessa logica per ogni giudizio di totalità» (C. G. Jung, La simbolica dello spirito, Torino, Einaudi, 1959, 245).
[19]. I. Calvino, Le città invisibili, cit., 164.
[20]. H. Ferrer, Las ciudades.
[21]. Cfr Gen 1,28.
[22]. A. Baricco, Omero, Iliade, Milano, Feltrinelli, 2013, 157.
[23]. Ivi, 158.
[24]. Cfr Omero, Iliade, VI, 254-439. Con linguaggio meno elevato, Aristofane, nella commedia Lisistrata, sviluppa i suoi argomenti contro la guerra attorno a un personaggio femminile. Cfr Aristofane, Le Commedie, a cura di B. Marzullo, Roma, Newton Compton, 2015, 701-793.
[25]. Cfr Omero, Iliade, VII, 345-378.
[26]. A. Baricco, Omero, Iliade, cit., 161.
[27]. Cfr M. Heidegger, «Costruire abitare pensare», cit., 133.
[28]. Cfr ivi, 141.
[29]. I. Calvino, Le città invisibili, cit., X.
[30]. Ivi, 164.
[31]. A. Baricco, Omero, Iliade, cit., 162.
[32]. Ivi, 163.
[33]. Agostino, s., La città di Dio, XIV, 28, II.
[34]. Cfr Mt 13,39.
[35]. Cfr Agostino, s., Commento di alcune questioni tratte dalla Lettera ai Romani, Milano, Paoline, 1993, 13-18.
[36]. L. Gaudé, Eldorado, Buenos Aires, 2007, 228.
[37]. Ivi, 229.
[38]. Ivi, 230 s.
[39]. La riflessione che abbiamo presentato in queste pagine riprende una conferenza tenuta agli studenti di Filosofia presso le facoltà di Filosofia e Teologia di San Miguel, a Buenos Aires, l’11 novembre 2016.
*******