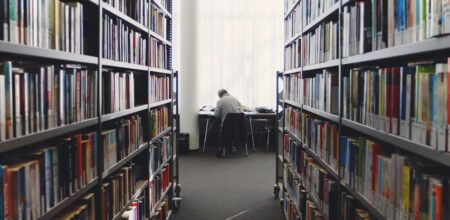|
|
Il beato Antonio Rosmini (Rovereto 1797 – Stresa 1855) è stato uno dei maggiori pensatori italiani di tutti i tempi, e i suoi interessi spaziarono nei più diversi ambiti della filosofia, non esclusa la politica, alla quale dedicò scritti di notevole importanza. Tra questi, vanno ricordati lo Statuto romano, la Costituente per il regno dell’Alta Italia, la Costituzione secondo la giustizia sociale e il Saggio sull’unità d’Italia, quattro testi di recente raccolti a cura di Ludovico Maria Gadaleta nel 36° volume dell’Edizione nazionale e critica delle opere rosminiane.
A partire dai moti che scossero l’Italia nel biennio 1820-21, Rosmini avvertì un forte interesse per le vicende del nostro Paese, e sempre più chiara si fece in lui la convinzione dell’utilità di un’elaborazione pratica delle sue idee politiche. Egli ritenne la Carta costituzionale di una nazione «l’opera più grande che si possa mai fare: l’opera la più importante; quella che dee fare ordine a tutta intera la nazione, che dandole l’organismo, le dà altresì l’unità, la vita, l’azione, l’esistenza. Una costituzione si decreta perché sia perpetua, ché una nazione non dovrebbe morir giammai».
Proprio per questo, nel pensare a una Carta costituzionale italiana, Rosmini non volle rifarsi a modelli provenienti dall’estero, in particolare dalla Francia, ove aveva visto realizzarsi una sorta di dispotismo popolare estraneo alla sua visione dell’uomo e della società e foriero di gravi errori e pericoli. Ai suoi occhi il dispotismo si presenta come un «veleno mortalissimo», contro il quale è necessario adottare efficaci contromisure atte a garantire la libertà. Questa, in particolare, deve riguardare la Chiesa, perché, come ha affermato Giorgio Campanini, «la presenza di una società religiosa […] autonoma ed originaria è una garanzia necessaria per la stessa società civile, soprattutto come freno al dispotismo familiare e statuale».
Evitare l’instaurazione di un regime dispotico significa salvaguardare la persona e la sua inalienabile dignità. Non casualmente Rosmini definisce la persona «diritto sussistente», autentico e intangibile fondamento della vita associata. A tale proposito, risultano particolarmente interessanti queste considerazioni di Mario Cioffi: «Il primato della persona, il suo valore e la sua vocazione alla libertà riportano al tema proprio delle moderne dottrine costituzionali, l’integrazione dell’individuo nel sociale. Rosmini vuole uno Stato di diritto ma soprattutto di giustizia, che riconosca la legge morale come la legge stessa di verità, nel quale la persona attua la sua libertà nel diritto e nella giustizia, e l’individuo e lo Stato sono ugualmente sottoposti alla stessa unica legge morale».
Un altro aspetto importante del personalismo rosminiano è quello legato all’affermazione della libertà economica: Rosmini, temendo l’indebito sconfinamento del potere dello Stato nel campo proprio degli individui e dei loro diritti, stabilisce la tutela e l’inviolabilità della proprietà, da lui considerata un elemento strettamente connesso con la persona. Ispirandosi a queste certezze fondamentali, egli redasse i suoi progetti di Costituzione, che sono, come asserisce Gadaleta, «forme diverse di un unico, compiuto e lucido disegno politico, volto da una parte a inscrivere nella carta costituzionale i principii già presenti nella società naturale e, al contempo, a far sì che la nuova costituzione plasmi i cittadini nel senso di una maggior adesione a tali valori preesistenti e indefettibili: appunto, all’originaria giustizia sociale».
ANTONIO ROSMINI
Progetti di Costituzione
Roma, Città Nuova, 2017, 504, € 58,00.