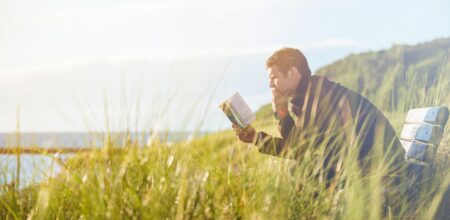|
|
Antonio Rosmini (1797-1855) è indubbiamente uno dei più prolifici interpreti del genere letterario e comunicativo epistolare dell’Ottocento. Lo testimoniano le sue 8.470 lettere, pubblicate in 13 volumi a partire dal 1887 dalla Tipografia Giovanni Pane di Casale Monferrato. E parte di questo vasto oceano resta ancora inesplorato: il rosminiano Cirillo Bergamaschi riteneva di aver individuato i riscontri di almeno 9.045 lettere dell’abate roveretano; altre fonti parlano di 11.000 missive.
Secondo Stefania Zanardi, «le lettere di Rosmini sono un aspetto fondamentale della sua produzione e la loro lettura costituisce un aspetto imprescindibile per la ricostruzione del percorso biografico e intellettuale del filosofo» (Rosmini Studies, 3/2016, 48).
Nelle lettere indirizzate agli esponenti di spicco della vita ecclesiale, politica e culturale della prima metà dell’Ottocento, ritroviamo infatti riflesso e rivelato, come in uno specchio dell’anima, il Rosmini teologo, filosofo, pedagogo, riformatore politico, giurista, mentre nell’epistolario «ascetico» si impone all’attenzione il direttore spirituale.
Ma che importanza possono avere in questo contesto le lettere indirizzate ai propri familiari? Sembra chiederselo anche Ludovico Maria Gadaleta, uno dei curatori di questo volume: «Allo studioso, il contenuto del carteggio può apparire di poca sostanza: non vi si tratta dei temi della “grande storia” se non di passaggio e, al massimo, permette solo di ricostruire un po’ di cronaca spicciola di quel “mondo piccolo” roveretano e trentino in cui si muovono i protagonisti» (p. CXXVII).
È proprio in questo contesto alla periferia dell’Impero e della storia che Antonio si forma umanamente, spiritualmente e culturalmente, in un percorso che lo porta gradualmente a diventare una figura di primo piano della storia della Chiesa, del Risorgimento italiano e del pensiero europeo.
Il carteggio, raccolto nei due tomi, arricchiti da note, profili biografici, alberi genealogici e indici, comprende la corposa corrispondenza (815 lettere) tra Antonio e i suoi più stretti familiari: il padre Pietro Modesto, la madre Giovanna Formenti, lo zio Ambrogio, la sorella Gioseffa Margherita, il fratello minore Giuseppe Maria e la moglie di quest’ultimo, Adelaide Cristiani.
Nelle lettere sembrano prevalere preoccupazioni ed esigenze quotidiane comuni a qualsiasi famiglia, ma a una lettura più attenta vi si ritrovano significative conferme di una costante coerenza tra vita vissuta e valori proclamati.
Le lettere più problematiche, a volte drammatiche, hanno come protagonista o destinatario il fratello minore Giuseppe, roso dall’invidia per il ruolo di primogenito maschio che assegna ad Antonio i quattro sesti dell’eredità e ne fa il capofamiglia alla morte del padre. Rosmini si dimostra a un tempo paziente e risoluto, mettendo in pratica nel rapporto con l’irrequieto fratello quei princìpi educativi che ha delineato nelle opere pedagogiche.
Nella corrispondenza con la sorella Gioseffa Margherita, che nel 1824 entra tra le Suore della Carità, fondate a Verona nel 1808 da Maddalena di Canossa (canonizzata da Giovanni Paolo II il 2 ottobre 1988), emerge la consonanza tra due anime spiritualmente affini, con Antonio, guida spirituale, che insiste sull’importanza fondamentale della preghiera: «L’orazione è lo strumento universale per mandare in effetto ogni lecito e vantaggioso nostro disegno. L’orazione, come il calore del sole, fa rinverdire e fiorire e fruttare tutte le piante».
Se il padre è soprattutto il referente per i problemi concreti (ad esempio, le spese sostenute nel periodo universitario a Padova) e lo zio Ambrogio, artista e bibliofilo, è l’interlocutore privilegiato sul piano culturale, è con la madre che Rosmini dialoga nel momento delle scelte decisive della propria vita. È lei a chiedergli di valutare attentamente le conseguenze e le responsabilità che si assume intraprendendo la via del sacerdozio. Quando, però, la mamma invoca in maniera struggente il ritorno a casa del figlio, perché prenda le redini della famiglia dopo la morte del padre, Antonio le ricorda che, pur amandola con tutto il cuore, ha il dovere di ubbidire anzitutto alla volontà di Dio, secondo quel principio – «principio di passività» – che ha posto come bussola della propria vita e che consiste nel fare silenzio dentro e fuori di sé per ascoltare unicamente la voce di Dio.
Quella che emerge dalla corrispondenza familiare è in sostanza un’autobiografia che ci aiuta a scoprire il Rosmini meno conosciuto, intimo, segreto. E perfino inatteso nella sua tenerezza. Vale ancora oggi quanto si legge nella Prefazione dell’Epistolario completo (Casale Monferrato, Pane, 1887, vol. 1): «Chiunque si farà a leggere con animo puro da pregiudizi e da passione le lettere che gli mettiamo innanzi, siamo certi che ne trarrà a sé infinito giovamento, e imparerà a conoscere ammirando nell’Uomo che le scrisse il gran dono che la Provvidenza ha fatto a un secolo che non s’è peranco mostrato degno d’intenderlo» (p. IX).