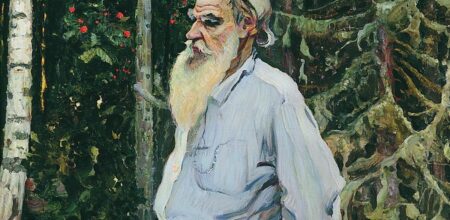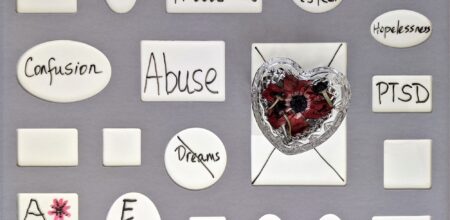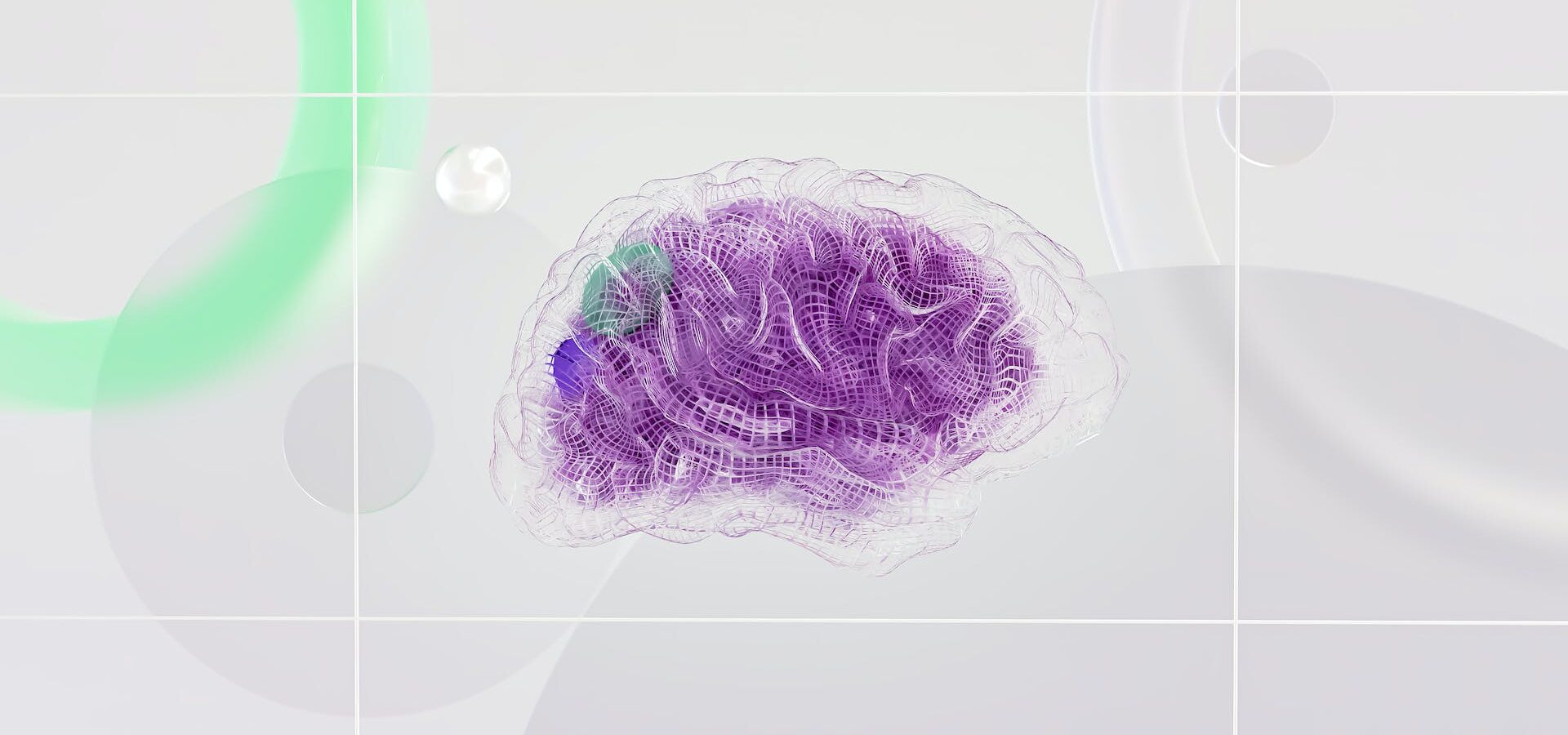
P. Paolo Benanti è un francescano del Terzo Ordine Regolare, professore di Teologia morale presso la Pontificia Università Gregoriana. Nella sua attività di ricerca, insegnamento e divulgazione, si occupa di etica, bioetica ed etica delle tecnologie. In particolare – scrive nel suo sito personale – i suoi studi «si focalizzano sulla gestione dell’innovazione: internet e l’impatto del Digital Age, le biotecnologie per il miglioramento umano e la biosicurezza, le neuroscienze e le neurotecnologie»[1]. Dotato di una grande capacità comunicativa e pedagogica, p. Benanti è presente frequentemente nei media e collabora con varie istituzioni accademiche, governative e internazionali. Recentemente è stato nominato dal Segretario generale delle Nazioni Unite membro dello High-Level Advisory Body on Artificial Intelligence[2]. P. Benanti ha gentilmente accettato di rispondere alle nostre domande, e gli siamo grati per la disponibilità dimostrata. Nelle sue risposte, ci illumina su molte questioni che sono all’ordine del giorno e che definiranno il futuro dell’umanità.
P. Benanti, Lei è stato recentemente nominato dal Segretario generale delle Nazioni Unite, António Guterres, membro dello «High-Level Advisory Body on Artificial Intelligence» dell’Onu. Troviamo interessante che l’unico italiano di questo gruppo sia un religioso. Vuol dire che la Chiesa italiana è più avanti nella riflessione sul tema, nel nostro Paese?
Lo sviluppo rapido e globale delle intelligenze artificiali ha colto la maggior parte delle persone di sorpresa. Questo scenario di rapido cambiamento, di fatto, è un processo interdisciplinare che interroga competenze e discipline diverse, mettendo sul tavolo numerosi fattori di crisi e nuovi stimoli. Il primo elemento da sottolineare è proprio questo: il fatto che le intelligenze artificiali siano una grande sfida per tutti. In questo generale fronte di transizione, appartenere a una istituzione, la Chiesa, e a un Ordine, i francescani, che hanno attraversato altre grandi transizioni sociali e culturali, aiuta a intravedere nei diversi elementi di mutazione alcune istanze di continuità e altre di novità. Penso che questa congiuntura storica, con il mutamento di tanti elementi sinora consolidati, possa portare anche allo sviluppo di nuovi dialoghi tra la Chiesa e il resto del mondo.
Ovviamente, la sua nomina all’Onu non arriva dal nulla. Lei è anche membro della Pontificia Accademia per la Vita, con mandato per il mondo dell’intelligenza artificiale; ed è stato nominato dal governo italiano tra gli esperti che hanno il compito di elaborare la strategia nazionale sull’intelligenza artificiale. Ci può riassumere il percorso accademico e intellettuale che l’ha portata ad assumere
Contenuto riservato agli abbonati
Vuoi continuare a leggere questo contenuto?
Clicca quioppure
Acquista il quaderno cartaceoAbbonati
Per leggere questo contenuto devi essere abbonato a La Civiltà Cattolica. Scegli subito tra i nostri abbonamenti quello che fa al caso tuo.
Scegli l'abbonamento