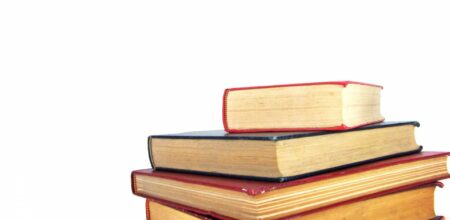|
|
Sono stati recentemente presentati a Roma i risultati di una ricerca sociologica internazionale condotta per capire qual è l’idea dei giovani circa il loro futuro sia dal punto di vista personale sia come prospettive familiari, locali e nazionali dei Paesi in cui vivono. L’indagine è stata compiuta su un ampio campione di giovani tra i 18 e i 30 anni nel periodo tra marzo e luglio 2018 e ha riguardato giovani di quattro Paesi europei: Italia, Germania, Polonia e Russia. Per quanto concerne l’Italia, l’istituto di riferimento è stato l’Eurispes (Istituto di Studi Politici Economici e Sociali)1, che ha diffuso online i risultati della ricerca e gli altri materiali di cui ci siamo serviti per questo articolo2.
Il metodo di ricerca
Qualche cenno sul campione prescelto per l’indagine e sulla metodologia seguita. L’indagine è stata condotta su 1.536 giovani che vivono nei quattro Paesi indicati. Sono state intervistate 384 persone per ogni Stato. Secondo i ricercatori, la dimensione del campione garantisce che i risultati siano rappresentativi di ciascuno dei Paesi prescelti3. La tecnica del sondaggio è consistita nell’utilizzare un metodo combinato tra l’indagine classica (condotta faccia a faccia) e online.
I quattro Stati sono stati scelti per motivi che li rendono significativi anche per le loro differenti vicende storiche, pur in una certa omogeneità culturale. Gli eventi storici hanno certamente segnato anche i loro attuali giovani. La ricerca ne presenta la diversità, dividendoli in: a) «Paesi nei quali non ci sono mai stati dei cambiamenti di fondo nella sfera economica e politica; b) Paesi nei quali c’è stata un’unificazione di sistemi economici e politici fondamentalmente diversi; c) Paesi nei quali ci sono stati cambiamenti segnati come dal moto del pendolo nelle strutture economiche e politiche. In questi Stati la cultura cristiana è rappresentata dalle sue componenti principali: cattolica, protestante e ortodossa» (p. 4).
Più in particolare, la Russia nel XX secolo ha vissuto profonde trasformazioni storiche, che hanno determinato in ampia misura anche lo sviluppo mondiale. In pratica, durante l’Impero e fino agli inizi di questo secolo essa non ha avuto esperienza di vera democrazia: si è passati da un sistema nel quale lo zar era il centro della vita politica a un sistema monopartitico e di amministrazione pubblica socialista. Si è poi giunti a un sistema che riconosce i princìpi della democrazia e li coniuga con la costruzione di una Repubblica presidenziale. Nella sfera religiosa, si è passati dall’Ortodossia, riconosciuta come religione di Stato, al completo rifiuto di essa e, dopo il crollo dell’Urss, al ritorno della religione a un ruolo attivo nella vita socio-politica del Paese.
L’Italia è uno Stato agricolo-industriale sviluppato, con una storia a economia di mercato, nel quale nei due secoli passati non vi è stato alcun cambiamento da un sistema di economia di mercato a un altro, e dove l’autorità del cattolicesimo non è mai stata messa in discussione. La sfera economica è caratterizzata da forti differenze regionali in termini di reddito e di industrializzazione. Anche l’economia sommersa svolge un ruolo importante nello sviluppo del Paese.
La Germania dal 1949 al 1990 è stata divisa in due Stati: la Repubblica Federale di Germania e la Repubblica Democratica Tedesca (Ddr). La prima ha mantenuto l’organizzazione di mercato della produzione e il sistema di valori della società protestante-cattolica, mentre la Ddr ha adottato il sistema economico dell’economia socialista e i valori corrispondenti. Dopo l’unificazione del 1990, la parte orientale è stata praticamente assorbita dal sistema occidentale a economia di mercato. La ex Ddr ha ora rianimato ufficialmente il protestantesimo, già prevalente prima dell’unificazione.
La Polonia, prima della Seconda guerra mondiale, era uno Stato con un’economia di mercato, con una forte influenza del cattolicesimo nella vita pubblica. Dopo la Seconda guerra mondiale l’economia è diventata socialista e il ruolo della religione non è stato ufficialmente né riconosciuto né sostenuto. Dopo il crollo dell’Unione Sovietica e del mondo socialista si è tornati al sistema precedente di economia di mercato e la Chiesa cattolica ha ripreso a svolgere un ruolo attivo nella vita sociale.
«I valori della vita» dei giovani
Ai giovani intervistati è stata indicata una serie di 25 «valori di vita», prendendo poi in considerazione solo le risposte sui valori che essi hanno indicato come «molto importanti» o «importanti». Così si sono messi in evidenza i valori sui quali i giovani concentrano la loro attenzione e in base ai quali è probabile che agiranno in futuro. Le percentuali segnalate sotto riguardano la quota di giovani che hanno indicato il valore corrispondente come importante. La struttura generale degli orientamenti dei valori risulta abbastanza omogenea nei quattro Paesi considerati, ma con differenze specifiche.
La «salute» risulta al primo posto in Italia (97,8%), Polonia (98%) e Russia (95%); in Germania la percentuale scende all’86,1%, mentre il primo posto tocca al valore «amici». L’«istruzione» è al primo posto in Italia (96,4%), mentre negli altri Paesi è stata indicata come importante in una percentuale che oscilla tra l’81,2% e l’88% delle risposte.
Volendo dare delle indicazioni generali su alcuni dei punti significativi e degni di interesse, è bene sottolineare, ad esempio, che il valore «figli» è piuttosto basso nei gruppi di età più avanzata: non più del 70% in ciascun Paese, dato confermato dai bassi tassi di fertilità esistenti oggi in tutti i Paesi. È quindi un valore giudicato meno importante degli «amici», del «tempo libero» e dello «svago».
I valori «indipendenza personale» e «libertà» sono stati giudicati importanti tra l’80 e il 95% delle risposte dei giovani, cosa che evidenzia il desiderio di evitare il controllo dei genitori. Il desiderio di indipendenza cresce in proporzione all’età.
La «religione» risulta il valore più basso nella classifica dei valori (tra il 36,9 e il 32,8% in tutti i Paesi). Il calo di religiosità fra i giovani inoltre non è collegato alla confessione religiosa. Si tratta infatti di Paesi nei quali sono presenti le principali confessioni cristiane, ma con dati sostanzialmente simili. Gli ultimi posti della classifica, dopo la religione, sono generalmente occupati da «patriottismo», «bellezza», «affari» e «politica».
L’importanza del «lavoro» e del «denaro» è ovviamente più alta nei Paesi in cui i giovani incontrano maggiori difficoltà per l’occupazione o per una retribuzione decente: il lavoro è prezioso per il 92,4% degli intervistati in Italia, per l’89,1% in Russia, per l’87,5% in Polonia, ma solo per il 70,7% in Germania.
Il «patriottismo» non suscita un particolare interesse tra i giovani. In Russia «patriottismo», «politica» e «religione» sono risultati agli ultimi posti nella classifica dei valori, nonostante il grande sforzo su questi argomenti compiuto dai media e dalla Chiesa nel Paese.
La Russia presenta alcuni aspetti specifici rispetto agli altri Stati, quali il fallimento di valori come la «democrazia» (solo il 58%), mentre negli altri Paesi essa è pari almeno all’80%, e in Italia è del 91,1%. Appaiono anche una maggiore importanza data agli aspetti materiali della vita e un certo desiderio di isolamento nella vita personale. Minore importanza viene attribuita in Russia anche ai valori «amici» e «sesso», cosa che in genere non è tipica per questa fascia di età. Così pure minore importanza è attribuita al valore «seguire solidi princìpi». Il divario tra Russia e Italia su questo aspetto è superiore al 25%. Si mostra invece un maggiore interesse per gli aspetti materiali della vita e per il benessere.
La fondamentale somiglianza nella struttura dei valori indica l’appartenenza dei giovani di questi quattro Stati a una comune cultura europea, ma appaiono anche le differenze specifiche di ogni nazione e le specificità della vita sociale.
Lo stato emotivo dei giovani nel 2018 e la pianificazione familiare
Se si suddivide lo stato emotivo dei giovani nelle tre categorie «negativo», «incerto» o «positivo», si può pensare che un costante umore negativo induca la popolazione ad abbandonare certe attività e a inibire lo sviluppo non solo individuale, ma anche della società. I giovani con questo stato d’animo non saranno cioè promotori di sviluppo. Viceversa, gli stati d’animo positivi sono giudicati altrettanto contagiosi di quelli negativi: le emozioni di gioia e felicità, moltiplicandosi, possono diventare la base dell’entusiasmo pubblico.
In Italia, nel 2018 ha avuto emozioni positive il 55,5% dei giovani; il 43,4% ha vissuto situazioni emotive di carattere negativo; e solo l’1,2% ha sperimentato l’incertezza. In Germania, dominano le emozioni negative (43,8%, tra le quali indifferenza, mestizia, tristezza); il 35,4% dei giovani ha emozioni positive; e il 5,7% vive l’incertezza. In Polonia, prevale lo stato d’animo positivo: il 48,7% ha emozioni positive; il 31,2% sperimenta emozioni negative; e il 20,1% è in uno stato di incertezza. In Russia, i giovani sono divisi in tre gruppi quasi uguali: il 37,3% ha vissuto stati d’animo negativi; il 30,1% un umore con caratteristiche positive; e il 32,6% stati d’animo di incertezza.
Circa gli orientamenti riproduttivi e la pianificazione familiare, la creazione di una famiglia e la nascita dei figli, si evidenzia quanto sia importante questo valore per l’attuale generazione e per l’intera società. Il numero previsto (atteso) di figli è inferiore a quello ideale, come risulta dai sondaggi in tutti i Paesi. Il maggior numero di figli si trova nei piani concreti di russi e italiani, pari rispettivamente a una media di 1,64 e 1,74 figli. È da notare che in tutti i Paesi considerati i tassi di fertilità in relazione al numero previsto di figli (da 1,28 a 1,74 bambini in media) in ogni caso non raggiungono mai il livello richiesto per la semplice riproduzione della popolazione, in modo cioè che essa non diminuisca. Questo fa prevedere che, per almeno un decennio, la popolazione originaria continuerà a ridursi, aprendo spazi per i migranti, specialmente nell’ambito dell’occupazione. Cosa che però non è ancora oggetto di un serio dibattito pubblico in questi Paesi.
La crescita dei sistemi riproduttivi è fortemente influenzata dal senso di fiducia nel futuro. Il confronto tra le risposte sull’essere fiduciosi o incerti circa il proprio futuro rivela una differenza significativa negli orientamenti. Ciò indica che l’aumento del tasso di natalità è possibile non solo con l’aiuto di sostegni finanziari o di altro tipo da parte degli Stati, ma anche se si modificheranno le opinioni dei giovani sulla possibilità di mobilità sociale, cioè con previsioni più ottimistiche circa le pratiche reali di successo dei giovani nella società.
È bene ricordare che l’orientamento verso un basso livello di nascite non implica che i giovani abbandonino l’idea di una vita familiare, «la quale invece è pienamente accolta e inserita nella loro struttura di valori, dove il valore della famiglia è significativamente più alto del valore dei figli» (p. 10). Gli oppositori alla creazione di un’unione familiare sono in genere intorno al 10,5%. Il minimo numero di contrari alla vita di famiglia si riscontra tra i tedeschi (3,9%), mentre gli italiani (82,2%) sono i più orientati alla costituzione di una famiglia.
Gli orizzonti della pianificazione per il futuro
1) La durata della vita. Le persone definiscono la durata dei loro piani di vita in modo diverso. Qualcuno progetta il futuro per un anno, qualcuno per 5 o 10 anni, e qualcuno vive alla giornata. Evidentemente tutto dipende anche dalle condizioni in cui una persona si trova concretamente. L’ambiente pubblico, la possibilità di carriera e di crescita personale, la presenza di valori stabili nella società, una visione del futuro chiaramente delineata nei suoi elementi principali sono fattori che contribuiscono a formare e a precisare l’ampiezza di questo orizzonte.
In base ai risultati ottenuti, in tutti i Paesi considerati i giovani presentano un orizzonte di pianificazione sociale della propria vita per un periodo medio da 5 a 8 anni, che i sociologi considerano un breve periodo. I giovani non vedono la possibilità di costruire piani a lungo termine, ma neppure sono orientati a vivere alla giornata.
Elementi importanti per pianificare a lungo termine l’orizzonte di vita sono costituiti dall’aspettativa di vita, ma anche della lunghezza di una vita sana. Secondo i dati Eurostat, per il 2016 l’aspettativa di vita media per i polacchi era stimata in 78 anni, per i tedeschi in 81 anni, per gli italiani in 83,4: dati confermati dai risultati della ricerca. Il sondaggio tra i giovani russi sulla loro aspettativa di vita, pari a 68,8 anni, inferiore di quasi 4 anni rispetto ai dati delle statistiche ufficiali, conferma la loro convinzione che dovranno compiere maggiori sforzi per raggiungere i loro obiettivi rispetto all’attuale generazione di persone attive, e che quindi le loro risorse fisiche saranno consumate più rapidamente. Chiedendo invece ai giovani quale sia l’età limite per svolgere ancora in buone condizioni l’attività fisica e mentale, le stime dei giovani indicano 66,6 anni in Italia, 61,2 in Germania, 51,1 in Polonia, 56,2 in Russia. Queste stime indicano livelli sensibilmente inferiori a quelli forniti dalla medicina moderna: 83,4 anni per l’Italia, 81 per la Germania, 78 per la Polonia, 72,7 per la Russia.
2) La mobilità sociale. In una prospettiva di 10-15 anni, i giovani dei quattro Paesi credono che in futuro avranno l’opportunità di diventare più sicuri dal punto di vista finanziario e di vivere in un Paese più potente e rispettato. Tutte le valutazioni evidenziano una prospettiva positiva. Gli italiani e i polacchi si collocano ai livelli più alti sia nelle situazioni attuali sia nella prospettiva di 10-15 anni futuri, ma i giovani italiani sono sicuri di compiere i progressi maggiori sui gradini della scala sociale. L’ottimismo sociale si riscontra del resto nei giovani di tutti i Paesi. «L’autovalutazione delle prospettive della giovane generazione di Russia, Polonia, Germania e Italia mostra un focus sulla mobilità sociale verticale» (p. 12). Questo fa migliorare anche la posizione del proprio Paese nella competizione mondiale.
Il fattore «fiducia nel futuro» gioca un ruolo cruciale. La valutazione «fiducioso/insicuro rispetto al futuro» varia in modo significativo nei vari Paesi. Le persone fiduciose nel loro futuro hanno dimostrato indici iniziali più alti e maggiori avanzamenti nella scala sociale. L’unica eccezione è l’Italia, dove i giovani privi di fiducia nel futuro, anche se valutano le loro posizioni inferiori a quelle di coloro che hanno fiducia nel loro futuro, credono però che il loro passo in avanti sarà grande.
Secondo la ricerca, la Russia è l’unico Paese nel quale la valutazione del potere e della forza dello Stato e le prospettive per la sua promozione mondiale sono più alte delle dinamiche sociali personali. Essa cioè conquisterà posizioni migliori sulla scena mondiale. La Germania in un futuro di 10-15 anni, secondo i suoi giovani, mostrerà un lieve peggioramento della sua posizione, ma il suo sviluppo economico continuerà a renderlo uno dei motori dello sviluppo mondiale. I giovani italiani e polacchi da questo punto di vista rappresentano, nella situazione attuale e tra 10-15 anni, un livello di valore medio.
Interessanti sono le differenze di genere. In Germania e in Russia le ragazze sono molto ottimiste. In Italia e in Polonia sono più ottimisti i giovani maschi. Gli autori della ricerca ritengono che il grosso della gioventù, nel suo complesso, sia carico di un buon livello di ottimismo.
3) Attività civile e politica. La capacità di interagire con le autorità e di poter influenzare il processo decisionale riflette il livello di democrazia di uno Stato, ma indica anche il livello di fiducia nelle autorità e il coinvolgimento della popolazione nel processo di gestione nei vari livelli decisionali.
La capacità di influenzare la politica delle autorità consente di pianificare il proprio futuro in un ambiente adeguato e favorevole. Secondo il sondaggio, più alto è il livello dell’istituzione pubblica, minore è il numero di giovani che pensa di poter influenzare il processo decisionale. I giovani polacchi e tedeschi sono quelli convinti di avere le maggiori possibilità di influenzare la politica dello Stato nel suo insieme, come pure quella delle autorità regionali e così via. I giovani in Italia pensano di poter influenzare la politica delle autorità regionali e comunali.
Circa la possibilità di influenzare la politica dello Stato, le opinioni sono ugualmente divise tra «sì» e «no». I giovani in Russia pensano di non aver influenza sulla politica delle autorità a nessun livello. Il dato corrisponde alla scarsa importanza, per i russi, dei valori della democrazia e della politica. Questo rischia di minare la credibilità delle autorità.
Può essere interessante, per definire il grado di maturità della società civile, valutare la partecipazione dei giovani a determinate iniziative nel loro Paese. Ad esempio, in un Paese in cui il ruolo della Chiesa e della religione è forte, le istituzioni religiose sono attivamente coinvolte nella società e la partecipazione alle attività religiose è in aumento, come in Italia. Lo stesso vale per le attività di volontariato (anche in favore dei più poveri), che coinvolgono i giovani in Germania (35,6%) e in Italia (36,8%), mentre in Russia e in Polonia la percentuale di giovani che partecipano a questo tipo di attività si riduce alla metà: 18,3% in Russia e 17,2% in Polonia. Ciò indica una significativa differenza culturale, la distanza dal potere e la tendenza dei giovani a chiudersi in se stessi per dedicarsi a risolvere i problemi personali o quelli dell’ambiente immediato che li circonda. Solo il 28,8% dei giovani russi ha dichiarato di aver partecipato alle elezioni nazionali; lo stesso avviene in Polonia, dove però la partecipazione è più alta di un 10%. Ma i giovani di tutti e quattro gli Stati esprimono un uguale apprezzamento per la partecipazione personale alle attività di svago e del tempo libero.
In Germania e in Italia si nota un coinvolgimento dei giovani nella vita politica – attraverso la partecipazione alle elezioni ai vari gradi, ai referendum, e a manifestazioni – maggiore rispetto a quello dei polacchi e dei russi.
Se si tratta di valutare il successo della vita, il criterio più importante per i giovani è quello dell’autorealizzazione dell’individuo, riassunto dall’espressone «l’opportunità di vivere cose interessanti»; seguono i criteri dell’«amicizia» e della «comunicazione» e quello della «salute». I giovani intervistati di tutti i Paesi ritengono di dover fare affidamento sulle proprie forze, formulando piani da realizzare da soli o con l’aiuto di qualcuno. Tutti rivelano di voler raggiungere i propri obiettivi in modo indipendente. Quelli che mostrano il maggior livello di affidamento su se stessi sono i giovani italiani.
Osservazioni conclusive
La ricerca, di cui abbiamo presentato alcuni dei risultati più interessanti, è stata condotta con l’idea di delineare il futuro come lo immaginano i giovani, nel presupposto che essi costituiscano il gruppo che meglio percepisce l’atmosfera sociale e la direzione dello sviluppo del Paese in cui vivono.
Appare chiaro che l’orizzonte sociale della pianificazione della vita dei giovani è progettato per il medio termine, ma in ritardo rispetto all’orizzonte della pianificazione biologica, cosa comprensibile in quanto viviamo un’epoca di rapidi cambiamenti, mai vissuta in passato e che i giovani percepiscono meglio degli adulti, perché ne fanno già parte come protagonisti, benché spesso inconsapevoli e non sempre attivi.
Questa constatazione impoverisce il panorama del progresso futuro, ma significa anche che i giovani non vivono alla giornata. Essi percepiscono che molte cose studiate con fatica dai loro genitori o nonni oggi non servono più o sono insufficienti, e questo non consente di costruire piani a più lungo termine, cosa che però, anche in passato, era proprio delle età più mature. Un processo di sviluppo più sostenibile e meno improvvisato e devastante per l’ambiente, unito a un quadro internazionale più stabile e con maggiore sicurezza, può contribuire a dilatare e allungare l’estensione dell’orizzonte delle previsioni e dei piani futuri.
Nei quattro Paesi prescelti per l’indagine risultano orientamenti di valore assai simili, che parlano delle radici cristiane comuni nella cultura europea e della diffusione di valori universali nei giovani dell’Europa. A questi si aggiungono le specificità nazionali della vita pubblica e della storia nei differenti Paesi.
I giovani sembrano manifestare un ottimismo sociale più marcato di quello degli adulti, che da sempre confrontano il presente con un passato che appare loro più solido e confortevole delle incertezze presenti. In questo senso, la ricerca mostra un quadro migliore di quello narrato ordinariamente dai media, sempre attenti soprattutto alle disfunzioni e agli insuccessi. Se i giovani mostrano ottimismo circa il dinamismo della scala sociale, questo può essere anche un segno del funzionamento dei cosiddetti «ascensori sociali» nella comunità, se non già effettivo, almeno sperato dalla gioventù europea.
Copyright © La Civiltà Cattolica 2019
Riproduzione riservata
***
1. L’iniziativa è stata promossa da tre studiose russe: Svetlana Varlamova ed Elena Kayshauri, del Centro Federale per la Sociologia Teorica e Applicata-Fctas dell’Accademia delle Scienze di Russia; e Anna Doroshina, del Dipartimento di Sociologia dell’Università «D. I. Mendeleev» di Mosca. In Germania, l’organismo di riferimento è stato l’Istituto Iwak dell’università «Goethe»di Francoforte.
2. I numeri citati tra parentesi nell’articolo si riferiscono alle pagine del testo diffuso online dall’Eurispes.
3. Poiché la popolazione di ogni Stato considerato è superiore a 100.000 persone, il calcolo del campione ha presentato una probabilità di attendibilità pari a 0,95, e un errore di campionamento pari a ±5%.