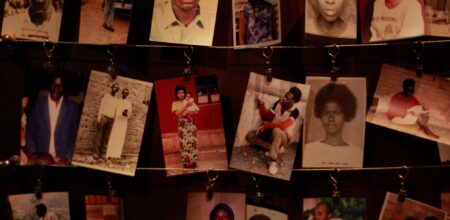Nell’omelia che, il 18 aprile 2005, il cardinale Joseph Ratzinger fece durante la Missa pro eligendo Romano Pontifice[1] vi era una chiara descrizione della situazione dottrinale presente nella Chiesa negli anni precedenti. Egli richiamò l’attenzione sul problema del relativismo e delineò il cammino che la Chiesa avrebbe dovuto percorrere per non lasciarsi guidare dalle ideologie, ma per rimanere docile alla guida dello Spirito.
Basandosi sul brano di Ef 4,11-16, egli fece notare che «avere una fede chiara, secondo il Credo della Chiesa, viene spesso etichettato come fondamentalismo. Mentre il relativismo, cioè il lasciarsi trasportare “qua e là da qualsiasi vento di dottrina”, appare come l’unico atteggiamento all’altezza dei tempi odierni». Il rovescio della medaglia di questa «fede chiara» porta a uno stato in cui «si va costituendo una dittatura del relativismo che non riconosce nulla come definitivo e che lascia come ultima misura solo il proprio io e le sue voglie».
Il Cardinale parla dunque di una «dittatura del relativismo» centrata sull’«io» e sui suoi «desideri»[2]. Per soddisfare questi desideri e per permettere che l’«io» rimanga al centro occorre trovare una «ideologia» di sostegno, arrivando così a lasciarsi trascinare dalle «correnti ideologiche» e dalle «opinioni alla moda». E Ratzinger lamenta che la fedeltà al deposito della fede sia tacciata di «fondamentalismo».
Nel contesto di queste affermazioni, dobbiamo chiederci che cosa intendesse il cardinale Ratzinger con «relativismo» e come, successivamente, Benedetto XVI abbia sviluppato la sua opera pastorale, tenendo conto di ciò che egli stesso aveva descritto come una «immaturità della fede». È necessario questo chiarimento, perché i termini «relativismo» e «fondamentalismo» possono diventare un cliché nel quale vengono messi insieme diversi contenuti poco distinguibili. Essi possono trasformarsi in un’arma polemica a cui ricorrere contro qualsiasi avversario, contro qualsiasi tentativo di mettere in pratica i princìpi della fede e della dottrina della Chiesa. Lo stesso Joseph Ratzinger riconosce, in un articolo del 1991, «che in alcune situazioni un pizzico di relativismo e un poco di scetticismo possano giovare, non intendiamo metterlo in discussione. Ma il relativismo risulta totalmente inadeguato a far da comune fondamento su cui poter vivere»[3].
Il seguito dell’omelia del cardinale Ratzinger chiarisce quale sia il punto di autentico ancoraggio della Chiesa. Perché, a fronte del relativismo, «noi, invece, abbiamo un’altra misura: il Figlio di Dio, il vero uomo. È lui la misura del vero umanesimo. “Adulta” non è una fede che segue le onde della moda
Contenuto riservato agli abbonati
Vuoi continuare a leggere questo contenuto?
Clicca quioppure
Acquista il quaderno cartaceoAbbonati
Per leggere questo contenuto devi essere abbonato a La Civiltà Cattolica. Scegli subito tra i nostri abbonamenti quello che fa al caso tuo.
Scegli l'abbonamento