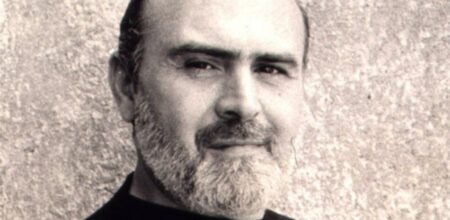|
|
«Perché questo film oggi? Perché questo film in televisione?». Le domande mi martellavano nella mente mentre percorrevo le strade di Trastevere per recarmi a un appuntamento con Paolo e Vittorio Taviani lo scorso 14 gennaio, giorno nel quale Raiuno stava per mettere in onda la prima parte del film Resurrezione (che i due fratelli hanno ricavato dal romanzo di Lev Tolstoj), la cui seconda parte è stata programmata il giorno successivo. Avevo visto il film qualche giorno prima, in una proiezione riservata alla stampa. «Perché un discorso così perentorio e perfino ribadito sulla responsabilità personale — tornavo a domandarmi — in un momento come questo, mentre si ha l’impressione di assistere a un’eclissi dei valori sui quali si basa il concetto di coscienza e il senso di responsabilità? Perché questo discorso proposto con la televisione, che molti considerano responsabile del progressivo diffondersi di una mentalità dominata dal consumismo, dall’edonismo, dall’egoismo, che sono, per così dire, i pilastri sui quali si basa l’attuale materialismo pratico?». Anche se le risposte erano implicite nelle domande che rimuginavo tra me e me, non ho saputo resistere al desiderio di rivolgerle ai registi.
Bilanci di fine secolo
Paolo: «Oltre al desiderio di raccontare una grande storia, quella della ragazza sedotta e abbandonata, del seduttore che, pentito, si prodiga per riparare il male che ha fatto, desiderio che portavamo dentro da molto tempo, quando abbiamo deciso di ricavare un film dal romanzo Resurrezione di Tolstoj siamo stati spinti da un convergere di coincidenze. Ci siamo accorti che Tolstoj, quando ha scritto il romanzo, aveva la nostra età. Siamo ormai sulla settantina. Inoltre si trovava anche lui, come ci siamo trovati noi, alla fine di un secolo tumultuoso, che per lui era il XIX mentre per noi era il XX, momenti nei quali un uomo si sente spinto a fare i conti con se stesso, con la propria vita, con le cose nelle quali ha creduto, con quelle nelle quali ha sperato e che si sono realizzate soltanto in parte, con quelle che non si sono realizzate e che, tuttavia, spera possano realizzarsi in futuro. Il momento nel quale viveva Tolstoj era caratterizzato dal rapido diffondersi di movimenti spirituali, anarchici, presocialisti, che lasciavano presagire grandi mutamenti nel futuro della società. Ora che quei mutamenti ci sono stati, torna il momento di fare un bilancio».
Vittorio: «A qualcuno può sembrare che il protagonista del film sia un po’ datato. Il suo comportamento infatti risulta comprensibile soltanto collocando la vicenda nel contesto culturale del suo tempo. A noi però non interessa tanto riproporre le condizioni di vita di un ambiente lontano dal nostro, come era la Russia di fine Ottocento. Ci interessa piuttosto raccontare la storia di uomini che, ieri in una maniera oggi in un’altra, devono fare i conti con la propria coscienza. Fare i conti con se stessi e con gli altri è uno dei bisogni più forti in un momento come quello che viviamo oggi. Basta guardarsi intorno. Basta parlare con i giovani per rendersene conto. Non è difficile capire che tanti riferimenti culturali, religiosi, sentimentali, che un tempo tenevano unita la società, si vanno progressivamente offuscando. Proprio per questo un racconto come quello di Tolstoj a noi risulta modernissimo».
Paolo: «A chi ci dice: “Ma non vi pare datato il senso di colpa che spinge il protagonista del film a spendere tutta la propria vita per riparare un torto compiuto nei confronti di un’altra persona?”, noi rispondiamo: “Ci sembra piuttosto datato il cinismo nei confronti di questi sentimenti e nei confronti della necessità di un’etica nuova”».
Vittorio: «Alla pari di altri scrittori del suo tempo, Tolstoj pubblicava i suoi romanzi a puntate su una rivista che consentiva la massima divulgazione allora possibile. Si serviva di quelle che alcuni critici hanno chiamato pratiche basse, in contrapposizione alle pratiche alte, un modo di raccontare che scaturisce dalla narrativa popolare e utilizza espedienti, tipici di quella narrativa, per aprire una breccia nella coscienza dei lettori, partendo dall’interesse che suscita sempre la storia di un amore contrastato. In questo modo riusciva ad attirare l’attenzione sui grandi temi, che sono la vita, la morte, l’aldilà, l’anima, Dio».
Paolo: «È un po’ come accade in Shakespeare, il quale partiva talvolta da canovacci messi in voga dai teatranti di scarso talento che lo avevano preceduto, riuscendo a elevarli fino ai vertici della poesia. Qualcosa del genere accadeva nel melodramma del nostro Ottocento (basta pensare a Verdi), con musica sublime che nasce da libretti a volte dozzinali, musica che non esisterebbe però se non ci fossero, come punto di partenza, quelle parole che a noi sembrano goffe e ridicole. Pratiche basse, come diceva Vittorio, che hanno consentito a opere artisticamente molto elevate di raggiungere una diffusione che va al di là di ogni confine».
Vittorio: «Per chi fa cinema, lavorare per la televisione equivale a fare qualcosa di simile a quello che per uno scrittore dell’Ottocento era il romanzo di appendice. La televisione consente di raggiungere con estrema rapidità un pubblico vastissimo. Allo stesso tempo la televisione ti chiede di raccontare storie popolari, utilizzando un linguaggio accessibile, che non esclude il ricorso alle pratiche basse pur di riuscire a comunicare contenuti validi».
Paolo: «Anche Roberto Rossellini pensava che la televisione fosse uno strumento formidabile per diffondere conoscenza. Purtroppo, dopo la sua morte, la televisione, invece di evolversi nella direzione da lui indicata, si è ripiegata su se stessa, in una gara tra emittenti private e pubbliche per accaparrarsi la fetta più grossa del pubblico con programmi di dubbio gusto, talvolta decisamente volgari. Il nostro film intende dimostrare che la ricerca dell’audience (parola orrenda!) non è incompatibile con prodotti di qualità. Se il nostro esperimento riesce, può darsi che altri registi si sentano invogliati a percorrere la stessa strada».
Una crisi di coscienza
Il titolo del romanzo e del film si riferisce a entrambi i protagonisti: il principe Dimitrij Nechljudov e Katjuša Maslova. La giovane e graziosa Katjuša, che ha ceduto alle lusinghe del padroncino e si è lasciata sedurre da lui, dopo aver disceso tutti i gradini dell’abiezione rinasce a vita nuova scontando colpe che non ha commesso. Dimitrij, pentito del male che ha fatto, rinuncia ai privilegi di casta e, seguendo Katjuša, avviata con un gruppo di prigionieri in Siberia, stabilisce con lei un rapporto di profonda solidarietà spirituale. Il romanzo e il film descrivono con colori delicati il momento dell’innamoramento giovanile tra i due durante una breve vacanza di lui nella villa delle zie, tutrici di lei. Tre anni dopo, Dimitrij torna nello stesso luogo. Non è più il giovane idealista di prima. È diventato un adulto cinico e dissoluto, pronto ad approfittare dell’ingenuità della ragazza che è ancora innamorata di lui. Un terzo incontro (ma si tratta questa volta di un incontro mancato) si svolge di notte in una stazione ferroviaria.
Vittorio: «Nel raccontare le fasi successive dell’abbandono, abbiamo voluto soffermarci sul dolore della donna che, mentre tenta di incontrare Dimitrij, è incinta. Non è un caso se Katjuša racconta questo episodio a una compagna di prigione che, a sua volta, è incinta. Accarezzando il ventre della compagna, dice: “Se lo avessi incontrato, gli avrei detto del bambino”. Penso che anche Tolstoj abbia voluto indicare con questa scena lo strazio sofferto dalla donna prima di lasciarsi andare sulla via della perdizione. La stazione ferroviaria con il treno che si allontana nella notte è, evidentemente, il luogo più indicato per parlare di due destini che, dopo essersi incrociati, si separano».
Dimitrij rivede Katjuša molti anni dopo in tribunale, dove è stato convocato come giurato. Dopo la nascita di un bambino, successivamente morto, la donna si è data alla prostituzione. Ora è accusata di aver avvelenato un cliente per derubarlo. A causa di un grossolano errore giudiziario è condannata, benché innocente, ai lavori forzati. Dimitrij, trovandosi improvvisamente di fronte alle conseguenze dell’errore commesso, rimane sconvolto e decide di impegnare le proprie sostanze e tutto se stesso per aiutare la donna a riscattarsi. Il romanzo si sofferma con descrizioni analitiche sul disagio morale che Dimitrij avverte a contatto con l’ambiente (caratterizzato da lusso, sopraffazione, meschinità, ipocrisia…) nel quale vive e al quale si è adeguato reprimendo la nausea che non può non avvertire, non solo nei confronti degli altri, ma perfino di se stesso, prima ancora di incontrare Katjuša in tribunale. Il film, a differenza del romanzo, sorvola su questo aspetto del racconto.
Paolo: «Le differenze tra romanzo e film, che sono indubbie, sono frutto di scelte che abbiamo compiuto con piena consapevolezza. Tolstoj scriveva nell’Ottocento. Noi siamo nel 2000. La differenza del mezzo impiegato induce a procedimenti di sintesi».
Vittorio: «Abbiamo pensato che vedere mani guantate di camerieri che scelgono le scarpe, mani guantate di cameriere che scelgono la camicia, lui che fuma adagiato sul letto “in quelle trine morbide” come direbbe Puccini, potesse bastare per rendere l’idea della situazione in cui vive, senza addentrarci nell’analisi psicologica e sociale alla quale Tolstoj si abbandona nelle pagine del romanzo».
Per riparare il torto compiuto nei confronti di Katjuša, Dimitrij decide di sposarla. La notizia mette a soqquadro il mondo privilegiato al quale il principe appartiene. Leggendo il romanzo si ha l’impressione che Dimitrij, non potendone più di quel mondo ingiusto e falso, trovi nell’idea del matrimonio riparatore, da lui abbracciata con determinazione ostinata, l’occasione per sfuggire all’abbraccio soffocante di un ambiente che lo ha tenuto prigioniero troppo a lungo e che pertanto detesta con tutta la sua anima. Nel film il senso di colpa, inteso come motivo del comportamento di Dimitrij, prende il sopravvento su altre considerazioni che, esplicite nelle parole di Tolstoj, diventano implicite nelle immagini dei Taviani.
Vittorio: «Nella parte del film che contiene la scena di seduzione, lui si comporta da laido, quale effettivamente è. Perfino in chiesa quando, inebriato dall’incenso e dai canti, dice “Siete tutti belli questa sera”, il suo sguardo, che si posa su Katjuša, non è uno sguardo innocente. Quando poi, la notte seguente, entra nella camera della ragazza e lei, sapendo quello che lui vuole, si rannicchia in un angolo per difendersi, lui per un attimo si appoggia alla parete come se, rendendosi conto di quello che sta facendo, non avesse la forza di farlo, mentre poi si riprende e lo fa. Questo comportamento dice con chiarezza che ci troviamo di fronte a un essere abietto, che ha la consapevolezza di esserlo».
Dimitrij raggiunge il colmo dell’abiezione il mattino successivo quando, al momento di lasciare la villa, mette una banconota da 100 rubli nel grembo di Katjuša, che non sa come reagire.
Il bruco e la farfalla
Tolstoj dice nel romanzo che, quando incontra per la prima volta Katjuša nella prigione, Dimitrij ha l’impressione di trovarsi davanti a una donna morta. Le pagine del libro e le immagini del film descrivono le fasi successive della «resurrezione» di Katjuša, a partire dai primi sintomi di ripresa, quando la donna si sottrae alla dipendenza dall’alcool, quando, osservando una vecchia foto, recupera i ricordi di gioventù, che aveva rimosso a causa delle disgrazie in seguito sopraggiunte, quando, a contatto con i bambini reclusi nell’infermeria della prigione, si accorge di essere guardata dai loro occhi innocenti in maniera diversa da come la guardano gli adulti viziosi, che non tralasciano occasione per ricordarle il suo passato di prostituta. La trasformazione iniziata incontra, come è ovvio, momenti difficili, affrontati parallelamente da Katjuša e da Dimitrij con tentazioni (messe in evidenza nel film dall’uso del montaggio alternato) che entrambi superano traendone motivo di corroborata determinazione.
Paolo: «Mentre Tolstoj si serviva della penna, noi ci siamo serviti dei mezzi del cinema, tra i quali, oltre al lavoro degli attori, c’è il lavoro del costumista, del truccatore, del direttore delle luci… Abbiamo detto agli attori: “Quando vi incontrate nella prigione all’inizio del film, siete due mostri. Siete diventati brutti per ragioni diverse. Tu, Dimitrij, sei diventato brutto perché mangi bene, mangi troppo. Sei molle, hai il viso flaccido. Man mano che si va avanti, poiché si parla della tua resurrezione, oltre a quella di Katjuša, il tuo viso si deve trasformare. Noi ti aiuteremo, ti metteremo la barba, faremo ricorso ad altri espedienti. Il tuo viso diventerà sempre più affilato. Alla fine si vedranno soltanto gli occhi. Al termine della tua trasformazione ti si deve amare, mentre invece non ti si ama prima che la trasformazione abbia inizio”. Lo stesso vale evidentemente con Katjuša, la cui trasformazione è ancora più marcata e perfino eccessiva. Stefania Rocca è talmente brava e ha capito a tal punto quello che volevamo da lei, che abbiamo avuto paura che stesse perfino esagerando. Quando Dimitrij le si avvicina e dice: “Io voglio sposarti”, lei si trasforma in un essere ripugnante. Le abbiamo detto: “Guarda che sei proprio brutta. Sei andata al di là di quello che avremmo voluto ottenere. La tua interpretazione raggiunge livelli di naturalismo che ci sembrano esagerati. Cerca di moderarti…”. Lei ha risposto: “Lasciatemi fare. Sento che è giusto così”. Vedendo il materiale in proiezione, ci siamo accorti che, proprio nel momento in cui il suo volto risulta più imbruttito, gli occhi esprimono una forza interiore, una carica di spiritualità, che raggiunge una grande forza proprio perché nasce da un contrasto spinto fino all’estremo».
Vittorio: «Anche la trasformazione di Katjuša, alla pari di quella di Dimitrij, si estende lungo l’arco del film, tanto è vero che, alla fine, l’immagine di lei appare bellissima come quella di una Madonna».
La trasformazione del personaggio di Katjuša è agevolata dai rapporti che, durante la detenzione, stringe con i prigionieri politici. Questi, secondo Tolstoj, sono i migliori tra gli uomini. Non è pertanto un caso se dal migliore di essi (Simonson) otterrà l’aiuto di cui ha bisogno per superare se stessa. Diverso è il percorso compiuto da Dimitrij, il quale, attraversando come un moderno reporter l’inferno della giustizia repressiva sotto il regno dello zar Nicola II, si fa carico di tutte le osservazioni e di tutte le riflessioni che, per suo tramite, Tolstoj propone all’attenzione dei lettori. Visto sotto questo profilo, il romanzo può essere considerato come un vero e proprio atto di accusa, nel quale sono passati in rassegna tutti i mali della società: dall’ingiustizia sociale e giudiziaria all’inefficienza delle istituzioni, senza risparmiare strali alla Chiesa russa (connivente — al dire di Tolstoj — con un ordine sociale in totale contrasto con i princìpi del Vangelo), la quale reagì impugnando contro lo scrittore l’arma della scomunica.
Paolo: «Prima di scrivere il romanzo, Tolstoj aveva scritto un racconto breve, sullo stesso argomento, avendo come punto di partenza una confidenza che gli aveva fatto un amico magistrato (si chiamava Koni), il quale gli aveva raccontato l’episodio più curioso al quale gli era capitato di assistere durante la sua carriera di giudice. Affascinato da quella storia, Tolstoj aveva chiesto all’amico di metterla per iscritto, ma, passato un certo tempo, visto che l’altro non si decideva a farlo, gli aveva chiesto il permesso di farlo lui. Nacque così Il racconto di Koni, che è, per così dire, il canovaccio sul quale Tolstoj ha poi scritto Resurrezione. Il racconto, che è stato successivamente pubblicato, è bellissimo anche se ha un finale deludente. Il suo fascino risiede nell’immediatezza con la quale i fatti sono narrati. Non c’è nel racconto tutta la parte sociale che nel romanzo è preponderante».
Vittorio: «Nel fare nostra l’opinione, condivisa da molti critici, che Resurrezione non sia il migliore tra i romanzi di Tolstoj, abbiamo tenuto presente il fatto che il racconto, nella sua stesura originaria, procedeva con ritmo diverso sulla base dei fatti narrati in maniera stringata. Nel romanzo si assiste invece a un progressivo accumulo di argomenti che stavano molto a cuore a Tolstoj e appartenevano alla realtà del suo tempo, una realtà dolorosa e ingiusta che egli intendeva denunciare. Questo accumulo di elementi diversi produce, a nostro avviso, nel romanzo una pesantezza che è del tutto assente dal racconto primitivo. Trovandoci nella necessità di ridurre la mole del romanzo, era chiaro che sarebbero cadute molte considerazioni sociali, politiche, religiose, sulle quali il romanziere si sofferma. Abbiamo lasciato soltanto un capitolo dedicato al rapporto dei contadini (allora considerati alla stregua di servi della gleba) con la terra, perché era insopprimibile».
La corona del pope
Nel finale del film i Taviani si distaccano dal percorso seguito da Tolstoj nel romanzo. Non è infrequente, nel caso di trasposizioni cinematografiche di opere letterarie, che la fedeltà allo spirito di un testo suggerisca di ricorrere a qualche infedeltà per quanto riguarda la sua interpretazione letterale. Il romanzo assume nelle ultime pagine un andamento che non sembra corrispondere alle aspettative del lettore, il quale, dopo essere stato informato nei minimi dettagli su tanti aspetti della vita dei protagonisti, vorrebbe sapere come va a finire la loro storia. Dimitrij e Katjuša si separano l’uno dall’altra senza rendere del tutto esplicite le proprie intenzioni. Lo stesso narratore, che nei capitoli precedenti aveva rischiato di affogare in un fiume di parole, sembra arenarsi su un greto sabbioso attraversato da un magro rigagnolo. Tutto si risolve nella trascrizione parola per parola di alcune pagine del Vangelo, proposte senza rielaborazione o commento.
I Taviani si trovavano, in primo luogo, davanti al problema di dover esplicitare ciò che nel libro è implicito in rapporto a tre personaggi (Dimitrij, Katjuša e Simonson) che nel romanzo abbandonano il teatro delle loro azioni allontanandosi in punta di piedi. La parola scritta consente di conferire alla loro presenza tracce che, di volta in volta, possono essere marcate o labili. L’audiovisivo, che ricorre alla presenza fisica degli interpreti, esige in ogni caso una definizione più precisa, che lascia meno spazio a incertezze o ambiguità. Katjuša trova il modo di esprimere con parole chiare nel film il suo amore per Dimitrij, che è rimasto immutato attraverso le dolorose vicende della sua vita. Splendida figura di donna che riesce a mantenersi fedele a un solo uomo anche quando, abbandonata da lui, si dà alla prostituzione, o quando, per non caricare sulle spalle di lui il peso del proprio passato, decide di sposare un altro. Si dirà che cose di questo genere possono accadere soltanto nei romanzi e nei film. Ma essi, quando raggiungono, come in questo caso, un livello così profondo di penetrazione della realtà, facendo risplendere allo stesso tempo i fatti della vita nella luce della poesia e dell’arte, aiutano a comprendere i paradossi dei quali, a sua insaputa, è spesse volte intrecciata l’esistenza dell’uomo.
Katjuša percepisce il grado di irragionevolezza che spinge Dimitrij a volerla sposare. Per il bene di lui, e perché questa storia abbia una svolta definitiva, decide di sposare Simonson, un compagno di prigionia. Il film si conclude con una gara di generosità nella quale i tre cercano di superarsi l’un l’altro. Dimitrij, che ha deciso di dedicare tutta la sua vita al riscatto di Katjuša, insiste nel chiederle di sposarlo, lasciandola tuttavia libera di decidere. Lei, proprio perché ama Dimitrij, chiede a Simonson di sposarla. Simonson è un uomo che conosce tutti i dolori della vita e nutre nei confronti di Katjuša un’ammirazione sconfinata. La sposa per aiutarla a coronare, con questo gesto, la sua piena evoluzione di essere umano che, pur avendo ricevuto tanto male, ha saputo trovare la forza di non soccombere ed è riuscita a trasformare il male in bene, fino ad attingere il livello più alto di generosità. Questo dato di fatto, a un tempo semplice e sublime, è indicato nel rito nuziale, del quale non c’è traccia nel romanzo, mentre il film lo propone utilizzando in funzione espressiva il momento nel quale il sacerdote pone una corona sul capo degli sposi.
Paolo: «Abbiamo avuto un consulente liturgico per le scene girate in chiesa. Un pope che ci ha aiutato a impostare la scena della messa di Pasqua (la liturgia della luce), compresi i canti, che sono stati eseguiti dal vivo. La scena del matrimonio è stata eseguita con la corona che, come lui ci ha spiegato, svolge un ruolo importante nella liturgia nuziale della Chiesa ortodossa, tanto è vero che lui, quando viaggia, la porta sempre con sé per il caso che gli capiti di celebrare qualche matrimonio all’improvviso».
Vittorio: «Katjuša ama Dimitrij. Lo ha amato sempre. Non si sa fino a che punto Dimitrij ami Katjuša. Parlando con una sua amica, lei dice: “Lui crede di amarmi”. È vero che, nella scena di addio, quando si incontrano per l’ultima volta alla stazione, lui le dice: “Io sono cambiato”, e quindi lei avverte che in lui c’è qualcosa di nuovo, che può essere vero amore, ma a questo punto la decisione è presa in funzione di lui, perché lui sia libero di andare per la sua strada. Katjuša ha intuito che Dimitrij ha bisogno di solitudine per poter raggiungere la sua piena dimensione spirituale».
In questo modo il film rende esplicito ciò che nel romanzo è implicito, ricorrendo a un procedimento inverso rispetto a quello utilizzato nella prima parte (quando si trattava di esprimere il disgusto avvertito da Dimitrij nei confronti dell’ambiente fatuo nel quale viveva), dove il film aveva reso implicito, sintetizzandolo, ciò che nel romanzo era esplicito.
La notte dei desideri
Il racconto sembra finito, ma nel film c’è un’aggiunta che è tutta farina del sacco dei Taviani. Tolstoj ha pubblicato il romanzo nel 1899. I fratelli registi immaginano che Dimitrij, dopo essersi accomiatato definitivamente da Katjuša con le parole: «Non riesco a dirti addio», rimanga ancora per qualche tempo nella steppa innevata prima di tornare a Mosca. È il capodanno del 1900. Un gruppo di contadini festeggia l’arrivo del nuovo secolo in una casa isolata nella pianura. Dimitrij è invitato a entrare. Allo scoccare della mezzanotte ciascuno esprime il proprio desiderio. È il momento nel quale si scatena l’utopia, elemento che non può mancare in un film dei Taviani.
Paolo: «Dato che il film racconta una storia d’amore, abbiamo voluto che i desideri espressi nell’ultima scena fossero soltanto in parte desideri pratici (una stufa di maiolica, un paio di vacche…), ma soprattutto desideri d’amore. Già quando Dimitrij entra nella casa, la prima cosa che si vede sono due che si baciano. Nel momento dei desideri c’è un carrello che passa da una all’altra di diverse coppie che si baciano. Quando lui viene invitato a esprimere il suo desiderio, si trova di fronte a un uomo e a una donna, entrambi giovani, che si amano. Nella sceneggiatura lui diceva: “Avere la forza di non tornare indietro”. Mentre giravamo la scena, per via del clima amoroso che si era stabilito con tutti quei baci, abbiamo capito che il film non poteva finire che con la parola amore. Così abbiamo cambiato la battuta. Il desiderio di Dimitrij espresso nel film, è “Amare come voi vi amate”».
La macchina da presa si avvicina al volto di Dimitrij, che guarda attraverso il vetro della finestra. Il volto di lui si fonde, in dissolvenza incrociata, con il volto di Katjuša che guarda attraverso il finestrino del treno. È chiaro il senso del desiderio espresso dal principe; amarsi da vicino, come fanno i giovani contadini, senza che l’amore debba essere pagato, come accade a lui, con il prezzo di una insuperabile lontananza. Ma, accanto al significato immediatamente percepibile della scena, strettamente legato allo stato d’animo del protagonista, se ne possono cogliere altri, più allargati e diffusi. Ciò accade nelle opere animate dal soffio della poesia, il cui senso non è chiuso, ma aperto e suscettibile di sempre nuove interpretazioni.
Dimitrij è nato in una casta di privilegiati. Pochi ricchi che vivono alle spalle di molti poveri. Unico tra i pochi, ha avuto il coraggio di rinunciare ai suoi privilegi. Non può non sentire su di sé il peso di questa condizione che fa del suo caso l’eccezione rispetto alla regola. Il nuovo secolo (il nuovo millennio) porterà un mondo dove amore e felicità non siano soltanto la ricompensa di enormi sacrifici che solo pochi sono in grado di affrontare, ma un bene comune, equamente condiviso da tutti?
Vittorio: «Le ultime immagini del film si basano su un contrasto che, secondo noi, dovrebbe provocare nella mente dello spettatore la ricerca di un senso che va al di là del significato delle singole cose che si vedono. Così è stato anche per noi che, quando preparavamo il film e mentre lo realizzavamo, non sapevamo con certezza quale sarebbe stato il risultato delle scelte che stavamo compiendo. A film finito ci siamo accorti che forse in quelle immagini c’era qualcosa di più rispetto a quello che abbiamo voluto metterci intenzionalmente. La giovane donna, nell’invitare Dimitrij a esprimere il suo desiderio, dice: “Il nuovo secolo sarà buono… Non avete nulla da chiedergli?”. Contemporaneamente si vede il treno, sul quale si allontana Katjuša, che avanza nella distesa gelata. Noi sappiamo che il secolo XX, verso il quale quel treno si inoltra, non è stato buono. Allo stesso tempo ci pare che il contrasto tra il volto della donna e l’immagine del treno, tra le parole della donna e il rumore delle ruote sui binari, sia ricco di significato. Non sappiamo che cosa ci riserva il futuro. Sappiamo però che non si può vivere senza speranza».