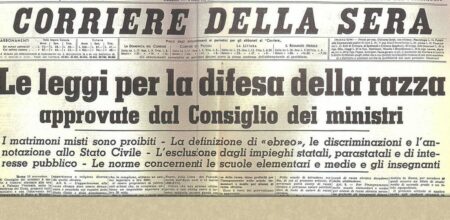Lungo il cammino verso Gerusalemme, Gesù attraversava la Samaria e la Galilea. Entrando in un villaggio, gli vennero incontro dieci lebbrosi, che si fermarono a distanza e dissero ad alta voce: «Gesù, maestro, abbi pietà di noi!». Appena li vide, Gesù disse loro: «Andate a presentarvi ai sacerdoti». E mentre essi andavano, furono purificati. Uno di loro, vedendosi guarito, tornò indietro lodando Dio a gran voce, e si prostrò davanti a Gesù, ai suoi piedi, per ringraziarlo. Era un Samaritano. Ma Gesù osservò: «Non ne sono stati purificati dieci? E gli altri nove dove sono? Non si è trovato nessuno che tornasse indietro a rendere gloria a Dio, all’infuori di questo straniero?». E gli disse: «Alzati e va’; la tua fede ti ha salvato!» (Lc 17,11-19).
L’episodio dei dieci lebbrosi ci aiuta a meditare sul tema della fiducia e della gratitudine. È con fiducia che quei lebbrosi si rivolgono a Gesù: la loro preghiera – Kyrie eleison – è quella che diciamo ad ogni Messa. È con fiducia che gli vanno incontro per essere guariti, rischiando di persona (non possono entrare in città se portano i segni della malattia), e che compiono quanto Gesù ha loro ordinato. I lebbrosi si mettono in cammino per presentarsi ai sacerdoti. Anche questa volta è un cammino da compiere e, proprio nel camminare, si scoprono mondati. È gioia per tutti. È l’esperienza della salvezza che penetra nella loro carne: sono guariti dal male incurabile…
Eppure uno solo torna da Gesù a ringraziare. La gratitudine del lebbroso non è l’espressione convenzionale di chi vuol manifestare in qualche modo la sua riconoscenza; è – e le parole di Gesù lo rivelano: «La tua fede ti ha salvato» (Lc 17,19) – la gioia di chi ha capito che colui che lo ha guarito lo guarirà ancora, lo guarirà sempre! È l’esultanza di chi scopre di essere amato dal Signore, e di essere amato per sempre. È questa la fede che salva il lebbroso, è questa la fede che ci salva.
Tuttavia, Gesù chiede: «Non ne sono stati purificati dieci? E gli altri nove dove sono?» (v. 17). Il Signore vuole insegnarci una grande verità: ricevere un dono, per quanto grande esso sia, può essere secondario: è più importante rimanere in relazione con il benefattore, con la persona che ci ha dato il beneficio. Riconoscendo i suoi doni, ringraziandolo, noi consolidiamo il rapporto che il donatore ha iniziato e che non può essere completato senza il nostro grazie. Perché il Signore non vuole solo farci dei doni, vuole darci se stesso: questo è il dono più grande, questa è la gioia che emana dalla gratitudine.
Va da sé che la gratitudine è un aiuto rilevante per la nostra vita spirituale: chi è riconoscente è una persona vera, è umile, è libero dalla tentazione dell’orgoglio (si veda il fariseo della parabola in Lc 18,9-14). Chi invece non ringrazia cade inevitabilmente nell’egoismo, nella superbia: si sente giusto e irreprensibile con le proprie forze. E dimentica che è il Signore che ci guarisce, ci purifica, ci rende capaci di compiere il bene, ci ama donandoci se stesso, per sempre.
La prima Lettura ci ricorda l’episodio di Naaman il siro, il generale straniero e nemico di Israele, colpito dalla lebbra: è salvato gratuitamente dalla misericordia divina, perché ha avuto fede. I numerosi regali che aveva portato con sé non gli sono serviti. Dio, nella sua generosità, non si fa pagare mai nulla! Tutto per Naaman (e per noi) è dono, tutto è grazia. Perciò egli chiede di portare via con sé un po’ della terra di Israele: è la terra «santa», in cui ha conosciuto il vero Dio, la sua salvezza.
Paolo afferma nella seconda Lettura, rivolgendosi a Timoteo, che se noi non ringraziamo il Signore o non gli siamo fedeli, egli «rimane fedele, perché non può rinnegare se stesso» (2 Tm 2,13). «Genti tutte, lodate il Signore: perché forte è il suo amore per noi e la sua fedeltà dura per sempre» (Sal 117).
* * *
4 ottobre 1965, Paolo VI all’Onu, 20 anni dopo la IIa Guerra mondiale: «Mai più la guerra!». L’inascoltato e attualissimo grido del Papa dopo l’immane tragedia del Secondo conflitto mondiale.