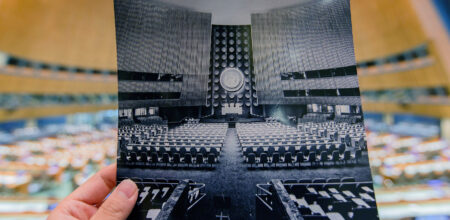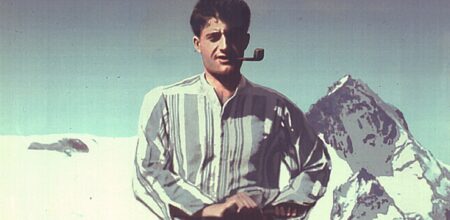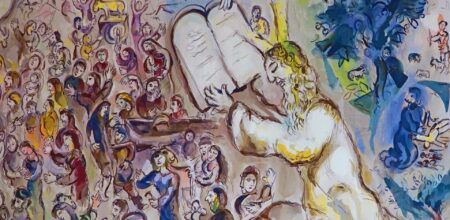|
|
Papa Francesco, dopo il suo viaggio in Cile, rigettando la logica del “capro espiatorio”, si è assunto in prima persona la responsabilità e la “vergogna” dello scandalo degli abusi su minori commessi da prelati nel Paese latino-americano, e della sua gestione. Con questo spirito, il Papa al ritorno dal Cile ha costituito una commissione speciale, guidata da S.E. mons. Charles J. Scicluna, per ascoltare direttamente le testimonianze delle vittime e raccogliere documentazione. A seguito della visita in Cile e della relazione di tale “Missione speciale” papa Francesco, con una lettera datata l’8 aprile, ha convocato a Roma tutti i vescovi cileni “per dialogare sulle conclusioni della suddetta visita e sulle mie conclusioni”.
All’inizio dell’incontro, avvenuto effettivamente dal 15 al 17 maggio 2018, il Papa ha consegnato ai vescovi una lettera di 10 pagine, resa poi nota dalla emittente cilena Tv 13. Qui di seguito ne diamo una nostra traduzione italiana.
Al termine dell’incontro ha consegnato ai vescovi cileni una breve lettera pubblica e ha loro affidato, perché fosse resa pubblica, una lettera al “popolo di Dio” del Cile, e anche di essa forniamo una nostra traduzione.
Pubblichiamo oggi questi testi non solo per documentare il processo avviato dal Papa per affrontare il dramma degli abusi sui minori, partendo da una situazione concreta; ma anche per far emergere quale visione di Chiesa sia possibile individuare dalle parole del Papa, alla luce di questo discernimento, necessitato da una situazione di gravissima “tribolazione”. Su questo tema la nostra rivista ha pubblica un ampio saggio di p. Diego Fares. Forniamo qui anche una nostra traduzione di un testo dell’allora p. Jorge Mario Bergoglio S.I. sulla «dottrina della tribolazione».
*******
Cari fratelli,
lo scorso 8 aprile, domenica della Misericordia, vi ho mandato una lettera convocandovi a Roma per dialogare sulle conclusioni della visita compiuta dalla «Missione speciale» che aveva il compito di aiutare a fare luce per trattare adeguatamente una ferita aperta, dolorosa e complessa, che da molto tempo sta sanguinando nella vita di tante persone e, pertanto, nella vita del Popolo di Dio.
Una ferita trattata, finora, con una medicina che invece di curarla sembra averne ingrandito ancora di più lo spessore e il dolore. Dobbiamo riconoscere che allo scopo di riparare il danno e la sofferenza arrecati sono state compiute diverse azioni, ma dobbiamo anche essere consapevoli del fatto che la strada seguita non è valsa molto a guarire e a curare. Forse perché si voleva voltare pagina troppo rapidamente senza farsi carico delle insondabili ramificazioni di questo male; o perché è venuto meno il coraggio di affrontare le responsabilità, le omissioni e specialmente le dinamiche permissive che hanno consentito alle ferite di generarsi e di perpetuarsi nel tempo; forse perché è mancata la risolutezza di assumere come corpo quella realtà in cui tutti siamo implicati, io per primo, e da cui nessuno si può esimere spostando il problema sulle spalle degli altri; o perché si è pensato che fosse possibile andare avanti senza riconoscere, con umiltà e fermezza, che in tutto il processo erano stati compiuti degli errori.
In questo senso, ascoltando il parere di diverse persone e constatando la persistenza della ferita, ho costituito una commissione speciale che, con grande libertà di spirito, in modo giuridico e tecnico potesse pervenire a una diagnosi quanto più possibile indipendente, e gettare uno sguardo limpido sui passati avvenimenti e sullo stato attuale della situazione.
Il tempo che ora ci viene offerto è tempo di grazia. Tempo in cui, con l’impulso dello Spirito Santo e in clima di collegialità, si possono compiere i passi necessari per generare la conversione a cui lo stesso Spirito vuole condurci. È necessario un cambiamento, lo sappiamo, ne abbiamo bisogno e lo desideriamo. Non è soltanto un debito che abbiamo verso le nostre comunità e tante persone che hanno sofferto e soffrono nella loro carne i dolori arrecati: lo spirito di conversione fa parte della missione e dell’identità stessa della Chiesa. Lasciamo che questo sia un tempo di conversione.
«Lui deve crescere; io, invece, diminuire» (Gv 3,30). L’ultimo dei grandi profeti, Giovanni il Battista, rivolse queste parole ai suoi discepoli quando, scandalizzati, gli vennero a riferire che qualcuno faceva le stesse cose che faceva lui. Giovanni, conscio della sua identità e della sua missione – non era lui il Messia, ma era stato inviato davanti a lui (v. 28) – non esitò a dare loro una risposta chiara e sgombra da qualsiasi ambiguità.
Con questo sfondo di profezia e ispirandomi alle parole di questo profeta vorrei dare il «calcio d’inizio» alla riflessione fraterna con voi nel corso di queste giornate.
Lui deve crescere…
Forse per il credente non esiste gioia più grande che condividere, testimoniare e rendere visibili Gesù e il suo Regno. L’incontro col Risorto trasforma la vita e fa sì che la fede diventi gioiosamente «contagiosa». È il seme del Regno dei Cieli che tende spontaneamente alla condivisione, a moltiplicarsi, e che, come Andrea, ci induce a correre verso i nostri fratelli e a dire: «Abbiamo trovato il Messia» (Gv 1,41). Un Messia che ci apre sempre un orizzonte di vita e di speranza. Grazie all’azione dello Spirito il discepolo si lascia lanciare in quest’avventura di fare crescere e spargere la vita nuova che Gesù ci offre. Non possiamo mai identificare quest’azione col proselitismo o con la conquista di spazi: è invece l’invito gioioso alla vita nuova che Gesù ci regala. «Lui deve crescere» è ciò che palpita nel cuore del discepolo, perché ha sperimentato che Gesù Cristo è offerta di vita buona. Soltanto Lui è capace di salvare.
La Chiesa in Cile ne ha buona esperienza. La storia ci dice che ha saputo essere madre e generare molti nella fede, che ha predicato la vita nuova del Vangelo e ha combattuto per essa quando veniva minacciata. Una Chiesa che ha saputo dare «battaglia» quando la dignità dei suoi figli non era rispettata o veniva semplicemente ignorata. Non ha cercato affatto di mettersi al centro, non ha cercato di essere il centro: ha saputo essere la Chiesa che metteva al centro ciò che era importante. In momenti bui della vita del suo popolo, la Chiesa in Cile ha avuto il coraggio profetico non soltanto di alzare la voce, ma anche di fare appello affinché si creassero spazi in difesa di uomini e donne sui quali il Signore l’aveva incaricata di vegliare; sapeva bene che non si poteva proclamare il comandamento nuovo dell’amore senza promuovere, tramite la giustizia e la pace, la crescita vera di ogni persona[1]. Così possiamo parlare di Chiesa profetica che sa offrire e generare la vita buona che il Signore ci offre.
Una Chiesa profetica che sa mettere Gesù al centro è capace di promuovere un’azione evangelizzatrice che guarda il Maestro con la tenerezza di Teresa delle Ande, e affermare: «Hai paura di avvicinarti a Lui? Guardalo in mezzo al suo gregge fedele, mentre si carica sulle spalle la pecora infedele. Guardalo sulla tomba di Lazzaro. E ascoltalo dire a Maddalena: molto le è stato perdonato perché ha amato molto. Che cosa scopri in questi passi del Vangelo se non un cuore dolce, tenero, compassionevole, un cuore, infine, di un Dio?»[2].
Una Chiesa profetica che sa mettere Gesù al centro è capace di fare festa per la gioia provocata dal Vangelo. Come ho rimarcato a Iquique, ma possiamo certo applicarlo a tanti luoghi del nord e del sud del Cile, la pietà popolare è una delle ricchezze più grandi che il Popolo di Dio ha saputo coltivare. Con le sue feste patronali, con i suoi balli religiosi – che si protraggono anche per settimane –, con la sua musica e le sue vesti, giungono a trasformare tante zone in santuari di pietà popolare. Infatti non sono feste che rimangono chiuse all’interno del tempio, ma riescono a rivestire a festa tutto il villaggio[3]. E così si crea un intreccio capace di celebrare la presenza di Dio tra il suo popolo in gioia e speranza. Nei santuari impariamo a essere una Chiesa di vicinanza, di ascolto, che sa sentire e condividere la vita così come essa si presenta. Una Chiesa che ha appreso che la fede si trasmette soltanto in dialetto e così celebra cantando e danzando «la paternità, la provvidenza, la presenza amorosa e costante di Dio»[4].
Una Chiesa profetica che sa mettere Gesù al centro è capace di generare nella santità un uomo che ha saputo proclamare con la sua vita: «Cristo vaga per le nostre strade nella persona di tanti poveri malati, sofferenti, costretti ad abbandonare il loro misero alloggio. Cristo, rannicchiato sotto i ponti, nella persona di tanti bambini che non hanno nessuno da chiamare “padre”, che da molti anni sono privi del bacio della madre sulla loro fronte… Cristo non ha una dimora! Non vogliamo dargliela noi? […] “Quello che fate al più piccolo dei miei fratelli lo fate a me”, ha detto Gesù»[5]; infatti «se siamo ripartiti davvero dalla contemplazione di Cristo, dovremo saperlo scorgere soprattutto nel volto di coloro con i quali egli stesso ha voluto identificarsi»[6].
Una Chiesa profetica che sa mettere Gesù al centro è capace di chiamare a generare spazi che accompagnino e difendano la vita dei diversi popoli che formano il suo vasto territorio, riconoscendo una ricchezza multiculturale ed etnica senza pari, sulla quale è necessario vegliare. A modo di esempio segnalo le iniziative promosse specialmente dai vescovi del Sud del Cile negli anni Sessanta, promuovendo le dinamiche necessarie affinché il popolo Mapuche potesse vivere in pienezza l’arte del ben vivere, da cui abbiamo tanto da imparare. Azioni forti che hanno generato strutture favorevoli alla difesa della vita invitando al protagonismo responsabile di una fede incarnata, trasformante; quella fede che sa dare vita alla chiamata del Concilio che ci ricorda come «le gioie e le speranze, le tristezze e le angosce degli uomini d’oggi, dei poveri soprattutto e di tutti coloro che soffrono, sono pure le gioie e le speranze, le tristezze e le angosce dei discepoli di Cristo, e nulla vi è di genuinamente umano che non trovi eco nel loro cuore»[7].
Una Chiesa profetica che sa mettere Gesù al centro con sincerità è capace – come ha saputo mostrarci uno dei vostri pastori – di «confessare che, nella nostra storia personale, e nella storia del nostro Cile, ci sono state ingiustizia, menzogna, odio, colpa, indifferenza. [E li invitava a essere] sinceri, umili e a dire al Signore: abbiamo peccato contro di te! Peccare contro il nostro fratello, l’uomo e la donna, è peccare contro Cristo, che è morto ed è risorto per tutti gli uomini. Siamo sinceri, umili! Signore, ho peccato contro di te! Non ho obbedito al tuo Vangelo!»[8]. La coscienza consapevole dei suoi limiti e dei suoi peccati fa vivere vigili verso la tentazione di soppiantare il proprio Signore.
E così potremmo continuare ancora a enumerare molti fermenti vivi di Chiesa profetica che sa mettere Gesù al centro. Ma l’invito più grande e fecondamente vitale – come ho voluto sottolineare nella recente Esortazione apostolica ricordando Edith Stein – nasce dalla fiducia e dalla convinzione che «nella notte più oscura sorgono i più grandi profeti e i santi. Tuttavia, la corrente vivificante della vita mistica rimane invisibile. Sicuramente gli avvenimenti decisivi della storia del mondo sono stati essenzialmente influenzati da anime sulle quali nulla viene detto nei libri di storia. E quali siano le anime che dobbiamo ringraziare per gli avvenimenti decisivi della nostra vita personale, è qualcosa che sapremo soltanto nel giorno in cui tutto ciò che è nascosto sarà svelato»[9]. Il Santo Popolo fedele di Dio, nel suo silenzio quotidiano, sotto molte forme e maniere continua a rendere visibile e attesta con «cocciuta» speranza che il Signore non abbandona, che sostiene la donazione costante e, in tante situazioni, sofferente dei suoi figli. Il Santo e Paziente Popolo fedele di Dio sostenuto e vivificato dallo Spirito Santo è il volto migliore della Chiesa profetica che sa mettere al centro il suo Signore nella donazione quotidiana[10]. Il nostro atteggiamento di pastori consiste nell’imparare a confidare in questa realtà ecclesiale e a riverire e riconoscere il fatto che in un popolo semplice, che confessa la sua fede in Gesù Cristo, ama la Vergine, si guadagna da vivere col lavoro (tante volte malpagato), battezza i suoi figli e seppellisce i suoi morti, in questo popolo fedele che si sa peccatore ma non si stanca di chiedere perdono perché crede nella misericordia del Padre, in questo popolo fedele e silenzioso risiede il sistema immunitario della Chiesa.
Io, invece, diminuire
Duole constatare che, in quest’ultimo periodo della storia della Chiesa cilena, questa ispirazione profetica ha perso vigore per dare spazio a quella che potremmo denominare una trasformazione nel suo centro. Non so che cosa sia venuto prima, se la perdita di forza profetica abbia dato luogo al cambio di centro o se il cambio di centro abbia portato a perdere la profezia che in voi era così caratteristica. Tuttavia possiamo certo osservare che quella Chiesa che era chiamata a mettere in evidenza Colui che è la Via, la Verità e la Vita (Gv 14,6) è diventata essa stessa il centro di attenzione. Ha smesso di guardare e di additare il Signore per guardarsi e occuparsi di sé stessa. Ha concentrato su di sé l’attenzione e ha perduto la memoria della sua origine e della sua missione[11]. Si è accentrata su di sé a tal punto che le conseguenze di tutto questo processo hanno arrecato un prezzo molto alto: il suo peccato è diventato il centro di attenzione. La dolorosa e vergognosa constatazione di abusi sessuali verso minori, di abusi di potere e di coscienza da parte di ministri della Chiesa, nonché il modo in cui si sono affrontate queste situazioni[12], dà evidenza di questo «cambio di centro ecclesiale». Dove, anziché diminuirsi la Chiesa per fare apparire i segni del Risorto, è stato il peccato ecclesiale a occupare tutta la scena, concentrando su di sé l’attenzione e gli sguardi.
È urgente affrontare questo scandalo e cercare di porre rimedio a breve, medio e lungo termine per ristabilire la giustizia e la comunione[13]. Credo al tempo stesso che, con la stessa urgenza, dobbiamo lavorare a un altro livello per discernere come generare nuove dinamiche ecclesiali in consonanza col Vangelo e che ci aiutino a essere migliori discepoli missionari capaci di recuperare la profezia.
Questa vita nuova che il Signore ci dona implica che si riconquisti la chiarezza del Battista e si affermi senza ambiguità che il discepolo non è e non sarà mai il Messia. Questo ci porta a promuovere una consapevolezza gioiosa e realistica di noi stessi: il discepolo non è più grande del suo Signore. E per questa stessa ragione, in primo luogo, dobbiamo stare attenti a ogni tipo o forma di messianismo che pretenda di ergersi a unico interprete della volontà di Dio. Molte volte possiamo cadere nella tentazione di un’esperienza ecclesiale dell’autorità che pretende di soppiantare le varie istanze di comunione e partecipazione, o, peggio ancora, di soppiantare la coscienza dei fedeli dimenticando l’insegnamento conciliare che ci ricorda che «la coscienza è il nucleo più segreto e il sacrario dell’uomo, dove egli è solo con Dio, la cui voce risuona nell’intimità»[14]. È essenziale che si recuperi una dinamica ecclesiale capace di aiutare i discepoli a discernere il sogno di Dio per le loro vite, senza pretendere di soppiantarli in questa ricerca. Nei fatti, i falsi messianismi vorrebbero cancellare quell’eloquente verità che è la totalità dei fedeli ad avere l’unzione del Santo[15]. Né un individuo né un gruppo illuminato possono mai avanzare la pretesa di essere la totalità del Popolo di Dio, e tantomeno credersi la voce autentica della sua interpretazione. In questo senso dobbiamo guardarci da quella che mi permetto di chiamare «psicologia da élite», che può affacciarsi nel nostro modo di affrontare le questioni.
La psicologia da élite o elitaria finisce per ingenerare dinamiche di divisione, separazione, «circoli chiusi», che sfociano in spiritualità narcisiste e autoritarie dove, anziché evangelizzare, quello che conta è sentirsi speciali, diversi dagli altri, mettendo così in evidenza come non interessino veramente né Gesù Cristo né gli altri[16]. Messianismi, elitarismi, clericalismi sono altrettanti sintomi di perversione nella sostanza ecclesiale; ed è sinonimo di perversione anche la perdita della sana coscienza del saperci appartenenti al santo Popolo fedele di Dio che ci precede e – grazie a Dio – ci succederà. Non perdiamo mai la coscienza di quel dono così eccelso che è il nostro battesimo.
È il riconoscimento sincero, orante e molte volte finanche addolorato dei nostri limiti che permette alla grazia di agire meglio in noi, poiché le dà lo spazio per provocare quel bene possibile che è insito in una dinamica sincera, comunitaria e di reale crescita[17]. Questa coscienza del limite e della parzialità che occupiamo dentro il Popolo di Dio ci salva dalla tentazione e dalla pretesa di voler occupare tutti gli spazi, e specialmente un luogo che non ci spetta: quello del Signore. Soltanto Dio è capace della totalità, soltanto Lui è capace della totalità di un amore esclusivo e al tempo stesso non escludente. La nostra missione è e sarà sempre missione condivisa. Come vi ho detto nell’incontro con il clero di Santiago, «la consapevolezza di avere delle piaghe ci libera; sì, ci libera dal diventare autoreferenziali, di crederci superiori. Ci libera da quella tendenza prometeica di coloro che in definitiva fanno affidamento unicamente sulle proprie forze e si sentono superiori agli altri»[18].
Perciò, e permettetemi di insistere, è urgente generare dinamiche ecclesiali capaci di promuovere la partecipazione e la missione condivisa di tutti i componenti della comunità ecclesiale evitando qualsiasi tipo di messianismo o di psicologia-spiritualità da élite. E, in concreto, per esempio, ci farà bene aprirci di più e lavorare insieme con diverse componenti della società civile per promuovere una cultura antiabusi a trecentosessanta gradi.
Quando vi ho convocati a questo incontro vi invitavo a chiedere allo Spirito il dono della magnanimità per riuscire a tradurre in fatti concreti i punti su cui avremmo riflettuto. Vi esorto a implorare con insistenza questo dono per il bene della Chiesa in Cile. Ho recepito con una certa preoccupazione l’atteggiamento con cui alcuni di voi, vescovi, hanno reagito agli avvenimenti presenti e passati. Un atteggiamento orientato a quello che potremmo chiamare l’«episodio Giona» – in mezzo alla tempesta era necessario gettare a mare il problema (Gn 1,4-16)[19] – credendo che la mera rimozione di persone risolverebbe di per sé i problemi[20]. Qui c’è di mezzo la dimenticanza del principio paolino: «Se il piede dicesse: “Poiché non sono mano, non appartengo al corpo”, non per questo non farebbe parte del corpo» (1 Cor 12,15). I problemi che oggi si vivono dentro la comunità ecclesiale non si risolvono soltanto affrontando i casi concreti e riducendoli a una rimozione di persone[21]; questo – e lo dico chiaramente – va fatto, ma non è sufficiente, bisogna andare più in là. Sarebbe irresponsabile da parte nostra non andare a fondo nel cercare le radici e le strutture che hanno permesso a questi avvenimenti concreti di accadere e di perpetuarsi. Le dolorose situazioni avvenute sono indicatrici del fatto che qualcosa sta male nel corpo ecclesiale[22]. Dobbiamo affrontare i casi concreti e al tempo stesso, e con la stessa intensità, andare più a fondo per scoprire quali dinamiche abbiano reso possibile il verificarsi di simili atteggiamenti e mali[23]. Confessare il peccato è necessario, cercare di porvi rimedio è urgente, conoscerne le radici è sapienza per il presente-futuro. Sarebbe una grave omissione da parte nostra non andare alle radici. Più ancora, credere che soltanto la rimozione delle persone, da sola, ripristinerebbe la salute del corpo è un grande abbaglio. Non c’è dubbio che aiuterebbe e che sia necessario farlo, ma ripeto che non basta[24], perché questo pensiero ci dispenserebbe dalla responsabilità e dalla partecipazione che ci spettano dentro il corpo ecclesiale. E là dove la responsabilità non viene assunta e condivisa, il colpevole di ciò che non funziona è sempre l’altro[25]. Per favore, scansiamo la tentazione di voler salvare noi stessi, salvare la nostra reputazione («salvare la pelle»); piuttosto, confessiamo comunitariamente la debolezza per trovare così, insieme, risposte umili, concrete e in comunione con tutto il Popolo di Dio. La gravità dell’accaduto non ci permette di atteggiarci a esperti cacciatori di «capri espiatori». Tutto questo richiede da noi serietà e co-responsabilità per assumere i problemi come sintomi di un tutto ecclesiale che siamo invitati ad analizzare, e ci richiede anche di cercare tutte le mediazioni necessarie affinché mai più tornino a verificarsi. Possiamo riuscirci soltanto se assumiamo questo come un problema di tutti e non come il problema che riguarda alcuni. Possiamo risolverlo soltanto se ce lo assumiamo collegialmente, in comunione, in sinodalità.
Fratelli, non siamo qui perché siamo migliori di altri. Come vi ho detto in Cile, siamo qui con la consapevolezza di essere peccatori-perdonati o peccatori che vogliono essere perdonati, peccatori con apertura penitenziale. E in questo troveremo la fonte della nostra gioia. Vogliamo essere pastori secondo Gesù ferito, morto e risorto. Vogliamo trovare nelle ferite del nostro popolo i segni della Risurrezione. Vogliamo passare da quella che è una Chiesa incentrata su di sé, abbattuta e desolata dai suoi peccati, a una Chiesa servitrice di tanti avviliti che ci vivono accanto. Una Chiesa capace di mettere al centro ciò che è importante: il servizio del suo Signore nell’affamato, nel carcerato, nell’assetato, nel senzatetto, nel nudo, nel malato, nell’abusato… (Mt 25,35) con la coscienza che costoro hanno la dignità di sedersi alle nostre tavole, di sentirsi «a casa» tra noi, di essere considerati famiglia. Questo è il segno che il Regno dei cieli è tra noi. È il segno di una Chiesa che è stata ferita dal suo peccato, a cui il Signore ha usato misericordia, e trasformata in profetica per vocazione[26]. Fratelli, le idee si discutono, le situazioni si discernono. Siamo riuniti per discernere, non per discutere.
Rinnovare la profezia è tornare a concentrarci su ciò che è importante; è contemplare colui che hanno trafitto e sentirsi dire: «Non è qui. È risorto» (Mt 28,6); è creare le condizioni e le dinamiche ecclesiali affinché ogni persona, nella situazione in cui si trova, possa scoprire colui che Vive e ci aspetta in Galilea.
Traduzione italiana © “La Civiltà Cattolica” 2018 – Tutti i diritti riservati.
*******
[1] Cfr Paolo VI, Evangelii nuntiandi, n. 29.
[2] Teresa delle Ande, s., Diarios y cartas, 373; 376.
[3] Francesco, Omelia nella santa Messa e celebrazione fraterna per l’integrazione dei popoli, Campo Lobito (Iquique), Cile, 18 gennaio 2018.
[4] Ivi; cfr Paolo VI, Evangelii nuntiandi, n. 48; Celam, Puebla, nn. 400; 454; Celam, Aparecida, nn. 99h; 262-265; Francesco Evangelii gaudium, n. 122.
[5] Alberto Hurtado, s., Cristo non ha dimora, meditazione in un ritiro per donne, 16 ottobre 1944.
[6] Giovanni Paolo II, s., Novo millennio ineunte, n. 49.
[7] Concilio Vaticano II, Gaudium et spes, n. 1.
[8] Silva Henríquez, Reconciliación de los chilenos, omelia alla conclusione dell’Anno Santo, 24 novembre 1974.
[9] E. Stein, s., Verborgenes Leben und Epiphanie, in GW XI, 145.
[10] Cfr Francesco, Gaudete et exsultate, nn. 6-9.
[11] «La tua fama si diffuse fra le genti. La tua bellezza era perfetta. Ti avevo reso uno splendore. Oracolo del Signore Dio. Tu però, [ti sei] infatuata per la tua bellezza e [hai approfittato] della tua fama» (Ez 16,14-15b). [Ndt: il passo non regge nella traduzione italiana]
[12] È sintomatico notare, nel rapporto presentato dalla «Missione speciale», che tutti i dichiaranti, compresi i membri del Consiglio nazionale per la prevenzione dell’abuso verso i minorenni e per l’accompagnamento delle vittime, hanno segnalato l’insufficiente attenzione pastorale prestata fino allora a tutti coloro che sono rimasti coinvolti, in un modo o nell’altro, in una causa canonica de delicta graviora.
[13] Cfr Francesco, Lettera ai vescovi del Cile a seguito del report consegnato da S. E. mons. Charles J. Scicluna, 8 aprile 2018.
[14] Concilio Vaticano II, Gaudium et spes, 16.
[15] Cfr Concilio Vaticano II, Lumen gentium, 12.
[16] Cfr Francesco, Evangelii gaudium, n. 94.
[17] Cfr Id., Gaudete et exsultate, n. 52.
[18] Id., Incontro con sacerdoti, religiosi e religiose, consacrati e seminaristi, Santiago del Cile, 16 gennaio 2018.
[19] Lo stesso Giona ammette che la tempesta è stata provocata dal fatto che egli non ha assunto la missione che gli toccava e che per scamparla devono gettarlo a mare: «Prendetemi e gettatemi in mare e si calmerà il mare che ora è contro di voi, perché io so che questa grande tempesta vi ha colto per causa mia» (v. 12).
[20] «Morto il cane si calmò la rabbia». Potremmo anche parlare della «sindrome Caifa»: «Conviene che un uomo solo muoia per il popolo.
[21] Perché non si tratta soltanto di un caso in particolare. Sono numerose le situazioni di abuso di potere, di autorità; di abuso sessuale. E questo comprende il modo in cui finora le si è trattate.
[22] Per esempio, nel rapporto presentato dalla «Missione speciale» molti di coloro che sono stati intervistati nella Nunziatura sostengono che parte della frattura profonda nella comunione ecclesiale nel clero si trascinerebbe fin dallo stesso seminario, viziando quelle che dovrebbero essere le relazioni fraterne presbiteriali e rendendo i fedeli partecipi di queste divisioni e fratture, che finiscono per danneggiare irrimediabilmente la credibilità sociale e l’autorevolezza ecclesiale dei presbiteri e dei vescovi.
[23] Nel rapporto della «Missione speciale» i miei inviati hanno potuto confermare che alcuni religiosi espulsi dal loro ordine a causa dell’immoralità della loro condotta e dopo che era stata minimizzata l’assoluta gravità dei loro fatti delittuosi attribuendoli a semplice debolezza o mancanza morale, sarebbero stati accolti in altre diocesi e perfino, in modo più che imprudente, sarebbero loro stati affidati incarichi diocesani o parrocchiali che implicano un contatto quotidiano e diretto con minorenni.
[24] Di nuovo, in questo senso, vorrei soffermarmi su tre situazioni che si desumono dal rapporto della «Missione speciale»:
- L’indagine dimostra che esistono gravi difetti nel modo di gestire i casi di delicta graviora, i quali corroborano alcuni dati preoccupanti che si erano cominciati a sapere in alcuni dicasteri romani. Specialmente nel modo di ricevere le denunce o «notitiae criminis», poiché in non pochi casi sono stati catalogati molto superficialmente come inverosimili quelli che erano gravi indizi di un effettivo delitto. Durante la visita si è altresì constatata l’esistenza di presunti delitti su cui si è indagato intempestivamente o perfino non si è mai indagato, col conseguente scandalo per chi li aveva denunciati e per tutti coloro che conoscevano le presunte vittime: famiglie, amici, comunità parrocchiali. In altri casi si è constatata l’esistenza di gravissime negligenze nella protezione dei bambini e bambine e dei bambini o bambine vulnerabili da parte dei vescovi e superiori religiosi, che hanno una speciale responsabilità nel compito di proteggere il popolo di Dio.
- Un’altra circostanza analoga che mi ha causato perplessità e vergogna è stata la lettura delle dichiarazioni che certificano pressioni esercitate su coloro che dovevano condurre l’istruzione dei processi penali, o finanche la distruzione di documenti compromettenti da parte di incaricati di archivi ecclesiastici, evidenziando così un’assoluta mancanza di rispetto per il procedimento canonico e, più ancora, pratiche riprovevoli che andranno evitate nel futuro.
- Sulla stessa linea, e per poter avvalorare il fatto che il problema non riguarda soltanto un gruppo di persone, nel caso di molti abusatori sono stati individuati loro gravi problemi risalenti già alla tappa di formazione in seminario o nel noviziato. Di fatto negli atti della «Missione speciale» constano gravi accuse contro alcuni vescovi o superiori che avrebbero affidato dette istituzioni educative a sacerdoti sospettati di omosessualità attiva.
[25] Eco di quell’atteggiamento paradigmatico che ci ricorda Gn 3,11-13: «“Hai forse mangiato dell’albero di cui ti avevo comandato di non mangiare?”. Rispose l’uomo: “La donna che tu mi hai posto accanto mi ha dato dell’albero e io ne ho mangiato”. Il Signore Dio disse alla donna: “Che hai fatto?”. Rispose la donna: “Il serpente mi ha ingannata e io ho mangiato”». Ci ricorda l’atteggiamento del bambino che guarda i suoi genitori e dice: «Io non sono stato».
[26] Cfr Francesco, Incontro con sacerdoti, religiosi e religiose…, cit., 16 gennaio 2018.