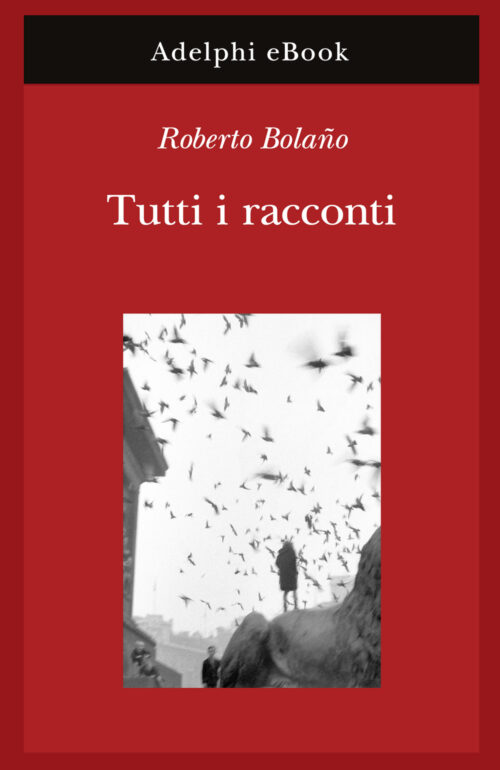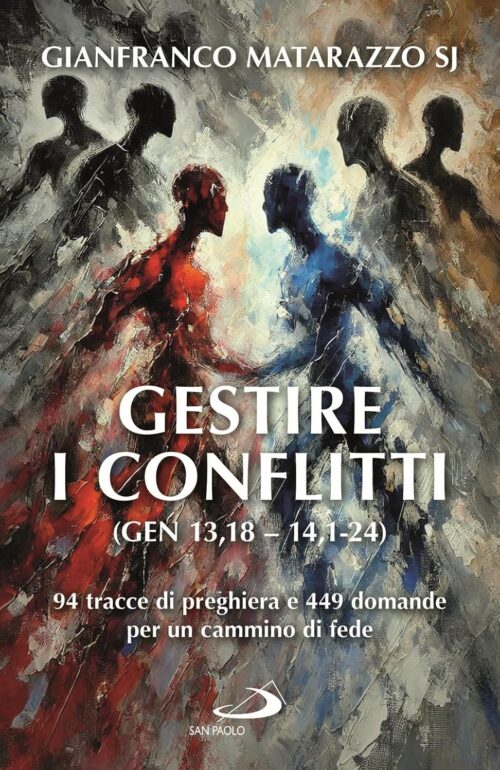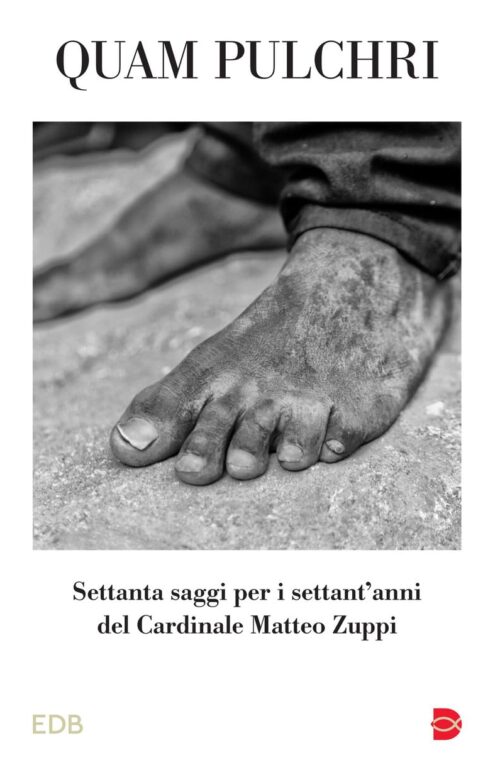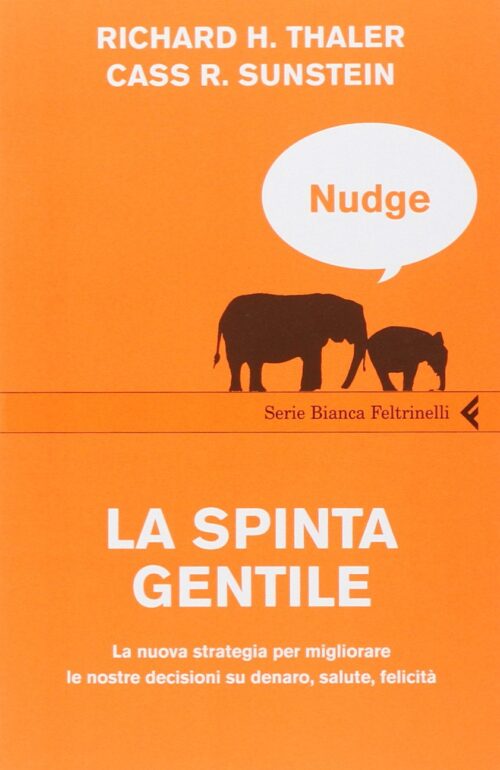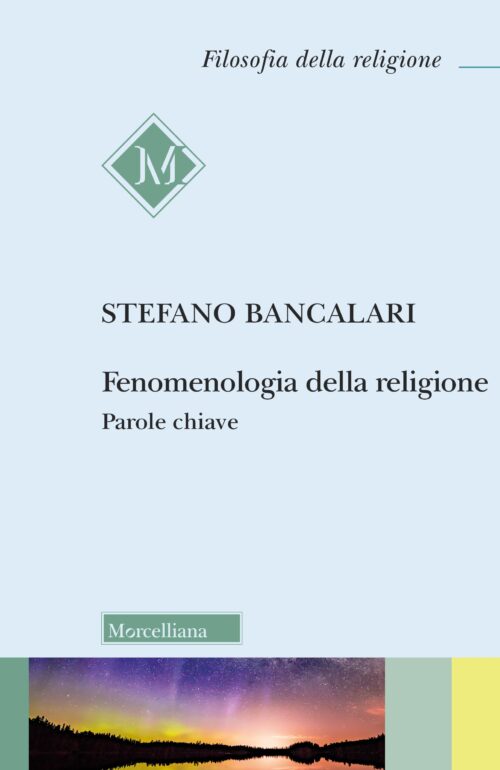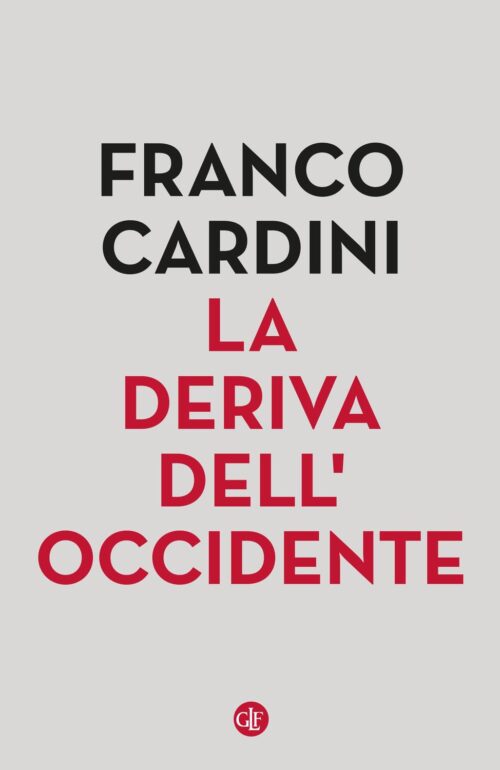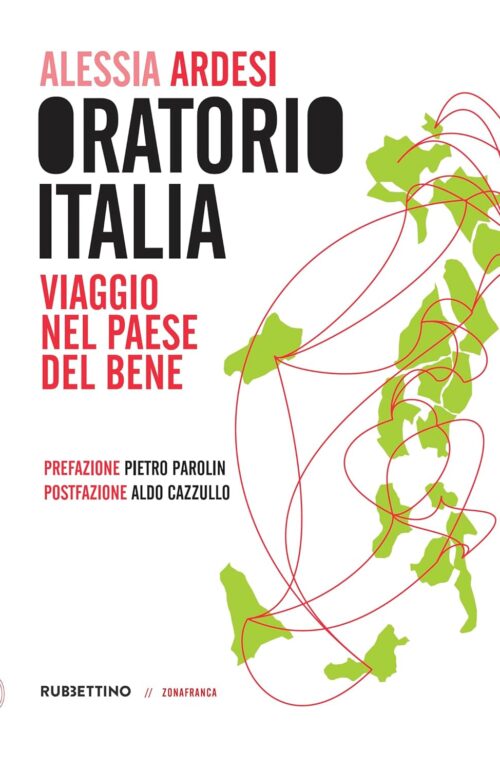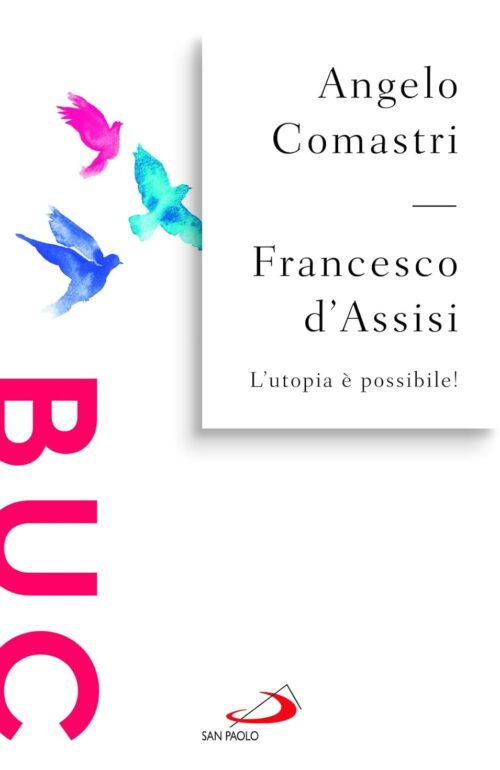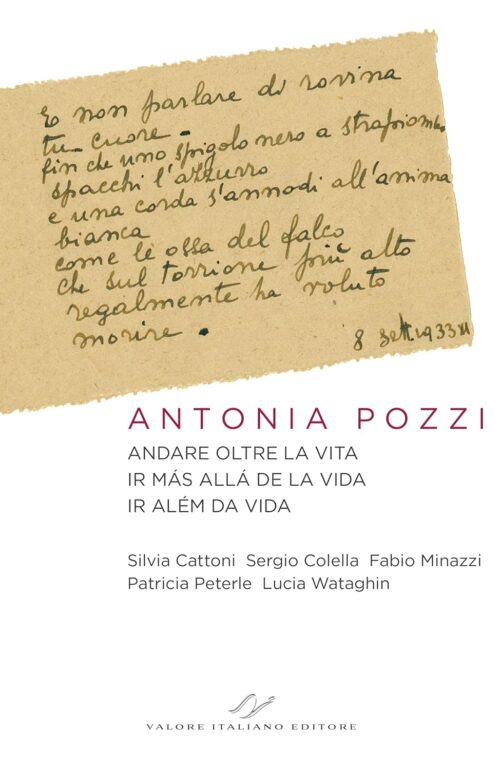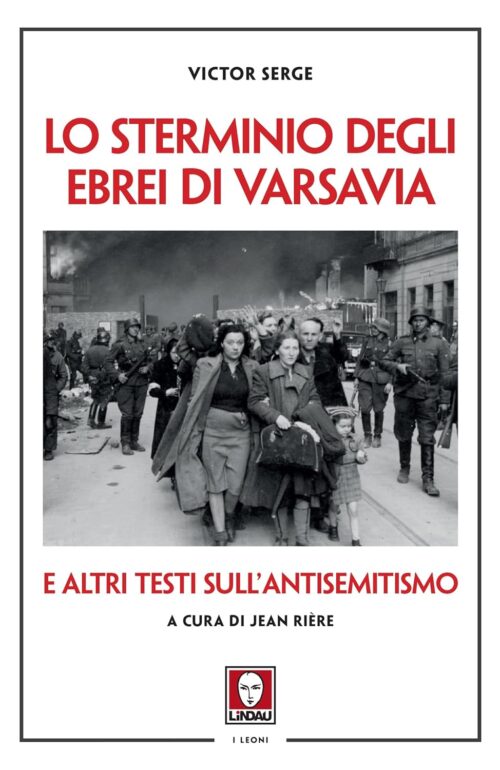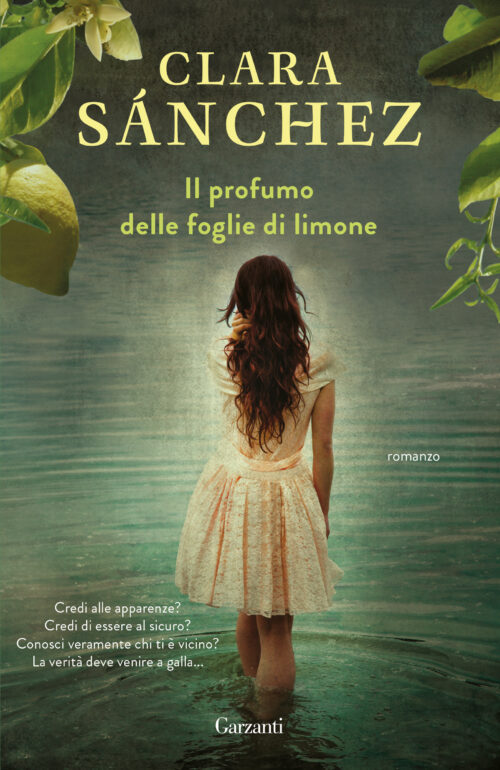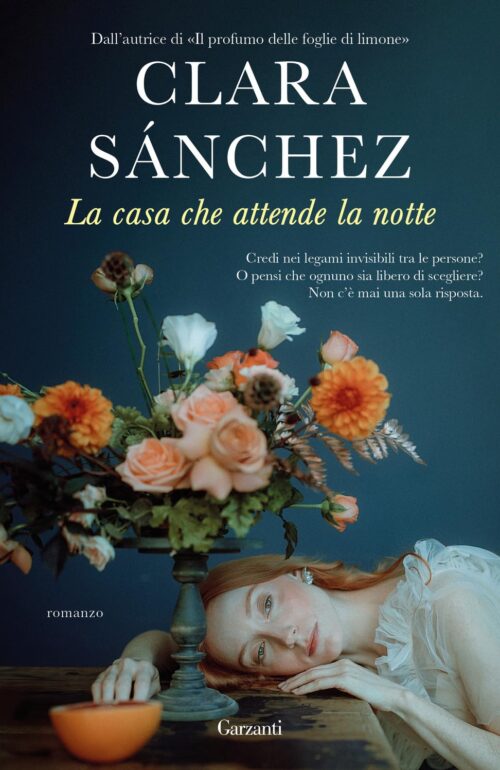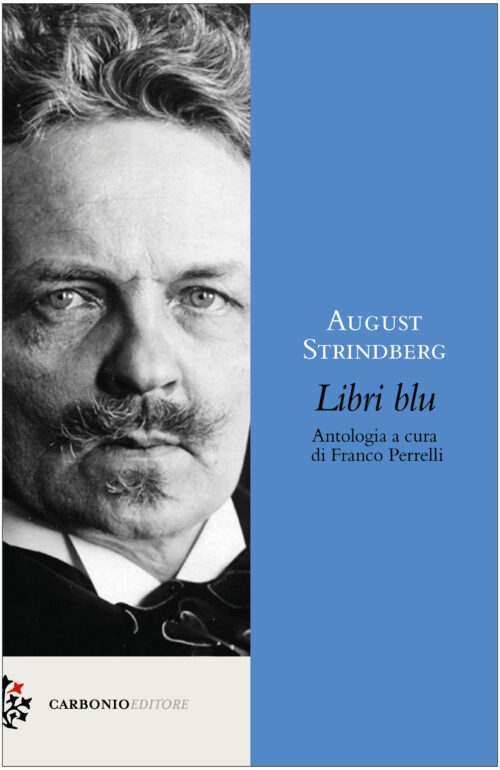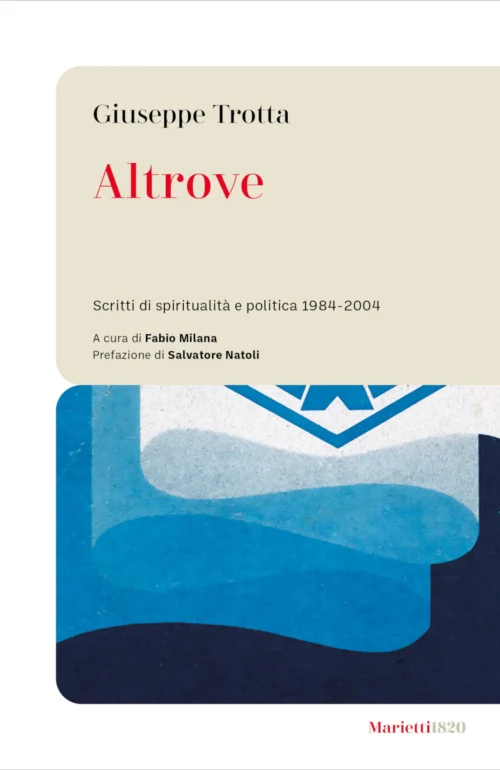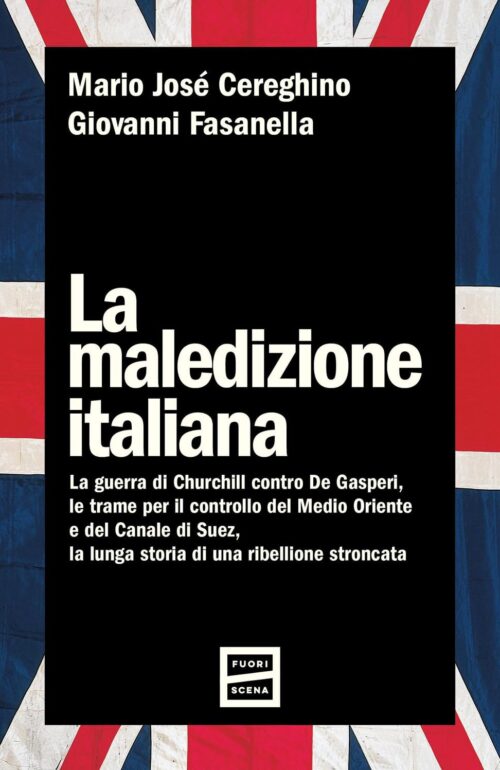The End, o il musical della fine del mondo, quindi film degli opposti – prima opera di finzione per il regista Joshua Oppenheimer –, è stato girato nel 2023 nelle miniere di salgemma Italkali in Sicilia, tra le più vaste d’Europa, in un set claustrofobico, da fantascienza, ed è proprio di questo che si tratta: è il racconto di una famiglia molto agiata che, per sopravvivere al disastro ambientale e a un conflitto che ha devastato la Terra, da vent’anni si è rifugiata in un bunker, in una miniera, dove ha portato una selezione di opere d’arte e ricchezze.
La storia è paradigmatica e universale; quindi, nessuno ha un nome (proprio); i personaggi di madre (Tilda Swinton), padre (Michael Shannon), amica (Bronagh Gallagher), maggiordomo (Tim McInnerny) e dottore (Lennie James) hanno tutti assaporato la vita all’esterno, mentre il più giovane, figlio (George MacKay), è cresciuto sottoterra, senza mai vedere altri esseri umani o la luce del sole. La loro routine prevede la contemplazione degli oggetti che sono riusciti a salvare, che però non fa che allargare sempre più l’enorme vuoto di figlio. Ma tutto cambia bruscamente, quando nel bunker arriva una persona dall’esterno: ragazza (Moses Ingram).
La fantascienza distopica è quindi inserita in un ambiente claustrofobico, reso sul grande schermo dall’ossimoro tra utilizzo della macchina da presa dinamico, come nel genere musical per assecondare le sequenze cantate e ballate, e uno più statico, quasi fisso, nelle altre scene.
L’ossimoro continua nella regolare ripetizione del salto tra temi drammatici, come la fine dell’umanità, la sopravvivenza in un ambiente deserto e sul punto di esplodere da un momento all’altro – un rumore di fondo costante che ci proietta verso un’estinzione ineluttabile – e l’esibizione della finzione propria del musical, con l’esplosione imprevista di canti e balli.
Lo spettatore è prigioniero in questa rete costruita da Oppenheimer che, a differenza dei tradizionali schemi di film apocalittici, si concentra non sugli eventi, ma sulle dinamiche interne tra i personaggi, come sospeso in un onirismo inquietante, che rende la visione elegantemente disturbante, seppur certamente originale. Infatti, l’eccellente cast, l’alta qualità stilistica dell’autore del lungometraggio data dalla ricercatezza compositiva e cromatica di ogni frame, arricchita dall’opulenza dei costumi di scena di Swinton (madre), dai quadri di Renoir o dai dolci consumati ogni giorno, tutte autentiche delizie non solo del palato, ma anche del gusto estetico e filmico, sono godibili pur nel permanente senso di orrore e vuoto inteso come «assenza dell’Umano in quanto persona e senso dell’Altro».
Questa costante convivenza degli opposti, unita alla continua divergenza tra balli, canti e dramma della fine dell’esistenza così come la conosciamo, risulta straniante, affascina e sconvolge come lampi di una tempesta distante, dall’altra parte del promontorio, quando un brivido sottile e un’attrazione latente ci attraversano. Difficile forse da reggere per l’intera lunghezza del film, che richiede un reale impegno da parte dello spettatore nell’accompagnarne il percorso e l’effetto-specchio che ne è il cuore.
La famiglia è tutto, come la parte finale del film ribadisce, ma ovunque, anche in situazioni estreme, l’homo sapiens conferma il suo naturale istinto di salvare sé stesso, annullando l’altro, cioè l’Umano: homo homini lupus.
Un film necessario? Per esserlo, dovrebbe essere oggetto di visione, non solo da parte di addetti ai lavori o critici. La sensazione è che, almeno al suo passaggio nelle sale, al di là delle proiezioni esclusive e masterclass, sia mancato proprio il suo specchio, il pubblico. Noi no. Confidiamo nella visione in streaming.