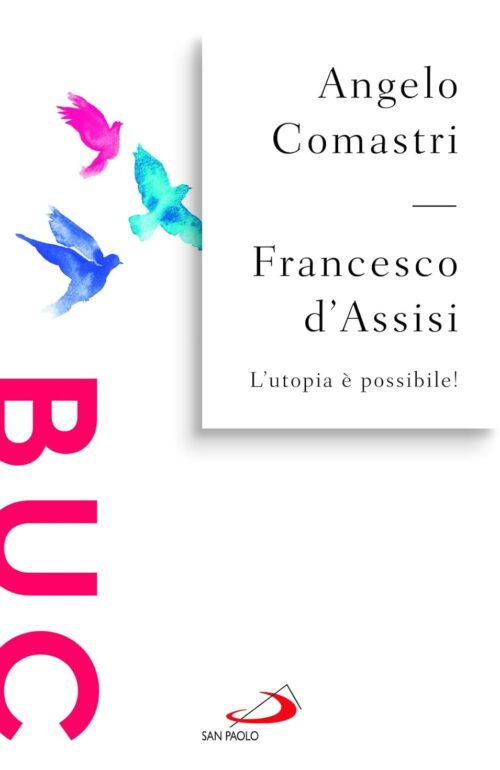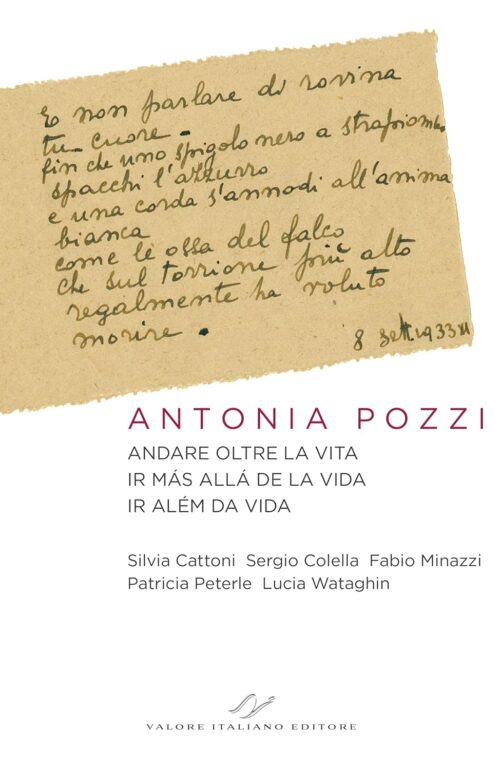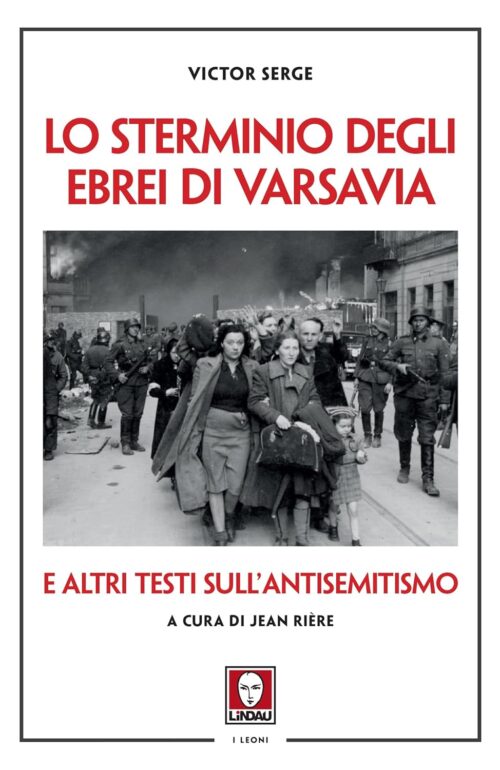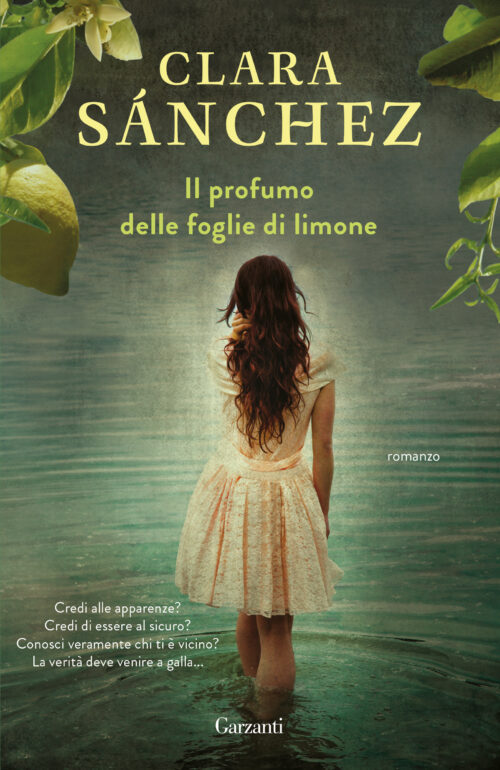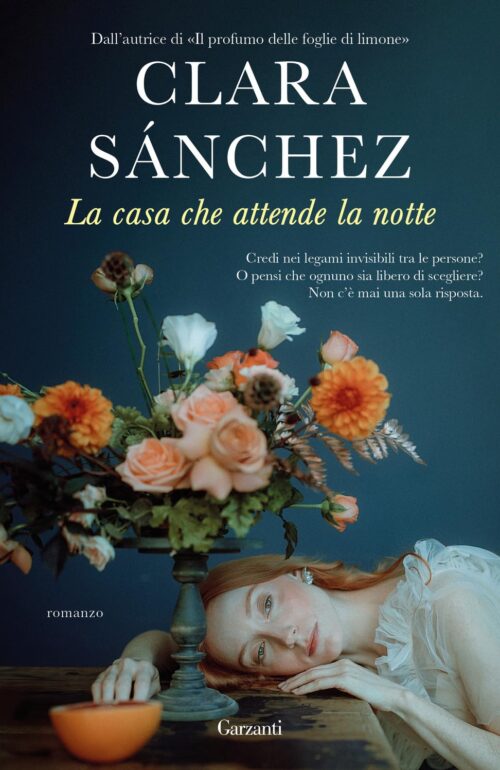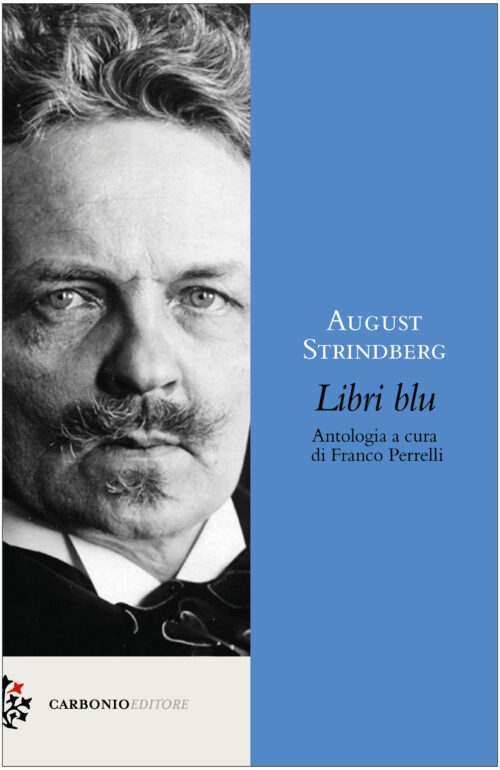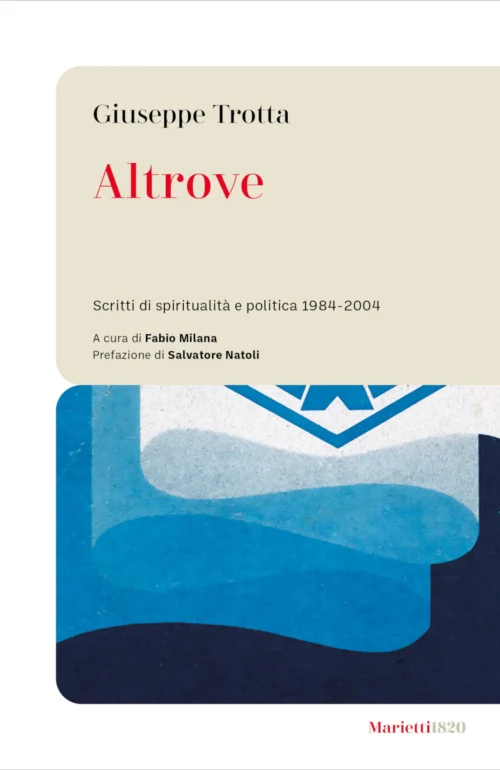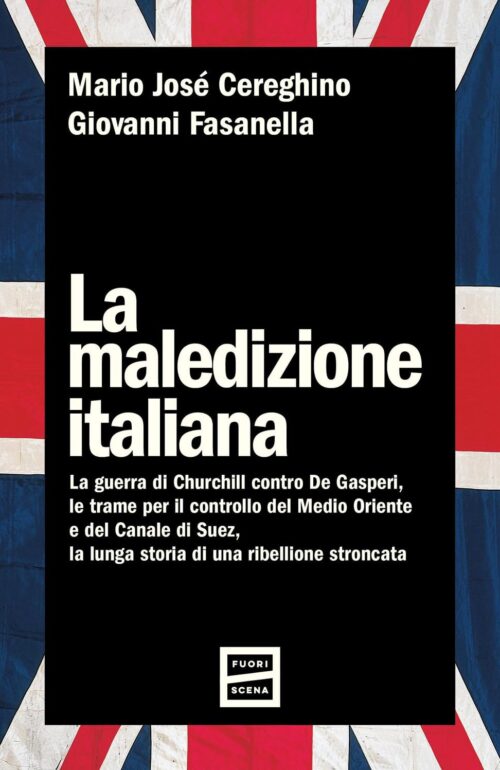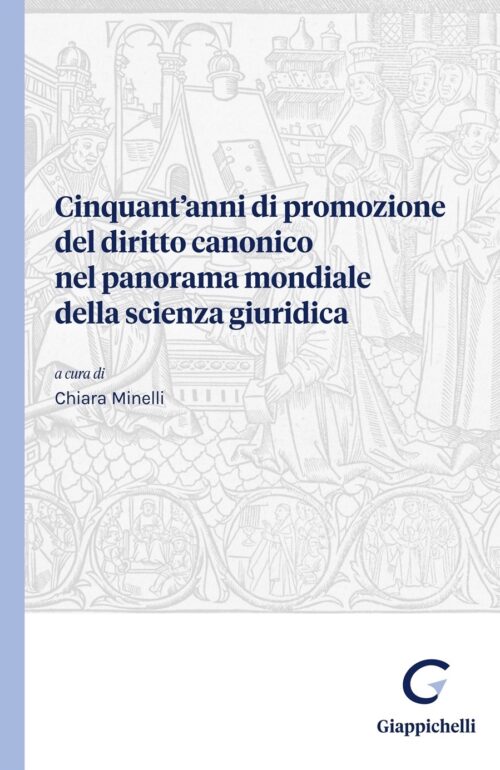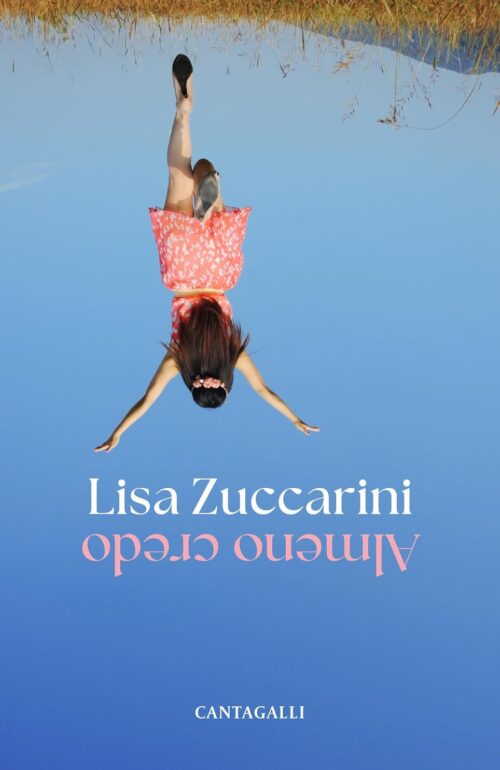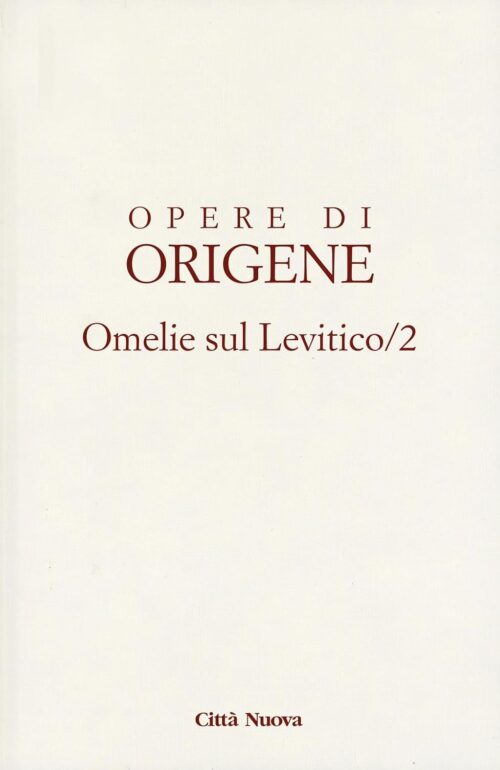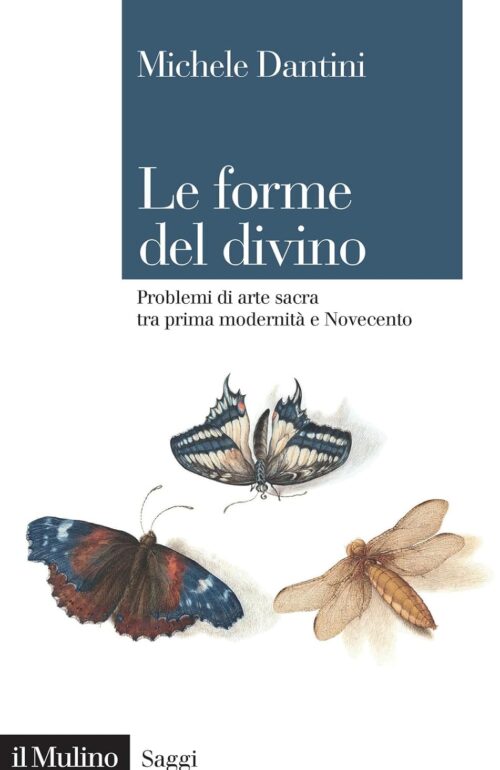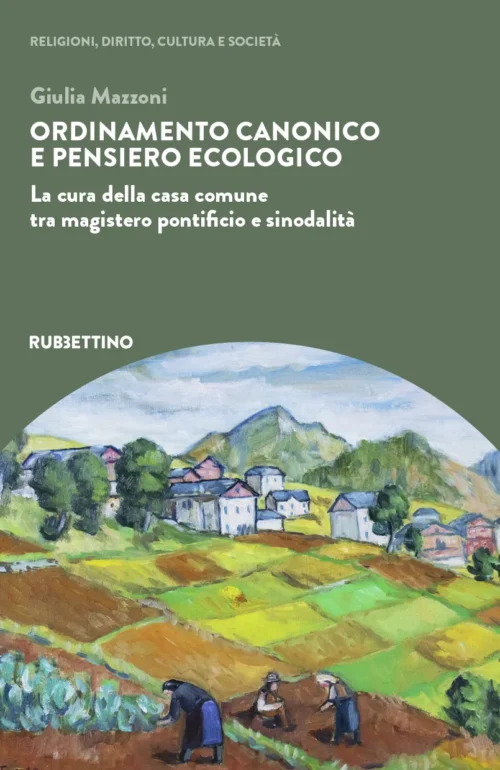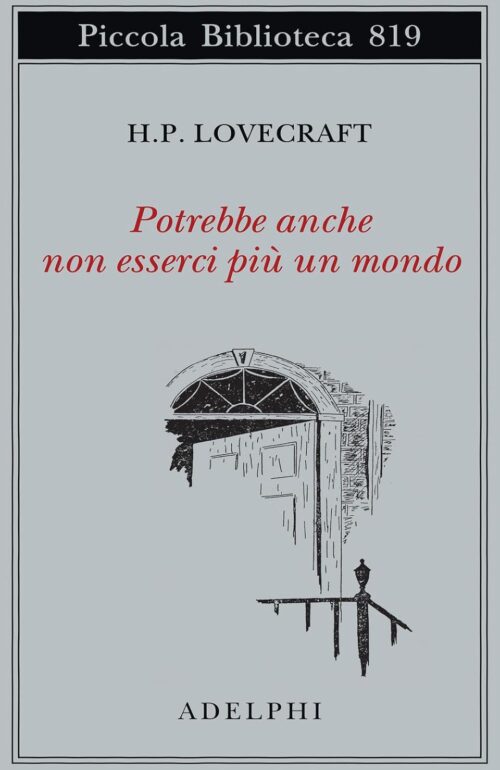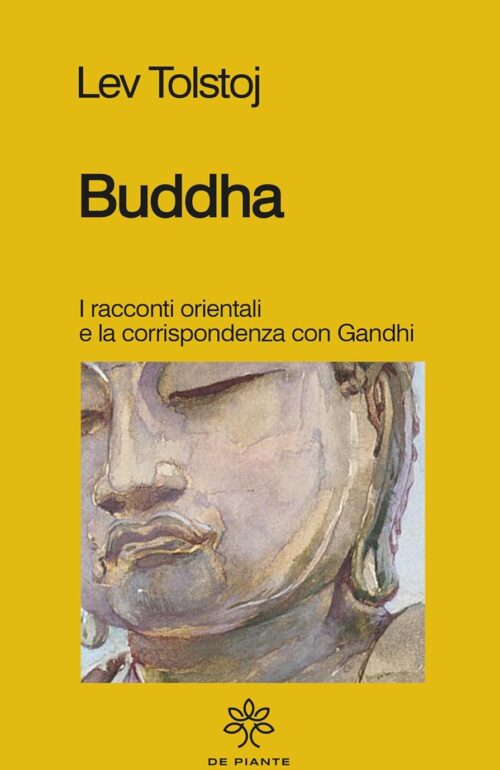Italia, 1936. Emilio è un bambino fantasioso, con la passione per Sandokan. Un giorno crede di vederlo davvero, quando suo padre, podestà fascista, cattura e rinchiude in una voliera nel giardino di casa sua il principe africano Abraham Imirrù. A Emilio non sembra vero: finalmente potrà conoscere da vicino un eroe, ma suo padre, i suoi colleghi e tutto il suo paese non lo guarda allo stesso modo. Il razzismo è dilagante, come la violenza su chi è considerato «diverso».
Cos’è più forte della paura? L’immaginazione. I libri. Questi i cardini di Ho visto un re, storia fantastica contro la xenofobia, ispirata da una storia vera, quella di Nino Longobardi, futuro giornalista, ancora bimbo ai tempi della Campagna d’Africa, che si vede arrivare un prigioniero etiope nel suo paese d’origine. Siamo ai tempi del fascismo e della guerra.
Tra adulti che vivono di illusioni e bimbi che fanno di quell’illusione una realtà immaginaria, alternativa, si snoda il racconto del lungometraggio di Giorgia Farina, che «spariglia» le carte, mettendo al centro lo sguardo di un innocente, rendendo straordinario un ordinario percorso di scoperta e di crescita. Quella di Emilio, ragazzino di 10 anni appassionato dei romanzi di Salgari, che quindi nella sua mente vive a metà tra Mompracem e Roccasecca, suo luogo natìo.
Tutto parte proprio da qui, da questa tranquilla cittadina di provincia, dove nel 1936 la vita scorre pigramente tra slogan mussoliniani, bambini divisi tra Balilla e Piccole italiane, donne relegate al ruolo di mogli e madri e podestà pervasi dalla retorica di regime e dall’entusiasmo generale per la conquista dell’Etiopia, in un fervore coloniale senza precedenti. L’Africa è un luogo mitico e lontano, terra di conquista e mistero.
La vita del piccolo paese laziale è «accesa» dall’arrivo del «confinato» Abraham Imirrù (Gabriel Gougsa), un ras etiope rinchiuso in una voliera nel giardino della villa del padre di Emilio (Marco Fiore), il podestà Marcello (Edoardo Pesce). È lui il motore del racconto insieme allo sguardo innocente del bambino, che non vede un prigioniero, o uno «scimmione puzzolente», bensì il suo eroe, lì, davanti a sé, in carne e ossa: Sandokan.
Tra federali e fascisti ridotti a macchiette umane, propaganda di regime grossolana, rozza, basata sull’assenza di conoscenza dell’altro, del diverso da noi, la chiave di lettura è nello sguardo puro, senza filtri, di Emilio e del suo amore per la letteratura d’avventura. Così la realtà si trasforma: si apre la gabbia materiale e metaforica delle menti, degli spiriti più ottusi, come quello del podestà razzista e chiuso (l’unico personaggio che non si evolverà per tutto il film) o del federale Trocca, ancora più «prigioniero» del pensiero fascista, «villain», reso da un eccellente Gaetano Bruno, e si è capaci di guardare all’altro come a un nostro simile, un essere umano.
Farina, alternando il registro della commedia e del grottesco, utilizzando la fantasia come grimaldello per scardinare la brutalità del reale, non solo propone una critica alla dittatura fascista, ma, in una visione più ampia, indica quanto chi è ai margini della società in realtà abbia un pensiero libero, lucido e «irridente» sul mondo. I temi del colonialismo, dell’odio razziale, dell’identità sono attraversati sempre con levità, grazie all’immensa meraviglia e al potere dell’immaginazione di Emilio. Tra registro fiabesco e realistico, il film inquadra con accuratezza il periodo storico, rimanendo sui tratti del sognante e del naïf. È interessante, anche per una carezza interiore: all’essere umano è dato evolversi, a patto però di mantenere il cuore aperto, e il resto verrà da sé; non saremo più soli su quel vascello che avanza intrepido verso l’avventura più grande, la versione migliore di noi stessi.