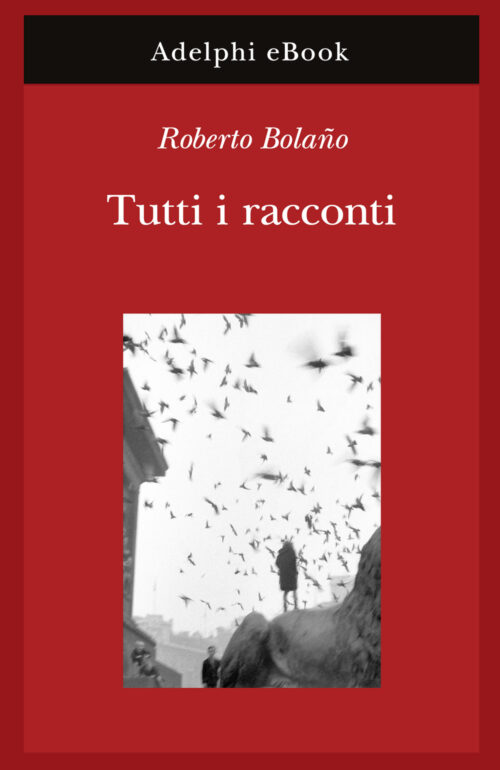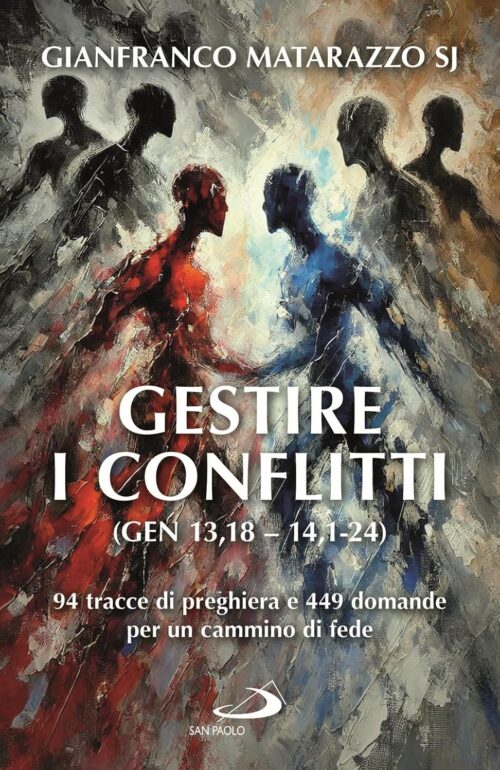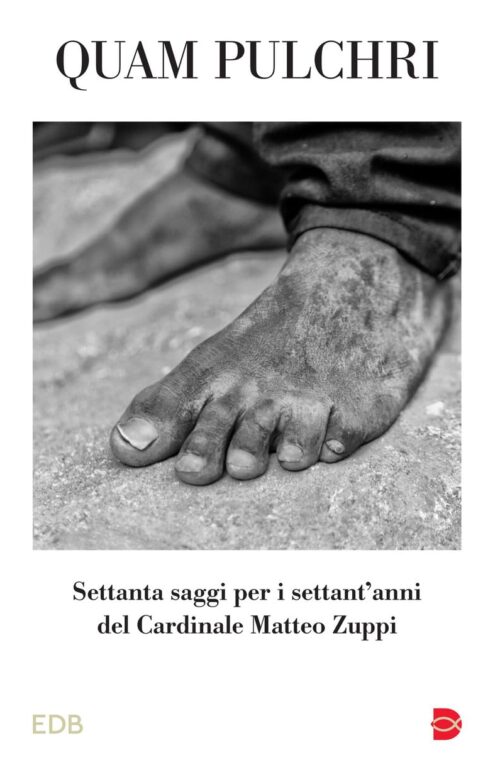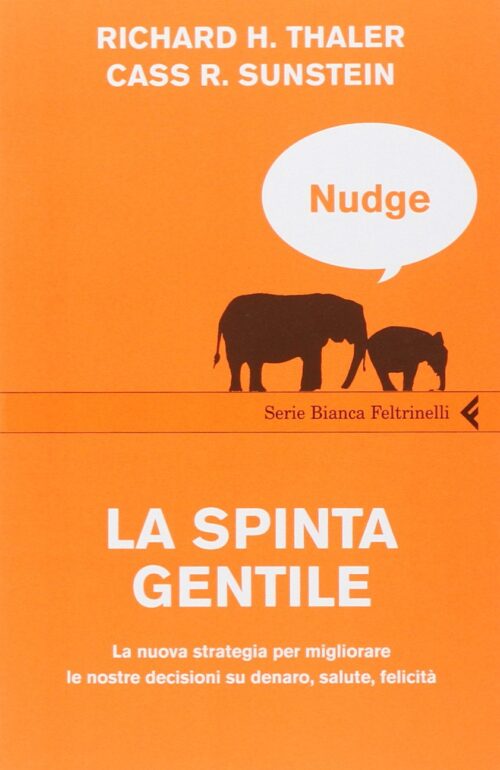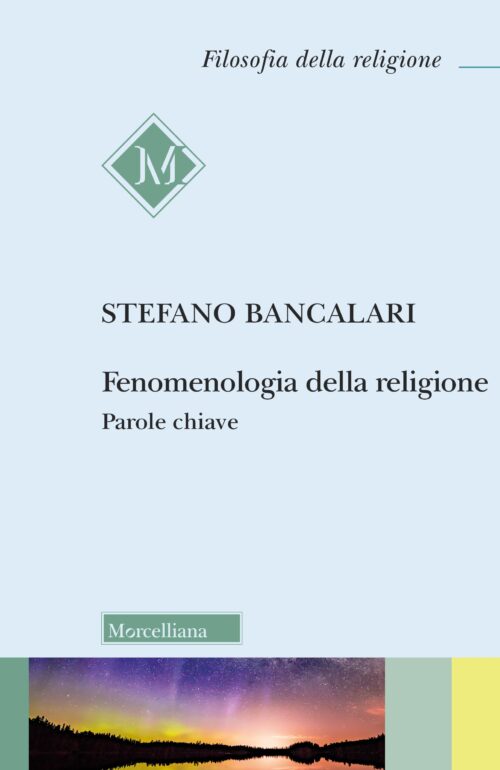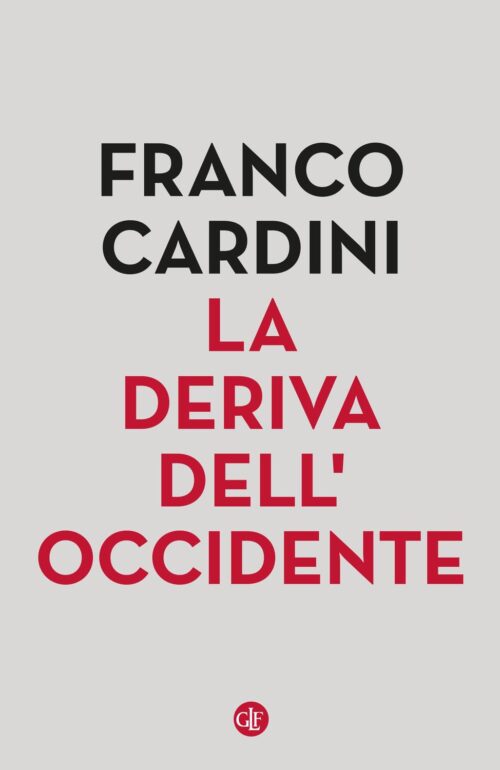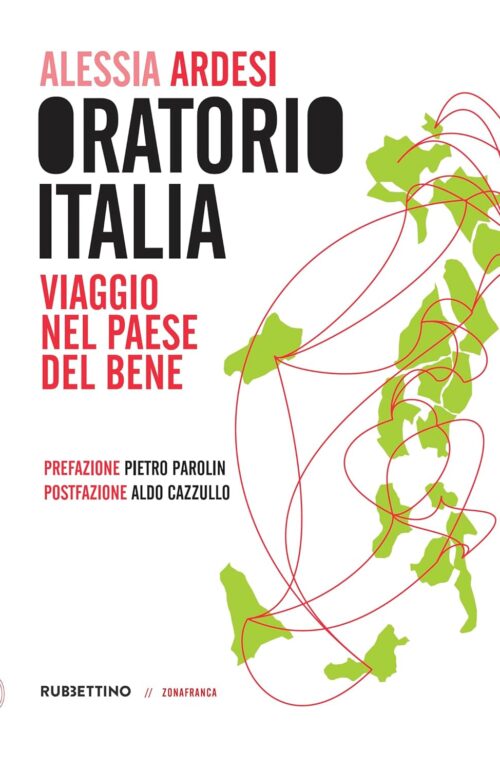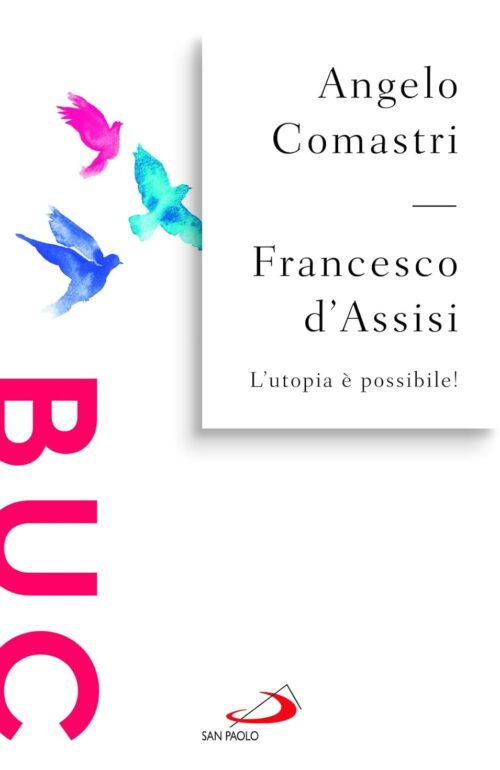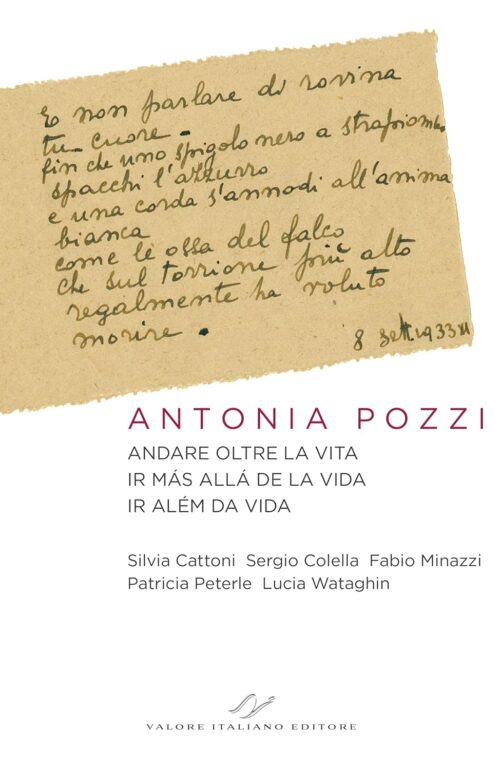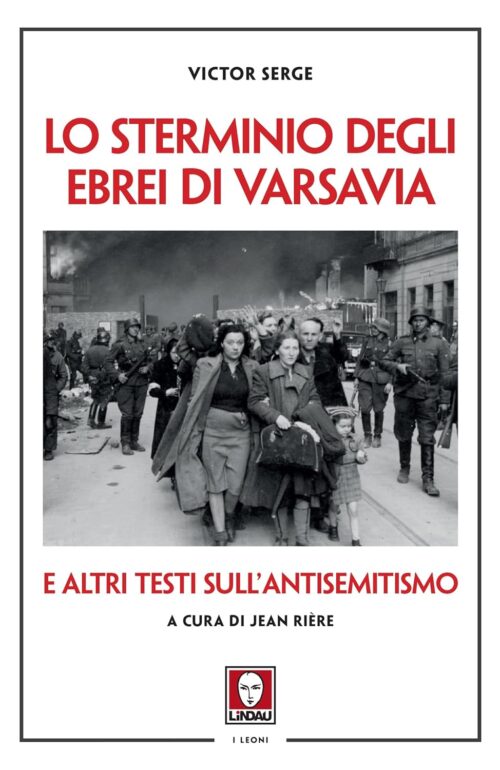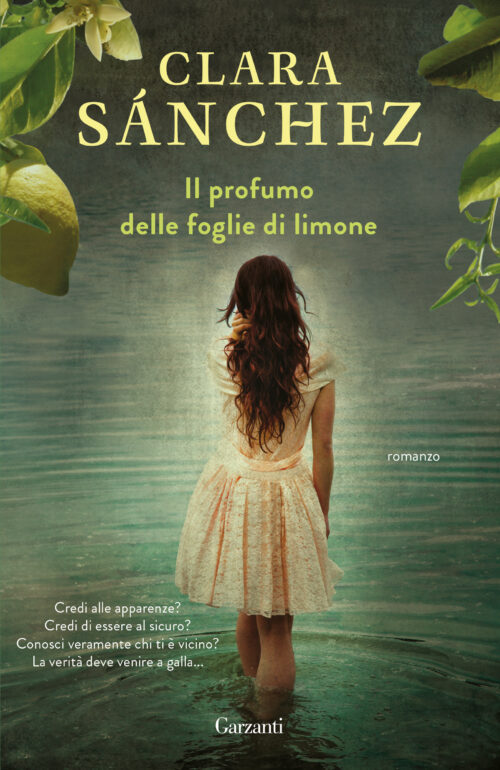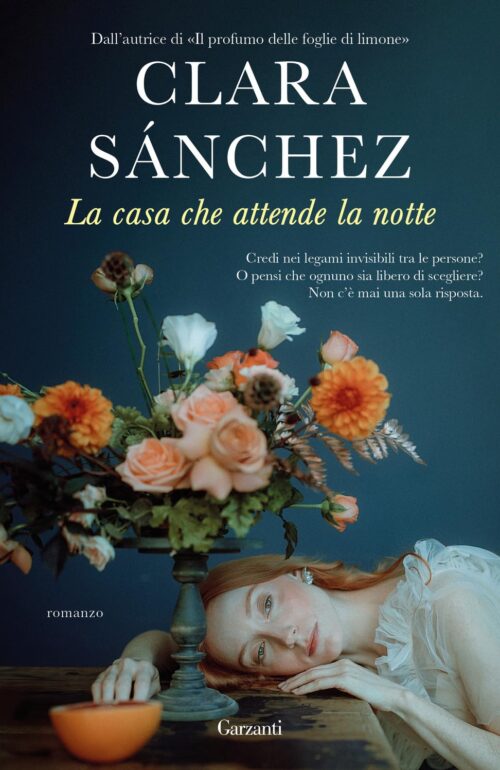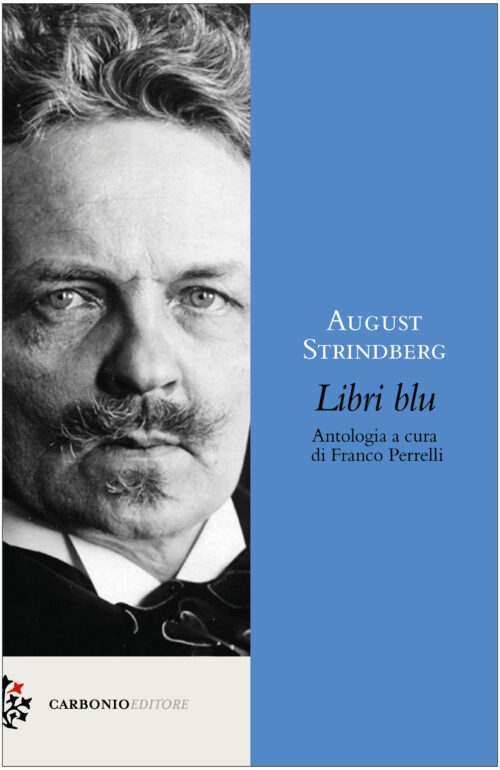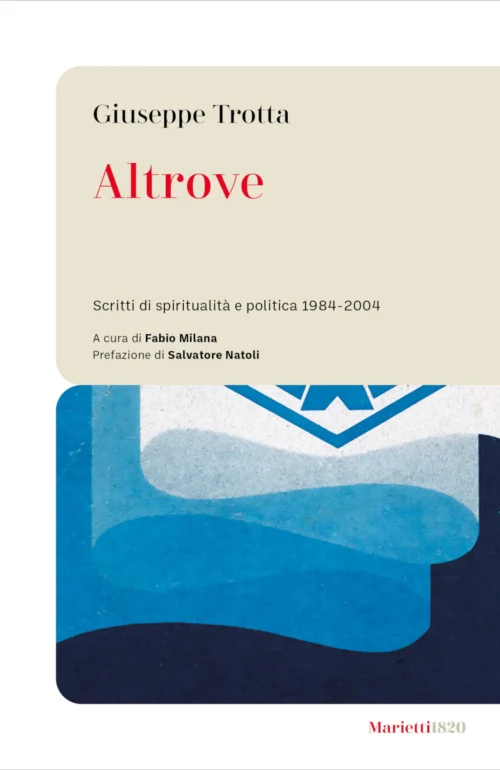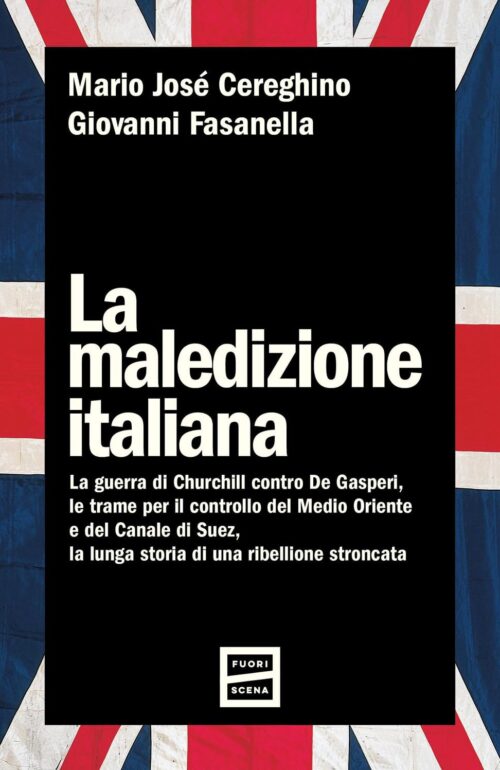Nel cuore del centro storico di Salerno si nasconde un locus amoenus: il Giardino della Minerva, incastonato nell’antico quartiere Plaium montis, così chiamato perché sviluppato lungo il monte su cui sorge il Castello Arechi, che silenziosamente veglia sull’intera città.
Fin dall’antichità, Salerno era rinomata per il suo carattere florido, per i verdi terrazzamenti e gli abbondanti corsi d’acqua, che dal monte scendevano al mare. Centro nevralgico del Meridione, nei suoi porti si incontravano Oriente e Occidente: proprio da questo crocevia culturale tra arabi, cristiani ed ebrei nacque la Scuola Medica Salernitana. Nota già nel IX secolo, essa fu la prima università di medicina – aperta anche alle donne! – e una delle istituzioni accademiche più antiche e innovative.
Il Giardino, strutturato su cinque terrazzamenti, ha origini remote: appartenente alla famiglia Silvatico dal XII secolo, fu trasformato in «Giardino dei semplici» nel 1300 da Matteo Silvatico, maestro della Scuola Medica Salernitana e autore dell’Opus Pandectarum Medicinae (un lessico sui semplici di origine vegetale, minerale e animale). In quanto giardino «di studi», vi si coltivavano piante da cui ricavare princìpi attivi a scopo terapeutico.
La fase medievale, tuttavia, si troverebbe a circa due metri di profondità rispetto all’attuale piano di calpestio. L’aspetto odierno richiama la struttura seicentesca, epoca in cui il giardino passò a Diego del Core, che lo descrisse in un atto notarile di acquisto. Oggi queste due anime – quella medica e quella estetico-barocca – convivono nel Giardino della Minerva, offrendo una vista sulla città davvero unica.
L’odore delle piante solletica piacevolmente l’olfatto; le forme e i colori stimolano la vista; il suono dell’acqua che attraversa i terrazzamenti addolcisce l’udito e calma la mente. La visita, tuttavia, non si limita al piacere sensoriale: si ha l’occasione di studiare le piante proprio come accadeva per i medici antichi. La loro suddivisione segue la teoria della Scuola, la «dottrina dei quattro umori», che dal 500 a.C. rimase in uso fino alla rivoluzione di Virchow del 1858. Gli umori (sangue, bile gialla, bile nera e flegma) si combinano con gli elementi (aria, terra, fuoco, acqua) attraverso le qualità condivise: caldo, freddo, umido, secco. La malattia, secondo queste teorie, nascerebbe dallo squilibrio di tali elementi; la preoccupazione dei medici, allora, era di ristabilire l’armonia.
Un mondo affascinante quello del Giardino della Minerva, in cui la natura segue una geometria sapienziale, in cui riverbera quel senso di sacro, insito nel legame tra l’essere umano e il creato, entrambi governati da una stessa logica armonica.
Il giardino è sempre un hortus conclusus, è la versione migliore e migliorata di ciò che conosciamo, è uno spazio delimitato in cui ordine e cura rispondono ai bisogni dell’animo. Dall’esperienza viva del giardino si imprime un ricordo che può riaffiorare ogni volta che ci si trova davanti a un giardino reale o dipinto; perché fare esperienza dell’armonia trasforma la memoria in «memoriale». Didi-Huberman – scrivendo a proposito dell’hortus conclusus nelle Annunciazioni – guida l’osservatore così: «Osserva il giardino […], perché occorre che l’occhio dell’amore “scavi” quel giardino, o meglio vi si annidi. In quel momento, nel fondo della terra dai colori confusi, troverai la Scrittura, vale a dire il suo senso spirituale; e quanto scoprirai con la profondità della Scrittura sarà la protensione della tua stessa coscienza, la tua personale capacità di virtù, la geografia della tua anima» (G. Didi-Huberman, Beato Angelico. Figure del dissimile, Milano, Abscondita, 2009, 268). Il Giardino della Minerva è dunque un luogo ideale per interrogarsi sull’armonia: con la natura, col mondo e con Dio.