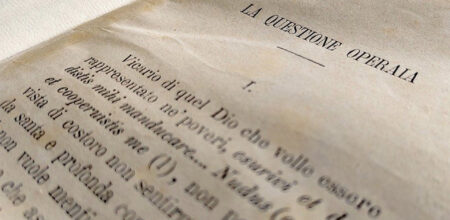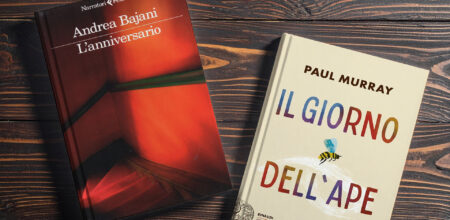| |
Il grande problema del male, del che cosa è, da dove viene, e perché esiste, è al centro non solo del dibattito della teologia, ma anche delle umane reazioni di fronte alla sofferenza.
In questo libro, Paolo Marino Cattorini, filosofo e già docente di Bioetica clinica all’Università dell’Insubria, affronta questo abissale interrogativo. Lo fa ripercorrendo il cammino delle interpretazioni dell’Antico e Nuovo Testamento, di san Paolo, di sant’Agostino, della filosofia (in particolare Schelling e Pareyson).
È un’antica questione che sfiora anche interpretazioni lontane dalle fonti citate: ad esempio, il teismo, vale a dire l’ammissione che ci possa essere un Dio persona e una sua rivelazione; il deismo, che è invece il semplice riconoscimento di un ente supremo creatore dell’universo; non ignorando le tesi dualistiche e manichee, secondo le quali il bene (lo spirito) e il male (la materia) sono due princìpi radicalmente distinti.
Ma, al di là di ogni pretesa ideologica, si staglia come presenza risolutiva la figura del Cristo: egli è icona del Dio che redime attraverso il suo sacrificio e che è «un Dio della vita» (p. 53).
Il fatto è che la tentazione di ripiegarsi in giustificazioni unicamente razionali è destinata a insabbiarsi di fronte al limite della parzialità delle interpretazioni, e soprattutto delle disquisizioni sottili che rischiano di diventare fini a sé stesse. E infatti emerge qui il punto di vista dell’A.: Dio è sentito come Padre e come un «Alleato affidabile e libero» (p. 85).
Si arriva così all’enigma di un male che esiste nonostante la fede in quella paternità amorevole. Perché questo amore oltrepassa i limiti dell’umana comprensione e si inoltra, come nel caso della consegna della stessa paga a operai che hanno lavorato per un numero diverso di ore (cfr Mt 20,1-16), nel mistero di un concetto di giustizia, quella divina, assai differente da quella della ragione umana.
Ma proprio perché il punto di vista umano è limitato, l’A. suggerisce che la presenza del male nel mondo non può essere unicamente legata all’evidente debolezza umana, ma a qualcosa di più profondo. E qui si apre una questione che investe la responsabilità divina, fino a far ipotizzare che il male possa «esistere prima dell’inizio dell’attività di YHWH» (p. 94).
Dio permette il male? O il male è una componente enigmatica che ha a che fare con la stessa essenza divina e rappresenta, tra le varie ipotesi, la tentazione a ripiegarsi su sé stesso, rinunciando ad accompagnare l’uomo per la sua strada terrena? O forse Dio si comporta come un medico che, non avendo una medicina risolutiva per ogni patologia, può solo piangere «assieme a noi che piangiamo»? (p. 99).
Quello che emerge da alcune pagine di questo libro è l’affascinante immagine di una divinità che, muovendo da una base fatta di tenebra primordiale, viene incontro alla sua creazione in uno slancio di amore assoluto. Il male è forse quella tenebra – afferma Cattorini, citando alcuni autori –, quella tentazione a tornare all’isolamento, a «l’essere-in-sé-e-per-sé». La presenza di un Grund, ossia di un fondamento abissale, potrebbe essere interpretata, secondo alcuni, come la fonte primordiale del male.
E fa bene l’A. a individuare i limiti delle interpretazioni citate e a ricorrere alla dimensione dell’icona attraverso la mediazione di Jean-Luc Marion (anche se altri, tra i quali Florenskij ed Evdokimov, hanno offerto fondamentali interpretazioni sul fascino dell’apparente semplicità dell’icona): essa rivolge su di sé l’attenzione di chi guarda, e nello stesso tempo è essa stessa che guarda, guidando nel passaggio della soglia tra il visibile e l’invisibile.
L’abbandono a Dio è uno dei modi per ritrovare il Senso primigenio dell’esistenza, anche quando, come nel Salmo 22, tutto sembra perduto.