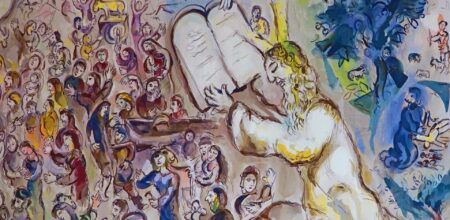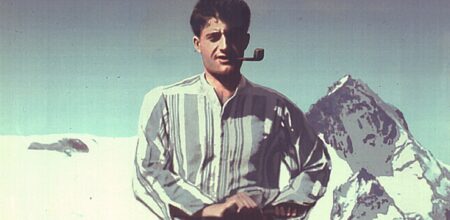|
|
I tre saggi di questo libro sono i testi di altrettante conferenze tenute da James Buchanan, Premio Nobel per l’economia del 1986, presso l’Università dell’Oklahoma nel 1961, poi pubblicati nel volume Ethics and Economic Progress.
L’A., celebre per essere stato il fondatore della scuola economica della Public Choice, presso l’Università della Virginia, in questi saggi affronta il tema del valore economico delle norme etiche.
Per avvalorare la sua tesi di fondo, secondo cui i vincoli etici e morali delle condotte umane hanno rilevanti effetti economici, Buchanan articola il suo ragionamento secondo tre passaggi nodali, ognuno dei quali costituisce il focus dei rispettivi saggi.
Nel primo, volto a illustrare l’etica del lavoro, l’A. sottolinea come il lavorare di più sia una scelta apportatrice di benessere non solo per i singoli che l’hanno adottata, ma anche per l’intera società.
Il secondo passaggio, centrato sull’etica del risparmio, mostra come l’orientamento degli individui ad accrescere la propria quota di reddito destinata al risparmio si riveli, a determinate condizioni, un fattore significativo di propulsione per il benessere collettivo.
Nel terzo saggio, più che occuparsi di una specifica caratteristica del comportamento individuale, Buchanan vuole dimostrare come l’inculcare in una società norme orientate a lavorare di più e a risparmiare di più produca risultati positivi, misurabili in termini di valore economico. Una tesi che giustificherebbe, per l’A., i costi sopportati da quella società per pagare le persone e l’apparato («il predicatore») necessari per favorire la penetrazione delle norme nel suo tessuto ordinamentale.
Un primo merito di questo libro senza dubbio è costituito dall’attualità del richiamo a valori etici, spesso trascurati, in un panorama economico dominato dall’esclusiva massimizzazione del profitto a beneficio di un numero ristretto di operatori e dalla pervasività di un’innovazione tecnologica, presentata anche in forme di prevaricazione sull’uomo.
Un secondo merito dell’A. è quello di aver mantenuto la sua promessa di evitare l’uso di un’analisi economica tecnica, rendendo così accessibile il proprio ragionamento e le sue implicazioni politiche a una platea ben più vasta dei soli economisti. Anzi, a questi ultimi non viene risparmiata la stoccata di una rigidità intellettuale legata alla loro specializzazione professionale, che pregiudicherebbe l’accettazione delle loro tesi.
Infine, un terzo merito di questo libro è l’arricchimento offerto al lettore dall’Introduzione di Alberto Mingardi, ordinario di Storia delle dottrine politiche presso lo IULM di Milano. Essa è utile per comprendere non solo il contesto storico e scientifico in cui si sono svolti gli studi di Buchanan, ma anche la sua formazione pluridisciplinare, il valore del suo contributo allo sviluppo della scienza economica e, in particolare, la validità della configurazione – che va al di là del singolo periodo storico – di una società che per il suo benessere sopporti di buon grado di «pagare il predicatore».