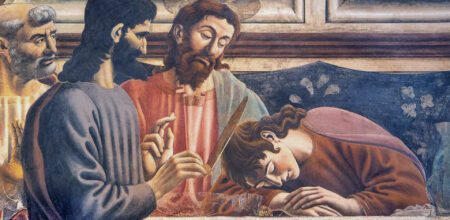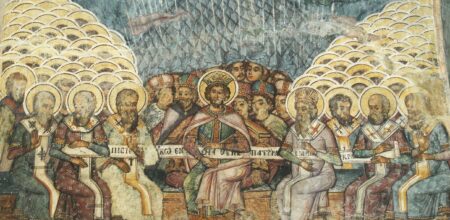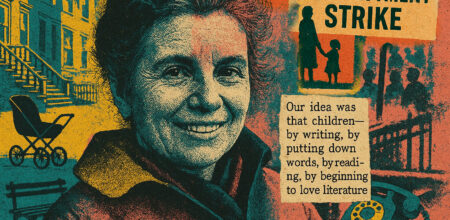|
|
Gli ultimi due decenni del XX secolo e i primi tre del XXI hanno scandito e stanno scandendo l’inesorabile, progressiva crescita del debito pubblico italiano: un fenomeno che si pone come un macigno sul percorso di sviluppo del Paese e lo caratterizza in negativo nei confronti internazionali con le economie degli altri principali competitors europei e del mondo intero. Ma cos’è esattamente il debito pubblico, come e quando si è andato formando nel corso della storia economica italiana, cosa si può fare per riposizionare correttamente la nostra economia, liberandola gradualmente da una zavorra così ingombrante?
Sono questi i principali interrogativi a cui prova a rispondere, con chiarezza concettuale e con l’utilizzo di uno stile agile, questo libro, scritto da Giorgio Di Giorgio, professore di Teoria e Politica economica presso l’Università Luiss Guido Carli di Roma; Alessandro Pandimiglio, associato di Economia politica presso l’Università Gabriele D’Annunzio di Chieti – Pescara; e Guido Traficante, associato di Politica economica presso il già citato Ateneo romano.
Il libro, esito di un’iniziativa promossa nell’ambito di un progetto sul debito pubblico avviato dalla Fondazione Ave Verum, costituita da Michele Rinaldi, imprenditore attivo nel settore assicurativo, offre al lettore una ricostruzione di questo fenomeno, articolata in quattro parti.
La prima parte si concentra sulle definizioni e sulle implicazioni teoriche che caratterizzano il tema del debito pubblico, con considerazioni utili a facilitarne la comprensione da parte del lettore.
Segue, nella seconda parte, una ricostruzione storica, che va dal momento dell’unificazione dell’Italia nel 1861, per giungere ai giorni nostri, in un contesto allargato al più ampio scenario internazionale. Vengono così individuati i momenti salienti della crescita del debito pubblico del nostro Paese e, in particolare, quelli in cui si sono registrate le sue impennate più significative.
Molto utili risultano le pagine della terza parte, dedicate a smontare alcuni miti legati al debito pubblico, alcuni dei quali ispirati a una superficiale e mal intesa interpretazione del pensiero keynesiano in tema di efficacia della spesa pubblica. Significativo risulta l’esempio di quanto avvenuto nello scorso decennio in Grecia, con un debito pubblico andato fuori controllo e un conseguente conto, particolarmente salato, fatto pagare all’intera collettività di quel Paese.
Nella quarta parte si illustrano le modalità con cui porre sotto controllo la crescita del debito pubblico per avviare un percorso di graduale riduzione. Indicazioni di aggiustamento, che possono essere integrate con i suggerimenti preziosi al riguardo – accolti in una delle due appendici del libro –, formulati da sei autorevoli economisti: Lilia Cavallari, Elsa Fornero, Giampaolo Galli, Stefano Micossi, Gustavo Piga e Paola Profeta.
Nell’altra appendice, viene presentata la formalizzazione matematica dell’identità relativa al rapporto tra debito pubblico e prodotto interno lordo, con i successivi passaggi utili a individuarne le condizioni di sostenibilità nel medio-lungo periodo.
In definitiva, nonostante la tecnicità dell’argomento trattato, questo libro sembra cogliere l’obiettivo di diffondere presso un pubblico ampio la conoscenza e le possibili soluzioni di un problema che, toccando, oltre che le condizioni economiche, la qualità della vita, ci riguarda tutti molto più da vicino di quanto comunemente si è portati a pensare.