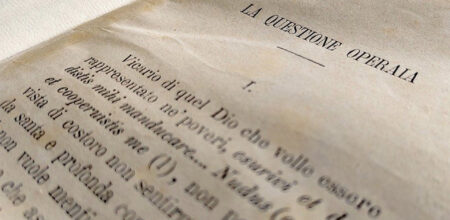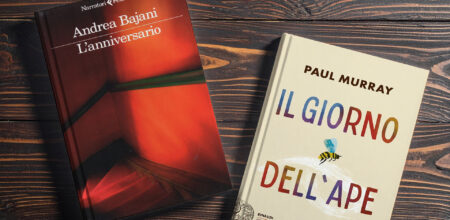|
|
Fin dalle prime pagine questo volume rivela l’ambizione di ricucire lo storico divorzio tra scienze della Terra, scienze sociali e tradizioni umanistiche. Il testo assume come proprio punto di partenza la «grande cecità» individuata da Amitav Ghosh, vale a dire l’incapacità della cultura contemporanea di percepire l’impatto dell’umanità sul «sistema-Terra». Muovendo da tale consapevolezza, i curatori orchestrano un mosaico disciplinare che, più che come un semplice affiancamento di saperi, si configura come un vero esercizio di ibridazione retorica, concettuale e metodologica.
Nella prima parte, l’ecologo Emilio Padoa Schioppa offre un quadro lucido delle prove stratigrafiche, biogeochimiche e climatiche che giustificano il ricorso alla categoria di Antropocene, discutendone la datazione convenzionale alla metà del Novecento e l’idea della «Grande accelerazione» come svolta irreversibile. In tal modo l’A. non solo fornisce dati, ma mostra come essi implichino un ripensamento etico-politico del rapporto fra umanità e geosfera.
Come contrappunto, il giurista Domenico Amirante scandaglia le narrazioni «catastrofista» ed «eco-modernista», evidenziandone aporie e punti di forza, e propone un modello di governance multilivello che non elimini, bensì trasfiguri, la dimensione democratica attraverso forme di coordinamento dell’azione ambientale locale con quella planetaria, restituendo così all’Antropocene la sua necessaria valenza istituzionale.
Nella seconda parte, si delinea una genealogia italiana della cli-fi e dell’ecocritica che parte da Italo Calvino: La speculazione edilizia e Il barone rampante vengono riletti come testi anticipatori di una critica al consumo di suolo e a un progresso disancorato dai limiti naturali. Da qui l’itinerario si prolunga fino alla contemporaneità della climate fiction, dove Arianna Mazzola individua la convivenza di distopia, thriller ecologico e narrazione epica, nell’intento di ridefinire il concetto stesso di «umano» sotto la pressione della crisi climatica. Giuseppe Langella indaga la dimensione emotiva della catastrofe; Francesco Sielo illumina la lezione bioetica di Primo Levi; Stefania Segatori mappa un filone di green poetry che, da Maria Grazia Calandrone ad Antonella Anedda, rende la natura soggetto di giudizio morale; e Niccolò Scaffai riflette sulla «profondità» come metafora e metodo di un immaginario in grado di intrecciare geologia, archeologia e psiche. Ciò che accomuna questi saggi è la convinzione che la letteratura non sia mero abbellimento del discorso ecologico, bensì laboratorio cognitivo dove si sperimentano forme di conoscenza capaci di mobilitare tanto l’intelletto quanto la sfera affettiva.
La terza parte sposta l’asse verso il diritto e la politica. Pasquale Viola conia il neologismo «nomocene» per indicare l’era in cui il diritto non si limita a regolare l’ambiente, ma diviene esso stesso fattore ecologico, insistendo sulla necessità di un diritto «multispecie» che superi l’antropocentrismo normativo. Luigi Colella ripercorre l’evoluzione del pensiero cattolico attraverso l’enciclica Laudato si’ di papa Francesco, mostrando come l’ecologia integrale abbia innervato il magistero recente; Gianfranco Pellegrino invita a non confondere la fascinazione narrativa con l’analisi empirica, riaffermando il primato dell’alfabetizzazione scientifica e della discussione pubblica informata; Carmine Petteruti esamina gli strumenti di democrazia deliberativa come argine al negazionismo climatico e come palestra di cittadinanza globale. Infine, Vincenzo Pepe propone un «ambientalismo realista» imperniato su transizione energetica digitale, rigenerazione territoriale e partecipazione civica.
Tra i meriti maggiori del volume spiccano la prospettiva multidisciplinare, la scelta di alternare voci consonanti e dissonanti e la chiarezza di un lessico che, pur specializzato, rimane accessibile a un vasto pubblico. Qualche limite si riscontra nella poca attenzione agli strumenti economico-finanziari della transizione (carbon price, incentivi verdi, finanza climatica). Nondimeno l’opera si impone come lettura imprescindibile per giuristi ambientali, comparatisti, ecocritici e policymakers, perché dimostra con chiarezza che «narrare» l’Antropocene non significa attenuare il rigore scientifico, bensì dotarlo di quelle forme simboliche capaci di convertire la conoscenza in responsabilità collettiva. In questa prova di equilibrio fra dati, diritto e narrazione risiede la forza teorica e la stringente attualità di un libro che contribuisce in modo sostanziale alla definizione di una cultura pubblica dell’Antropocene.