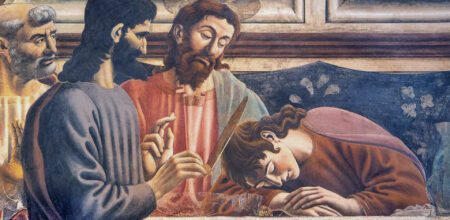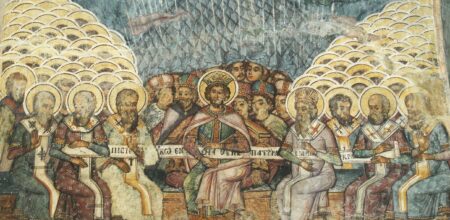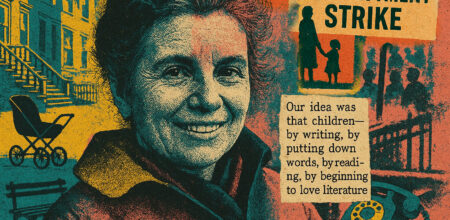|
|
Sullo scrittore e sceneggiatore anglo-americano Raymond Chandler (1888-1959), sulla sua carriera letteraria e con i registi di Hollywood che hanno tratto film da quasi tutti i suoi libri e, soprattutto, sul suo proto-detective hard-boiled, Philip Marlowe, sono state scritte montagne di saggi. Per buone ragioni, essendo stato, quello dell’A. – non meno del coevo Dashiell Hammett e del suo Sam Spade –, il contributo alla cultura americana di un intero universo immaginifico, un’influenza travalicante i generi del giallo e del crimine che continua ancora oggi.
La «signora del lago» del titolo svela quel tanto della trama che, per quanto è famoso il romanzo, ancora obbliga a pochi accenni. Marlowe viene assunto per trovare, appunto, una donna scomparsa, la moglie del suo cliente. A quanto pare, lei è fuggita in Messico con un bellimbusto di nome Chris Lavery, sulle cui tracce il detective si getta, ma che, al secondo incontro, trova morto ammazzato. Niente, naturalmente è come appare, e la pista iniziale porterà Marlowe da una grigia Los Angeles, che degli angeli eponimi ha ormai perso ogni battito d’ali, ai raccapriccianti accadimenti nei pressi di un remoto lago di montagna.
La prima persona di Marlowe sulla pagina è la soggettiva della macchina da presa, il film che si dipana nella nostra mente durante la lettura. In scena, troviamo la materialità greve delle cose, i portacenere stracolmi, l’alcool consumato a fiumi, i corpi impacciati da doppiopetti e fondine, le auto che sono direttrici fluide di ogni spostamento in una geografia reale appena dissimulata nei nomi dei luoghi. E non solo torbide vicende, la triade di sesso, denaro e potere, ma anche – come sempre in California, e ancora oggi – la contiguità di una natura selvatica, ostica e non meno protagonista chandleriana di quanto lo siano i paesaggi urbani: «Abbiamo raggiunto il lungo declivio a sud di San Dimas che, dopo la cresta, scende verso Pomona. Lì si è all’estremo confine della fascia nebbiosa, dove comincia quell’area semidesertica in cui al mattino il sole è lieve e secco come sherry invecchiato, a mezzogiorno è rovente come una fornace e la sera crolla come un mattone scagliato con rabbia» (p. 253).
Marlowe è, in fondo, un campione di sprezzatura: non è solo l’epitome dell’antieroe, ma un modello di maschio assai poco viriloide, quindi attualissimo, anche nella temperie culturale attuale. Forse l’unico americano a non portare armi, dubbioso («Magari va sempre così. Non è da molto che faccio questo mestiere», p. 126), egli opera spesso nel sottobosco ambiguo e anche un po’ sordido – tra il disprezzo dei poliziotti in uniforme e la loro disinvolta corruzione – delle indagini private; mette testa e inesorabile acume investigativo dove la tentazione altrui è invece quella di mettere rapidamente mano alla pistola. Ha a che fare con clienti che hanno molto da nascondere e da temere, bravacci, disperati, femmes fatales elusive e pericolose. Disarmato sempre, Marlowe, mai imbelle.
Non c’è vizio o nefandezza di cui il detective non porti cicatrice e da cui non abbia ricavato lezione. Egli conosce bene il legno storto dell’umanità, è naufrago con i naufraghi, si accompagna per mestiere e per destino a quelli di cui Thomas Elliott scriveva, most men live lives of quiet desperation. Ma lui non è affatto cinico o disperato, è piuttosto un romantico: dalla comprensione della natura umana emerge empatia, una complicità tra sommersi in un mondo in cui di salvati non è rimasta traccia.
L’icasticità proverbiale della scrittura di Chandler rivela la sua forza nella madre di tutte le scene, l’affiorare del cadavere della donna: «Ho visto della lana, fradicia e nera, un gilè di pelle più nero dell’inchiostro, dei pantaloni larghi […]. Ho visto un’onda di capelli biondo scuro che si spargevano nell’acqua e rimanevano per un attimo immobili, come in posa, per poi roteare e avvilupparsi di nuovo. […] E poi è stata la volta della faccia. Una massa bianco-grigiastra gonfia e senza forma, senza tratti riconoscibili, senza occhi, senza bocca. Un grumo di pasta grigia, un incubo con capelli umani» (p. 58).
In un mondo simile, la domanda del torvo poliziotto a Marlowe svela una dolente filosofia di vita: «“Fratello, come hai fatto a sopravvivere tanto a lungo?”. “Evitando di abboccare a troppi ami e di farmi spaventare troppo da certi duri di professione”» (p. 255).