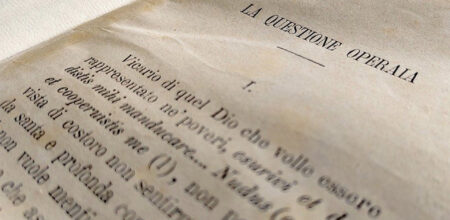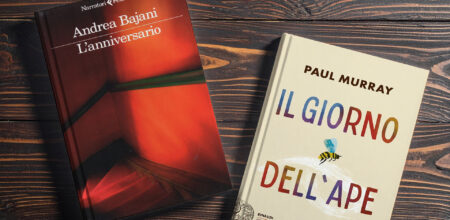|
|
Il volume è frutto di una ricerca sul tema della «corruzione», vista non solo dal punto di vista giuridico, economico e finanziario, ma soprattutto teologico e filosofico e in sinergia con un ampio progetto triennale che ha visto come protagonisti gli studenti del liceo «Euclide» di Cagliari.
Il gesuita Carlo Manunza conduce la sua indagine sulla «corruzione» partendo dal significato che propone il dizionario «Treccani», per poi entrare nell’ambito biblico, analizzando il contesto linguistico ebraico e greco. La corruzione ha un significato sia corporeo ed esistenziale, legato alla morte del corpo, sia economico: un «regalo […] offerto e ricevuto con fini ingiusti» (p. 18), un dono che diventa inevitabilmente un danno tanto per colui che lo riceve quanto per colui che lo fa. Come ha affermato papa Francesco, «la corruzione odora di putrefazione» (p. 23).
Gianmichele Marotta analizza il termine da un punto di vista più fenomenologico, illustrando la complessità di un sistema che, purtroppo, spesso viene messo a regime, come hanno mostrato le indagini di Mani pulite, che sono sfociate in Tangentopoli, fino a Mafia Capitale. Il presidente Sergio Mattarella descrive il fenomeno della corruzione come un «cancro […], un furto di democrazia. Crea sfiducia, inquina le istituzioni, altera ogni principio di equità, penalizza il sistema economico, allontana gli investitori e impedisce la valorizzazione dei talenti» (p. 41).
L’indagine, dunque, verte sulla misurabilità della corruzione, proponendo diversi indicatori e statistiche anche internazionali, che mostrano come essa non appartenga soltanto al nostro Paese, ma sia diffusa a livello globale. La ricerca si apre, in tal modo, alla questione se questo fenomeno antropologico, in quanto appartenente a tutte le società, sia un problema culturale e se possa avere strategie di cambiamento.
Giulio Parnofiello analizza il tema della corruzione ripercorrendo il pensiero di Jorge Mario Bergoglio, da quando era arcivescovo di Buenos Aires fino alla sua elezione al soglio pontificio. La Conferenza internazionale organizzata dal Pontificio Consiglio della Giustizia e della Pace nel 2006 ha mostrato come il tema della corruzione sia sempre sensibile, sia nei Paesi più ricchi sia in quelli più poveri. Ma anche la Chiesa non è esente dal pericolo di corruzione, come ha evidenziato papa Francesco, continuando con caparbietà la riforma finanziaria della Santa Sede già iniziata dal suo predecessore. Il tema della corruzione è presente nell’esortazione apostolica Evangelii gaudium e nell’enciclica Laudato si’, mentre più volte papa Francesco ne ha parlato nei discorsi, con tre immagini: come malattia dello spirito, come puzza e come cancro sociale.
Il testo, infine, illustra un esperimento, durato tre anni, in un liceo cagliaritano, che ha avuto come obiettivo un’educazione alla coscienza, partendo dalla Divina Commedia di Dante: tre tappe di un cammino che ha visto una crescita nel costruire un ambiente inclusivo, una coscienza politica orientata ai valori della solidarietà e un rispetto alle regole comuni per una reale possibilità di convivenza.
Il volume presenta una dettagliata analisi delle opere degli studenti, corredata di foto e immagini dei loro lavori. Un’appendice, a cura di Daniele Vinci, introduce il concetto recente della «semplessità», una crasi tra le parole «semplice» e «complesso», introdotto da Berthoz.
Questo testo presenta spunti teologici, filosofici, esperienziali, a partire dai quali è possibile pensare in maniera differente e da un punto di vista più creativo il problema della corruzione.