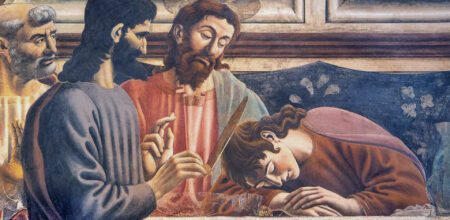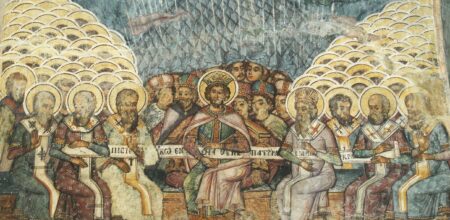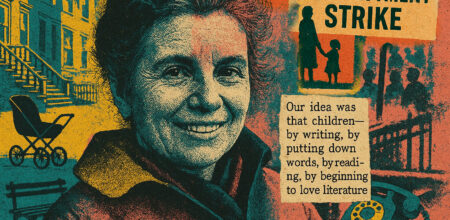|
|
Questo libro di Carlo Rinaldi, ingegnere e musicista con l’orecchio assoluto, invita l’uomo moderno a fermarsi, a leggersi dentro e a focalizzare la propria consapevolezza sul ruolo chiave che hanno ancora oggi le emozioni. L’A. si mette in discussione in prima persona ed entra in dialogo con un caleidoscopio di voci, di cuori e di anime che viaggiano in sintonia come in un’orchestra e nel loro agire danno valore alle antenne della propria sensibilità: Mario Calabresi, Andrea Pezzi, Marina Salamon, Pietro Trabucchi e molti altri.
Nella frenesia del vivere in cui siamo immersi, spesso non ci accorgiamo del miracolo che accade e si ripete in modo straordinario allorquando ci mettiamo in relazione con il mondo. L’intelligenza sensibile, la naturale evoluzione di quella «intelligenza emotiva» teorizzata da Daniel Goleman nel 1995, ci guida in questo affascinante processo, che sfugge alla nostra razionalità: «Possiamo progettare un algoritmo, prevedere ogni possibile interazione logica, ma non possiamo progettare l’amore né possiamo prevedere quegli incontri che ci cambiano l’esistenza» (p. 11).
La nostra vita in fondo non è una macchina perfetta e non possiamo sempre controllare o prevedere tutto, ma abbiamo due molle vitali che ci muovono: la curiosità e l’empatia, la risonanza verso il mondo. La curiosità, in particolare, ci apre alla conoscenza, che si genera grazie all’incontro con l’altro e spalanca il nostro sguardo, come sottolinea il monaco camaldolese Claudio Ubaldo Cortoni: «L’Alterità passa sempre attraverso una relazione. Non può esistere Dio se non esistono le relazioni. Ecco, io parto da questo presupposto: l’Alterità compare sempre e solo quando noi conosciamo le relazioni che ci sono nel mondo. Sono loro a dirci che c’è stato un qualcuno prima di noi che ha amato, qualcuno che ha preceduto il nostro amore» (p. 29).
La risonanza è un’epifania dell’infinito, che si rivela quando si entra in connessione con gli altri, ascoltando e vivendo pienamente il momento presente. Il rapporto con il prossimo colora di luce la nostra esistenza, è centrale nella nostra vita, e la sensibilità ci fa sentire parte di un disegno più grande: è un dono da coltivare come la risorsa più preziosa per creare connessioni. L’intelligenza artificiale, al contrario, presenta dei limiti, perché non possiede la sensibilità né è programmata per provare emozioni. Al di là delle etichette che la società ci impone, «la sensibilità è ciò che ci rende veramente umani, ci connette agli altri e ci ricorda che siamo parte di un tutto» (p. 95). La corrispondenza e la connessione emotiva che si innesca quando si entra in relazione con gli altri emanano una luce e un’armonia nuove, come due note musicali che, suonate insieme, generano una sinfonia inedita, che non è semplicemente frutto della loro somma, ma è un miracolo creativo unico e irripetibile.
L’intelligenza sensibile è un’intelligenza più profonda e si dipana in un percorso che si esprime in tre fasi: 1) essere sulla stessa frequenza; 2) generare energia e spazio per accogliere l’altro; 3) riuscire a creare connessioni, relazioni magari complicate, ma pur sempre belle, perché l’uomo è un animale sociale di aristotelica memoria. Nella società della performance, la vera linfa che ci nutrirà sarà l’intensità dei legami umani che sapremo costruire, àncora potente per sostenersi lungo il cammino della vita. La tecnologia e l’intelligenza artificiale sono solo strumenti che possono rivelarsi utili, ma potenzialmente pericolosi, e vanno gestiti con la giusta consapevolezza, sviluppando un pensiero critico che alimenti in noi la curiosità per porre le domande di senso, con fiducia nel futuro e responsabilità.
«Ciò che conta è come utilizziamo queste sfide tecnologiche per riflettere su noi stessi, sul nostro posto nel mondo e su come possiamo contribuire al benessere collettivo. La vera sfida è riscoprire e riaffermare l’importanza della nostra umanità, quella sensibilità unica che, una volta messa in risonanza con l’altro, può trasformare non solo i rapporti, ma l’intera esistenza. In fondo, la sensibilità trasformativa è l’invito a smettere di essere spettatori passivi per diventare protagonisti attivi della nostra realtà, in un continuo dialogo tra le nostre esperienze e quelle degli altri» (p. 105).