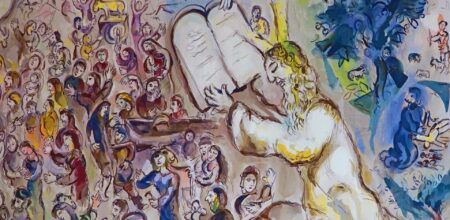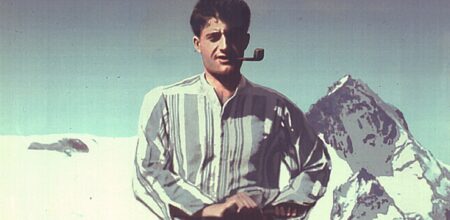|
|
Dopo Cuori fanatici (2019) e Desideri deviati. Amore e ragione (2020), opere narrative che ci erano sembrate tanto complesse quanto avvincenti, Edoardo Albinati conclude con questo romanzo la sua trilogia, che, ambientata negli anni Ottanta del secolo scorso, ruota intorno a due personaggi maschili: i giovani Nico Quell e Nanni Zingone, amici e coetanei, ma dal diverso carattere e dalle opposte inclinazioni. Il primo, figlio volubile e indolente di un ambasciatore, non è più nella condizione di rinviare il servizio militare e si trova dunque costretto ad attendere un anno, prima di iniziare a porre mano alla realizzazione dei suoi progetti. Il secondo, insegnante e poeta, ha avuto tre figlie dalla propria compagna – Costanza – e si sforza di evitare che questo legame vada in frantumi, trascinando nel naufragio la sua famiglia.
Nel corso di quello che è stato sovente definito il «decennio più edonista del Novecento», il narratore fa agire un’umanità varia e numericamente ragguardevole, formata da parenti, amici, colleghi e conoscenti dei due protagonisti, nonché da semplici passanti, ai quali viene dato spazio perché raccontino qualcosa sul proprio conto: ha così luogo una continua staffetta narrativa, nel cui ambito Nico e Nanni fanno la loro apparizione solo di tanto in tanto e quasi mai insieme. Il capitolo finale non farà che confermare questa alternanza.
Traboccante di personaggi, privo di una vera e propria trama, ricco di digressioni e citazioni, il romanzo si caratterizza inoltre per l’elevata qualità della prosa: scorrevole e incisiva, punteggiata da dialoghi calibrati ed essenziali, connotata dalla varietà dei registri espressivi, dalla musicalità dei periodi, dalla stratificazione del linguaggio, dalle ricorrenti coppie e terne aggettivali, la scrittura costituisce indubbiamente uno dei punti di forza di questo romanzo.
Va poi osservato come l’A. abbia deciso di non nominare esplicitamente l’Italia, che chiama sempre «lo Stivale», vede «immersa nelle sabbie mobili delle contraddizioni» e definisce «il benedetto Paese dello slancio e del calcolo, dell’euforia e della circospezione, della fede e dello scetticismo» (p. 18). Albinati ha anche scelto di omettere riferimenti palesi sia alle città in cui si muovono i suoi personaggi sia agli anni durante i quali si svolgono le vicende narrate: un proposito forse motivato dalla volontà di inserire la materia raccontata in un intero periodo storico, quasi a farne il simbolo di un’epoca, qualcosa insomma di peculiare e irripetibile al contempo.
Riguardo infine al titolo, occorre sottolineare come esso trovi la sua spiegazione in una battuta pronunciata da Costanza, la figura probabilmente più inquieta e disillusa del romanzo, che si esprime in questi termini: «Il fatto è che non mi sembra di esistere durevolmente, in modo continuativo, ma solo a sprazzi, a momenti. Come i lampi. Sento di essere una figlia dell’istante. Un battito di ciglia e potrei non esserci più» (p. 527). Uno stato d’animo palesemente condiviso anche da Nico Quell. Albinati narra appunto quegli attimi nei quali ci si rende conto di essere al mondo, si affronta l’imprevedibilità del vivere, si sceglie di andare avanti qualunque cosa accada. Lo scrittore riesce a coglierli restituendocene la vivacità, il fascino, l’imprevedibilità, e li pone al centro del suo romanzo, che diventa così un’opera destinata a raccontare la totalità del reale, di un intero universo i cui innumerevoli tratti vengono fissati sulla pagina e resi vividi grazie alla felicità della scrittura.
Si tratta certamente di una narrazione ambiziosa, che richiama alla mente imprese letterarie impavide e visionarie come quelle di Gadda e D’Arrigo, Pound e Musil, Döblin e Magris, Canetti e Thomas Mann. Ma I figli dell’istante ci convince e appassiona, dal momento che il suo periodare è trascinante, esatta la descrizione dei diversi contesti, inconfondibile il ritmo del suo racconto, pressante il suo invito a riflettere, preziosa l’emozione che sa trasmetterci.