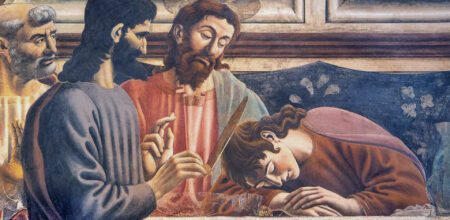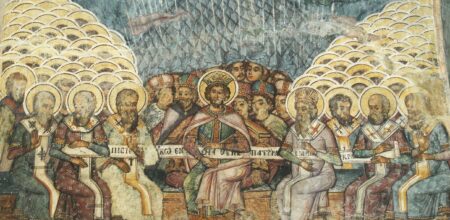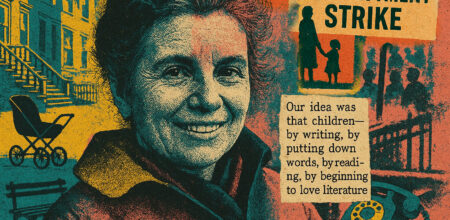|
|
Il libro di Leonardo Messinese si apre con un Prologo dal titolo «Filosofia contemporanea e metafisica». Dalle prime pagine, infatti, ci troviamo di fronte ai temi centrali che l’A. intende trattare: la filosofia contemporanea, il problematicismo, la metafisica. Mettendo insieme tali temi, bisognerà provare a pensare una «configurazione nuova di uno stile precedente». Questo vuol dire, da un lato, ripensare il pensiero italiano del Novecento e, dall’altro, lasciare emergere in maniera dialettica la duplice tendenza che l’A. presenta in questo contesto: quella problematicista, «dominante nella contemporaneità filosofica» (p. 12), e quella che, d’altra parte, affiora quale soluzione del problema, ossia il sapere metafisico.
In questo modo il libro si propone come una ricostruzione del percorso filosofico novecentesco italiano mediante una sorta di «racconto speculativo», che intende valorizzare in particolare due figure di rilievo del Novecento italiano: Gustavo Bontadini ed Emanuele Severino, il maestro e il suo allievo.
Il volume è suddiviso in cinque parti. Nella prima, possiamo osservare una disamina del rapporto tra metafisica e filosofia; più precisamente, tra metafisica classica, intesa come epistēmē, e filosofia. Quest’ultima è qui rappresentata, per così dire, nella sua eccedenza rispetto alla stessa epistēmē.
Assumendo la prospettiva di Bontadini – Messinese in questa prima parte utilizza come filo conduttore della narrazione uno scritto del 1950, dal titolo La mia prospettiva filosofica –, l’analisi si sofferma sulla filosofia moderna, sul valore che da essa può emergere e sulla capacità di reinterpretarla come compito e sfida, per restituire al sapere filosofico un significato forte e valorizzarne il senso logico e inferenziale. Questa riflessione riesce a intercettare esattamente l’insoddisfazione di un pensiero che ha rinunciato alla sua più profonda vocazione, quella di indagare l’essenza dell’essere.
D’altro canto, il problematicismo, osserva l’A., non costituisce semplicemente un modo generale della filosofia contemporanea, ma anche, per così dire, un modo particolare che segue quei filosofi che hanno teorizzato questa peculiare «figura» (p. 126). Alcuni pensatori qui descritti incarnano infatti, sotto questo aspetto, il problematicismo stesso. Da questa prospettiva si giunge così a introdurre, alla fine della seconda parte, la visione di Severino, soffermandosi in particolare sulla sua interpretazione del rapporto tra Heidegger e la metafisica.
Il discorso si svolge, in questo modo, come un racconto metafisico che si riapre costantemente intorno all’orizzonte dell’incontro tra il maestro e l’allievo. Ciò si fa particolarmente evidente nella terza parte del volume, in cui sono presentati, da una parte, gli elementi costitutivi della metafisica di Bontadini a partire dal concetto di esperienza e, dall’altra, la ricostruzione della metafisica classica di Severino, che segue alla strutturazione della metafisica neoclassica.
La disamina prosegue nella quarta parte, con la retractatio metaphysica di Severino, in cui possiamo di nuovo gettare uno sguardo sulla riflessione del maestro e dell’allievo, questa volta sul modo in cui le due prospettive si dividono. Infatti, il ritorno alla filosofia di Parmenide di Severino intende propriamente rappresentare una distruzione della metafisica classica. Per Bontadini, invece, si tratta di assumere il ripensamento della riflessione parmenidea quale conferma della metafisica stessa.
Nella parte finale, l’A. considera la nuova articolazione della riflessione filosofica di Bontadini, ponendo l’attenzione alla riformulazione di una «metafisica orginaria», in grado di delineare, come preannunciato nel Prologo, uno stile classico in una nuova configurazione.
In ultima analisi, sullo sfondo della discussione tra il maestro e l’allievo, la questione del problematicismo e della metafisica sembra articolarsi in una dialettica tra domanda e risposta. Se tale dialettica può svolgersi come «racconto speculativo», allora noi siamo sempre posti di fronte all’irrinunciabile esigenza del pensiero quale ricerca di senso. Per questo alla fine, osserva l’A. rievocando Kant, non va dimenticato che l’uomo è ente metafisico, prima che animale sociale e politico. La metafisica dunque possiede ancora in sé la forza di quelle domande che appartengono, dall’inizio alla fine, alla storia e al pensiero umano.